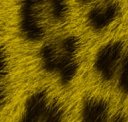|
INCONTRI CON PIPPO DELBONO
L’India che danza
Nuova versione 2009 - 36'
Sezione: Special events, Between Stage and Screen
Il film è stato girato nel 1993 quando Pippo Delbono sapeva di essere
ammalto di Aids da quattro anni. Decise di andare in India, arenare sulle
rive del Gange in cerca di una spiegazione alla parola morte.
KINEMATRIX Come nasce il film?
Pippo Delbono Il tentativo era quello di cercare di cogliere i
colori, l’amore, la bellezza. Pina Bausch nei suoi ultimi spettacoli usava
moltissimo il colore, scelta che le è stata anche contestata, si diceva
“Pina non è più quella di una volta”, probabilmente la verità è che quando
ti avvicini alla morte perdi delle remore intellettuali. In quelle zone
limite si vanno a cercare sentimenti come la gioia, sentimenti che un
intellettuale durante la sua vita rifugge, chi se ne frega della gioia!
Quando ti ritrovi sul letto di morte invece quella gioia la ricerchi, perdi
la retorica della mediazione con le cose. In questi momenti cerchi gli
altri, che in fondo è quello che fa anche il cinema. Io ho fatto per tanti
anni teatro e cinema per non morire, è chiaro per esempio in “Grido”. Lotti
per un dolore personale. Poi subentra un dolore che riguarda più la società,
stai male per qualcosa che non ti colpisce direttamente. Passi ad una fase
in cui non è più tutto concentrato su di te.
Cosa ci puoi dire rispetto alle musiche del film?
Quando uno fa un viaggio di questo tipo cerca di riportare un’esperienza ad
altre persone, e in questo senso la musica è fondamentale, per esprimere una
sensazione. La musica è una drammaturgia dell’anima. Una situazione non è
allegra o felice di per sé. Io posso guardare un cimitero ed essere felice,
la musica aiuta a dare un senso alle cose, ti aiuta a raccontare altro
rispetto a quello che sta succedendo.
Nel film si percepisce una grande e rispettosa religiosità…
Nel film ho ripreso in continuazione dei gesti rituali, delle preghiere. In
fondo in India la morte è vissuta con leggerezza, accompagnata da una
preghiera che non è fanatica. Purtroppo viviamo in una dimensione in cui la
religione cattolica ci ha schiacciato, ci ha tolto la gioia. Quando vai in
India o in altri paesi orientali non monoteisti, senti la coscienza profonda
che la morte convive con la vita. Nel fiume ti pulisci dove muori, ti lavi i
denti nell’acqua in cui c’è gente che sta morendo.
è un continuo riciclarsi. In
quel momento io avevo bisogno di sapere cosa si provava nel morire. Stavo
molto male, non avevo più difese immunitarie, mi bastava un’influenza per
crollare, e in più non avevo una lira e giravo con una telecamera
pesantissima, una super vhs, e cercavo proprio quella cosa lì, l'esperienza
della morte.
La stessa ricerca che si ritrova nello spettacolo “Questo buio feroce”.
In Birmania avevo trovato un libro di Harold Brodkey. In Birmania non c’è
assolutamente nulla. Nel golfo del Bengala, in un posto dove non c’era la
luce elettrica, non c’era niente, trovo su uno scaffale “Questo buio feroce”
di Harold Brodkey tradotto in italiano! Non l’ho più trovato in vita mia,
non è più tradotto
Ero in viaggio con una coppia di amici, io adoro i viaggi con le coppie
perché quando loro litigano tu puoi stare un po’ solo! Il mio amico mi
lancia questo libro e vedo che parla di un uomo che muore di Aids e gli dico
“Beh grazie, in vacanza…!”. L’ho letto, è un libro durissimo, però è strano
perché un uomo ateo raccontando la morte arriva a parlare di compassione, di
pace, arriva ad una dimensione mistica senza avere nessuna religione. Mi ha
colpito questo viaggio di un ateo, Brodkey, che arriva con lucidità a
parlare di fede. Infatti il mio spettacolo “Buio feroce” parte da lì. Parte
da un personaggio che guarda in faccia la propria morte. Cosa che noi non
facciamo, abbiamo alle spalle duemila anni di negazione di questa morte, la
morte fa paura. C’è un ricatto, il paradiso eterno in cambio del pentimento,
della colpa.
è il primo film che giravi
o avevi fatto qualcos’altro?
Ne avevo fatto uno prima, quando insegnavo alla scuola del Piccolo di
Milano.
Volevano che facessi un lavoro con gli allievi della scuola del Piccolo, una
scuola di teatro dove, dopo un mese di corso gli allievi si sentono già
arrivati, sono stati scelti tra non so quanti, ne vedono ottocento e ne
scelgono dieci, quei dieci, vi assicuro, sono insopportabili!
Il direttore voleva che facessi assolutamente uno spettacolo con loro, io
non sapevo nemmeno da dove cominciare e mi è venuta un’idea, faccio un
video, così vado sui particolari. E alla fine in effetti il direttore s’è
arrabbiato, non ci parliamo più! Riprendevo una mano, un piede, un occhio,
uno sguardo, non per cattiveria ma perché provavo a capire col cinema dove
potevo trovare della bellezza. C’è qualcosa di malato nella scuola, crea un
clima di competizione estrema, allora ho deciso di fare un video, per andare
a scavare in ognuno di loro. Il direttore non l’ha capito!
Locarno 10/08/2009
Guerra
Sezione: Special events, Between Stage and Screen
Il film è stato girato durante la turnè della compagnia di
Pippo Dlebono che nel 2003 portava in scena in Israele lo spettacolo
“Guerra”. Utilizzando le riprese fatte per le strade di Gerusalemme,
mescolando stralci dello stesso spettacolo teatrale, Delbono crea un tipo di
cinema innovativo, che cerca di cogliere la realtà attraverso una pluralità
di linguaggi ricca e profonda.
KINEMATRIX Che tipo di lavoro hai fatto sul suono e
sull’immagine?
Pippo Delbono Come dicevo ieri un film deve nascere da
una necessità, la forma non conta. La cosa importante è che in questo caso
sono andato con la mia compagnia in un posto di guerra. Avevamo una troupe,
piccola ma pur sempre una troupe che ha girato in digitale. E poi abbiamo
avuto la produzione della “H Film”, una casa di produzione di pubblicità.
Sembra strano, invece è stato importante soprattutto per il lavoro di
postproduzione, ci ha aiutato una persona molto brava. All’inizio avevo 95
ore di girato, non sapevo da dove cominciare, alla fine sono partito da
un’immagine. è stato
importante il lavoro sulla pasta dell’immagine, un po’ la specialità della
pubblicità. è stato un lavoro
molto diverso da quello sull’India o da “Paura”.
In che modo hai lavorato con la voce?
Io ho studiato per trent’anni la voce, non ho mai avuto un
rapporto interpretativo ma musicale con la voce. Ho avuto la fortuna di
avere all’Odin dei maestri che ti facevano incontrare delle voci profonde,
la voce come uno strumento. Abbiamo fatto per tanti anni teatro di strada, è
un’esperienza fondamentale, eravamo su questi palazzi senza microfoni, mi
ricordo una mia maestra che cantava e riempiva la piazza. Questo è
importante anche nel cinema perché usare la voce in modo interpretativo
significa sempre dare un giudizio morale.
Sembra che nel raccontare le cose in questo film tu abbia
usato un approccio quasi religioso, arcaico…
Penso che nel cinema come nel teatro ci sia uno scoprire dei
segreti. è difficile arrivare
in un luogo di conflitto come Israele ed è difficile parlare di un conflitto
come questo. La produttrice del film era ebrea ed era assolutamente pro
palestinese in ogni momento. Ci siamo trovati a fare un viaggio in cui il
vero conflitto era nell’autobus! Mi sono trovato a fare da mediatore tra chi
parteggiava per l’uno o per l’altra… Non nella mia compagnia, perché per
loro è diverso, io ho cercato di guardare questo film con gli occhi di Bobà,
lui ha uno sguardo diverso. La definizione di religioso è corretta nel senso
che ho vissuto la situazione con lo stomaco. A un certo punto la produttrice
era spaventata perché temeva che venisse una cosa troppo pro palestinese,
l’altra era preoccupata che venisse non abbastanza a favore dei palestinesi…
Un incubo! A un certo punto mi sono distaccato e ho deciso di seguire il mio
stomaco, non volevo seguire un pensiero. La cosa interessante è che non
volendo prendere le parti, il film anche a distanza di anni è sempre giusto.
Perché quando vai con lo stomaco, chiamiamolo religiosità, non cercando di
capire, finisce che racconti di più che se vuoi raccontare. A volte mi
succede che vedo uno spettacolo dopo tatni anni e lo capisco di più. Una
sera mentre noi facevamo lo spettacolo una bomba in una discoteca ha ucciso
25 persone. Quella sera in sala c’erano la metà di palestinesi e la metà di
israeliani. Alla fine dello spettacolo la gente si è alzata in piedi e
vedere questi omoni che piangevano è stata un’esperienza così forte a
livello teatrale che non potevo raccontarla. Allora l’ho dimenticata e ho
cercato di ritrovarla attraverso il cinema. Per raccontare qualcosa bisogna
dimenticare la testa e rientrarci da un’altra zona.
Che rapporto c’è invece con il corpo?
Il corpo è un fatto democratico. Viviamo in una società che
si basa sulla parola, se tu sei analfabeta come Bobà non abbiamo niente da
dirci. Artaud diceva: “ Io scrivo per gli analfabeti”. Pasolini diceva: “Io
faccio cinema, scrivo per quelli che non hanno fatto la quarta elementare”.
è una cosa straordinaria,
invece oggi la cultura la fai solo per quelli che conoscono. Il corpo è
stato dimenticato, viene solo esibito, l’estetica, il vestito determina chi
sei.
Locarno 10/08/2009 |