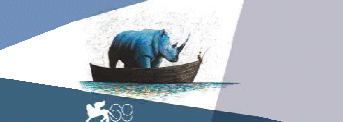|
mostra int. d'arte cinematografica 69.ma edizione
Lido di Venezia 29/8.08/9 2012
|
|
|
|
recensioni |
|
Tai Chi 0
Fuori Concorso |
|
|
|
|
|
23/30 |
|
Rice Spaghetti Western “For the past fifteen minutes, you've been droning on about names. Toby. Toby?” (Mr White, in LE IENE, 1992).
Senza averne piena consapevolezza, il regista di DJANGO UNCHAINED suggeriva una possibile via di fuga alla crisi del settore, ipotizzando la costruzione di fisicità tridimensionali, poiché over-spoken, super-citate, iper-raccontate, in grado di porsi come elementi strutturali di un edificio immaginifico che fosse parte costitutiva della memoria collettiva contemporanea ben oltre l’idea di star o diva/o. L’eroe trash, insomma, supera il momento della morte nel momento in cui viene, appunto, over-spoken, scolpito in un 3-D di termini e aggettivazioni e si candida a oltrepassare la limitatezza temporale rintracciabile, ad esempio, nella teoria immacolata dei vari Grace Kelly, Cary Grant, Henry Fonda o Jean Harlow. Anche grazie al Vhs, ai Dvd e al downloading, ovviamente. Provate a digitare “Jean Harlow” e vedrete quanti torrent vi verranno suggeriti: pochissimi.
Anno 2012: siamo ormai in pieno Manierismo di un’era che era già manieristica all’origine. Fucking Charlie Chan, di conseguenza, da personaggio di finzione si è trasformato in creatura vera in 3-D: esiste, “c’è”, esattamente come i characters stereotipati del quasi omonimo Jackie Chan, attore-icona come pochi, che vanta esordi per gli “Shaw Brothers Studios”, fondati nel 1924 dagli antenati di Stephen Fung. La madre dell’attore/modello/cantante/regista vi lavorava e l’autore di TAI CHI 0 vi è cresciuto a colpi di arti marziali. Il film presentato alla Mostra è niente di più (o meno) che il frutto di un citazionismo alla quarta ormai pronto a includere, risucchiandolo, tutto il Passato, sino alla vertigine in cui questo si fa Presente e Futuro. L’incertezza nominalistica di Mr. White (Toby?Toby Wong?Toby Chung?Charlie Chan?) condensava 20 anni fa esatti l’indefinitezza di questi eroi-corpi strappati alla morte per troppa definizione: Stephen Fung chi è ? Un attore o un cantante di mandopop ? Un regista dotato di una qualche poetica o uno strumento utilizzato da una macchina inarrestabile che centrifuga immagini cinordamericane? Chi è, poi, l’eroe dagli occhi di luce che campeggia al centro della storia, tra extreme jumps e spostamenti a mezz’aria che neanche ne LA TIGRE E IL DRAGONE? La sensazione è di trovarsi di fronte a un prodotto-cosa tridimensionale assolutamente compatto e illeggibile, come se fosse, e lo è, made in China. Silenzioso, inattaccabile, di qualità dubbia. Come Jackie Chan, Fung è passato dalla recitazione allo sfruttamento del brand in questione: qui è Tai Chi - in origine film uscito quest anno, ora già trasformatosi in prequel, cioè ZERO e, a breve scadenza, addirittura in sequel, TAI CHI HERO, previsto per la fine del 2012…). Si attendono il videogame e la serie-tv, da vere su Ipad possibilmente in metropolitana. Fung ha esordito sedicenne in Forbidden Nights (1990), inanellando poi successi in serie come teenage-icon senza tempo (Gen-X Cops e il sequel Gen-Y Cops, 1999, stesso anno di Gorgeous, con la magnifica Shu Qi, presente anche nel cast di TAI CHI 0), sino ai recenti The Heavenly Kings (2006), Heavenly Mission (2006), All About Women (2008), The Fantastic “Water Babes (2010), Virtual Recall (2010), Amazing (2012) e, appunto, il primo Taichi (2012). Del 1999 è anche l’esordio come solista, dopo una parentesi nella band “Dry”. Il buon Fung in versione regista passa dalla commedia romantica (Jump) allo steampunk-kung-fu di TAI CHI 0, lasciandoci l’interrogativo su dove e come si possano unire i punti e ottenere l’immagine complessiva (di una qualche poetica o idea di cinema). Forse negli studi di grafica portati a termine alla University of Michigan si possono/ devono rintracciare le origini di uno sguardo mobile e predisposto alla grafia dell’immagine anche quando statica o rallentata (Jump), per poi esplodere pienamente nell’assurda macchina cinetica del film veneziano. Fung Ku o Kung Fu: il genere definisce l’autore e/o viceversa, comunque. La storia vede il giovane guerriero Yang Luchan alle prese con l’apprendistato delle arti marziali proibite, il combattimento Tai Chi, in un villaggio sperduto attaccato (massimo del crossover manieristico) da un battaglione di guerrieri steampunk provenienti dallo United Kingdom. Sottotesto? Sottile induzione di tracce social-political? No. Presi a metà tra folli scene con 100 tagli di montaggio (minimo) e larghi tramonti distesi, ma infettati da un brillìo tecno-CGI che fa tanto poca vita reale e molto videogame, scegliamo di concentrarci sul viso di Shu Qi, che da sola metterebbe a sedere un plotone di steampunk-warriors solo a guardargli nel centro del mirino. Notevoli, in ogni caso, le scene acrobatiche, portate all’estremo e rese astratte, volatili, come forse mai prima (nemmeno CROUCHING TIGER poteva raggiungere queste tecno-vette). |
|
di Daniele Ciprì
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
28/30 |
|
Come si poteva facilmente prevedere, l'esordio “solista” di Daniele Ciprì è stato vittima di robuste incomprensioni. Tutti a fare paragoni con i suoi lavori in coppia con Franco Maresco, a giudicare è stato il figlio con quell'inopportuno metro. Eppure, già dalle primissime inquadrature, c'è un segnale chiarissimo relativo al filtro attraverso cui intendere il film: Alfredo Castro, l'attore cileno di Tony Manero e Post Mortem. Il nuovo film di Ciprì va infatti visto come fosse un film di Pablo Larrain: un resoconto puntuale e narrativamente arguto su una piaga storico/antropologica della propria nazione (guardata attraverso il consueto filtro metonimico siciliano), indagata dal punto di vista delle dinamiche libidinali che essa mette in gioco. Una famiglia siciliana a cui viene promesso dallo Stato un risarcimento dopo la morte accidentale/mafiosa della figlioletta, la dilazione del quale però crea una catena di eventi farseschi che si terminerà (ci viene detto proprio in apertura) con il padre ucciso dal figlio. La storia, raccontata come un unico lungo flashback da un enigmatico narratore che troviamo già nella prima scena in un ufficio postale, è puntellata di tocchi surreali e di parentesi sopra le righe. Intermezzi musical, perfino. Insomma: il film è una commedia e reca sulle sue pelle gli eccessi di tono tipici di quel genere. Quando però il flashback termina, il film vero e proprio, per così dire, comincia, e attraverso una geniale torsione narrativa ridefinisce retroattivamente quanto abbiamo appena visto come non una commedia, ma una meta-commedia, un film sulla commedia come aspetto quintessenziale del “carattere nazionale” (qualunque cosa esso sia). La commedia è infatti il luogo dell'innocenza generalizzata (naturalizzata) quale superamento/estremizzazione della Colpa tragica. E la piaga intrinsecamente italiana che Ciprì vuole che noi torniamo a guardare in faccia, è la tendenza a generalizzare qualunquisticamente l'innocenza estendendola a tutto e a tutti, solo per rimuovere l'intollerabile trauma che noi stessi in prima persona siamo innocenti – rimozione senza la quale risulterebbe insostenibile il primo e ultimo comandamento della nostra etica nazionale: una mano non deve sapere quella che l'altra fa. è stato il figlio è insomma un clamoroso sforzo terapeutico e illuministico (atteso da decenni nel nostro cinema nazionale, dopo che il thriller politico aveva gloriosamente dimostrato tutto ciò già negli anni Settanta) per restituire alla luce e alla consapevolezza quel nodo che stringe insieme commedia e tragedia, colpa e innocenza, un nodo la cui rimozione ha provocato a mo' di disfunzione collaterale una sorta di Colpa Infinita che attanaglia e immobilizza tutto e tutti. Una disfunzione di cui gli eccessi della commedia, percepibili non solo sulla pelle dei film ma anche sulla vita sociale tutta intera, sono solo il sintomo più visibile. È importante, insomma, che lungo tutto il film lo spettatore si imbarazzi per tutte le tirate grottesche di cui Ciprì fa sfoggio, e che subisca catarticamente il rovesciamento finale, che diagnostica con impressionante precisione le ragioni profonde e pressoché antropologiche di questo imbarazzo. |
|
stories we
tell
Giornate degli Autori |
|
|
|
24/30 |
|
Sarah, attrice di talento e attivista politica, scopre, dopo paziente scandaglio nell'archivio dei ricordi familiari, mostrato in un'implacabile docu-intervista al padre e ai fratelli, di essere figlia di un altro uomo, amante della madre prematuramente scomparsa, irrequieta interprete di teatro nel Canada di fine anni Settanta. Il fatto che questi sia anche produttore cinematografico indipendente, dove il padre è mesto attore ritiratosi dalle scene, rende subito fitta la trama d'incroci tra dimensione privata e facies pubblica della Polley, spianando la strada verso un outing non richiesto (“sono attrice, ma anche regista, grazie a un dna e un'educazione di rara ricchezza”). Ciò che intriga e insospettisce allo stesso tempo lo spettatore medio è l'alternanza pacatamente sfacciata di Super 8 familiari, pellicola fake intenta a mimare filmini d'epoca 1974/79 e primi piani degli intervistati. Le stories raccontate, letteralmente “balle” o comunque racconti fatti d'invenzione istantanea, perdono ogni verosimiglianza col procedere dell'investigazione, man mano che la rete informativa approntata dalla regista sembra avvolgerci, trattenendoci in una morsa di calibratissima noia. Se tale stratificazione di livelli alla lunga irrita per il modo scolastico con cui Polley si gioca le carte a disposizione - la stoica saggezza del padre, bravissimo ad incassare, ormai 70enne, l'indesiderata e prevedibilmente sconvolgente novità; il tono patetico nel ricordare la defunta; la qualità vintage dei memorabilia filmici - la figura della madre acquista, invece, uno spessore del tutto autonomo e indipendente dal progetto registico della figlia. Quanto più questa si concentra sul nuovo genitore, ripreso da vicino o vicinissimo mentre il voice over di Sarah non ci lascia tregua, tanto più noi svoltiamo verso l'unica vera storyteller , la madre, ovviamente. Un po' Marilyn gaudente e un po’ desperate housewife, Diane MacMillan Polley riuscì a costruirsi un percorso autonomo e, questo sì, indipendente rispetto agli sbagliatissimi mariti che andava sposando sovrapensiero. L'indugiare sulle figure maschili e il tratteggio veloce della figura femminile rischiano di rafforzare l'impressione di uno strisciante e innecessario giudizio a posteriori sulle scelte materne. STORIES WE TELL si posiziona in qualche modo tra il possibile remake nordamericano di UN'ORA SOLA TI VORREI, quindi senza un decimo della sintesi visiva di Alina Marazzi , e la declinazione digeribile del cinema di Nick Cassavetes. |
|
di Ramin Bahrani
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
27/30 |
|
Lo stile visivo di Rahmin Bahrani è tra i più millimetricamente precisi al mondo. Maestro, davvero, dell'azione pura, che ha finora brillato coerentemente in drammi ultraminimali (Goodbye Solo su tutti) meticolosamente costruiti e storyboardati, fa ora il passo più lungo della gamba affrontando un genere poco congeniale rispetto a queste premesse. Per quanto questo passo sia più lungo della gamba, Bahrani cade comunque in piedi e non si rompe niente, sia chiaro. Anche perché le ambizioni di partenza erano davvero alte: comporre, forte della distanza critica fornita dalle sue origini iraniane, IL romanzo americano contemporaneo, con le sue ben salde connessioni nel passato e soprattutto con l'atemporalità del Mito, già dalle sue origini ancestralmente viziato da una Colpa Infinita che il Dio Denaro non può che perpetrare di generazione in generazione. È proprio questo, infatti, che legherà il figlio un tempo ribelle (e aspirante pilota) al padre, coltivatore dell'Iowa obbligato a sottostare ai rischi immensi dell'imperativo "Expand or Die" che condiziona ormai, OGM o meno, tutta l'agricoltura contemporanea (almeno a quelle latitudini). Come il figlio interpretato da Zac Efron, Bahrani eccelle nell'azione pura: le corse automobilistiche a cui partecipa quel personaggio sono davvero magistralmente filmate. Analogamente, impressionano molto quelle scene dove l'enormità del pathos in gioco impone una decisa purificazione e rarefazione delle linee dell'azione (l'omicidio, la scoperta della colpevolezza del figlio da parte del padre etc.). Bahrami impressiona meno quando è costretto a rincorrere l'ispessimento di trama e personaggi – fermo restando un lodevole "occhio" per le sterminate colture dello Stato, tra quelli dell'Unione, rurale per eccellenza. In definitiva, un ottimo romanzo sull'America in crisi, anche se non spicca molto il volo (in originalità soprattutto) rispetto ai modelli nobili (il romanzo anni Trenta del New Deal) che evidentemente rincorre, e in funzione dei quali Bahrani mette a servizio il suo grande talento, al quale forse tarpa un po' le ali da solo. |
|
di Susanne Bier
Fuori Concorso |
|
|
|
|
|
24/30 |
|
After different melodramas, oscar-winner Susanne
Bier suprisingly comes out with a feel-good romantic-comedy about love,
sadness, jealousy, life and death. Set in beautiful Italy, spoken in english
and danish played by a well casted group of danish and english actors. When loveable hairdresse Ida (Tine Dyrholm) comes home from hospital, not knowing if she will be finally healthy after a breast cancer desease, she finds her husband Leif (Kim Bodnia) fucking on the couch with his acoountant Tilda (Christiane Schaumburg-muller). But there is no time for blaming or long discussion cause their daughter Astrid (Molly Blixt Egelind) is going to get married in Italy just after three months with her fiancee Patrick (Sebastian Jessen). On her way to Italy Ida accidentally meets Patrick’s father Philipp (Pierce Brosnam) a vegetable and fruit manager with a big built berrier caused by his wifes’ lost sorrounding him and a quite harsh tone. All of these characters gather in Philips’ summer house, where Leif suprisingly brings his affair and Patricks nearly bitchy aunt Benedikte (Paprika Stehen), showing lot of interest in Philipp. Funny situations, big love, breakups and a lot of tears are reprogrammed. Susanne Bier’s LOVE IS ALL YOU NEED is very reminiscint of the musical-comedy MAMMA MIA, keeping out the ABBA songs, but taking a young marriage as an event at a beautful sea and a charming Pirece Brosnan in the maincast. Instead of "Daning Queen", we are now faced with the again and again played Dean Martin classic "That's Amore", underlining the nearly too beautiful area and the over romantic atmosphere that leads us through the whole movie. Tine Dyrholm as Ida is without doubt one of the highlight in the cast, playing her role as brave and sweet Ida perfectly. In addition to that Paprika Steen asthe mean aunt, continiously stouching her daughter (Frederikke Thomassen) and hitting on Philip, is a real pleasure to watch. A new masterpiece by Susanne Bier shouldn’t be expected in this case, but a heart warming romatic comedy that will make you laugh and walk out of the cinema with a big smile. |
|
kuf
Settimana della Critica |
|
|
|
|
|
25/30 |
|
Rigido e statico come un’icona ortodossa,
Ercan Kesal interpreta il ferroviere Basri, addetto al controllo dei
binari in una desolata stazione dell’Anatolia. Istanbul è lontana, tenuta
fuoricampo. Il potere centrale, oppressivo e irrappresentabile, non agisce
direttamente sulle dinamiche private del protagonista, stretto tra familiari
tragedie ed epilessia. Seyfi,il figlio disperso a metà anni ’90 durante un
corteo antigovernativo, compare solo in forma di carta d’identità, ma
aleggia dall’inizio alla fine. Mummificato in questo universo tutto al maschile, Basri interagisce, a livello privato, solo con l’alcolista Cemil , minaccioso custode di un segreto comune che gli ispira continui ricatti, e con l’ispettore di polizia Murat, cui spetta il compito di rappresentare l’alterità pubblica, filtro freddo tra campagna e capitale. Il film scivola silenziosamente tra estenuanti trattative in commissariato per far continuare le ricerche del figlio e afona solitudine combattuta solo con una radiolina d’antan, improbabile residuo di un’arcaica modernità. Già acquistato dalla Sacher, assai incline a un cinema devitalizzato, KUF è però film da festival come pochi. Un po’ Guney e un po’ Anghelopulos, un po’ realismo simbolico e un po’ singulto sociopolitico, la pellicola si erge a esempio paradigmatico di un’estetica immobilista in base alla quale nulla deve succedere, ma non perché sia programmaticamente bandita la narrazione in favore di chissà quali accentazioni visive, bensì per la scelta discutibile di moltiplicare, lungo la durata infinita del film, l’ingombrante imago mortis del ferroviere quasi fosse - in assenza di eventi o sviluppi - l’unica materia di scandaglio voyeuristico da parte dello spettatore, che dovrebbe teoricamente farsi bastare la sua corporeità angusta e immota. Kesal è assolutamente espressivo nella fissità eterna di uno sguardo arcaicissimo, ma è anche evidente il tentativo di Ali Aydin, regista esordiente e subito premiato alla Mostra, di appendere KUF al solo gancio a disposizione. Non è un caso che l’unico scatto significativo stia nella fenomenale scena della morte di Cemil: mentre la carrozza out of focus avanza lentissimamente verso il corpo alcolico dell’altro ferroviere intento a verbalizzare l’ennesima minaccia verso l’anziano collega, lo sguardo di Basri, sempre fisso, si veste finalmente di tragica grandiosità, perché viene per una volta intelligentemente contrapposto all’affabulazione del condannato, mentre, nel resto del film, non fa che trovare eco scontate nella definizione degli interni - asettici, tristi, scoloriti- e del paesaggio (brullo, nemico, assolato). |
|
BAIT 3D
Fuori Concorso |
|
|
|
|
|
19/30 |
|
Supermarket
Supershark Nell’esperienza traumatizzante del 3D ciò che viene a mancare è la selezione delle immagini da parte dello spettatore, invalidata dai tempi e dalle modalità di fruizione. Il conoscere non passa più attraverso la visione, come volevano i surrealisti, ma si forma grazie a una percezione velocizzata in cui, per definizione, la convessità del pensiero rivolta verso l’universo concavo del muto - un secolo fa - viene ora ribaltata in convessità intrusiva delle immagini stesse. Combinando 3D e cinema di squali, protrusi per loro natura verso il pubblico-vittima, otteniamo una scultura in movimento che ci mangia gli spazi vitali e ci fa arretrare, progressivamente offesi e indifesi, verso lo schienale della nostra postazione di osservatori ormai meno che passivi. Sarebbe auspicabile, paradossalmente, un’evoluzione fisicamente estrema del 3D: lo schermo potrebbe arrivare sino a noi e, come in VIDEODROME, prenderci, ferirci, lasciandoci scolpiti e sanguinanti. Oggi come oggi, al contrario, un innocuo film come BAIT 3D non può che condurci lontano dai territori del cinema come esperienza sensoriale, traghettandoci verso ragionamenti marginali sui meccanismi produttivi. Innanzitutto occorre dire come l’immane sforzo compiuto per completare il “primo film d’azione australiano in 3D” (citazione dal press-kit) si concentri praticamente nei primi 10-15 minuti della pellicola, che hanno richiesto, ad occhio, un buon 40% delle risorse a disposizione. Con queste premesse, la sceneggiatura doveva essere necessariamente impostata in modo da prevedere un immediato crollo narrativo e una stasi sulla quale costruire, poi, il resto, con i pochi soldi rimasti. Dopo l’inizio sentimental-tragico-iperbolico, del tutto simile a un teenager-horror hollywoodiano, ma in grado, perlomeno, di caderci addosso come una bevanda frizzante, si sterza verso il thriller da supermercato e, nel giro di qualche minuto, verso il genere catastrofista, declinazione tsunamica, con qualche impaccio nella CGI dell’onda. In pratica lei ha perso il fratello, finito dentro lo squalo per colpa del fidanzato baywatcher distratto, e ora, terminato l’erasmus singaporiano da cui torna con nuovo boyfriend meticcio (la coproduzione comporta il solito cast misto), incrocia l’ex nel megastore dove questi finge di elaborare il macerante senso di colpa. Lo script non lascia respiro e mentre la cassa sta per essere rapinata arriva, mai così necessaria, l’onda anomala, che spalma edifici e film come un morbido e passivo philadelphia. Gli attori stanno, ora, arrampicati sugli scaffali del supermercato e sopravviveranno - non tutti - tirando la sceneggiatura come un elastico, nel tentativo disperato di arrivare all’ora e quaranta. Le dinamiche tra personaggi double-face fanno sì che rapinatori, padri ricattati, capufficio e teenagers debbano barcamenarsi tra il bene e il male per salvare la pelle, mentre l’animale pneumo-telecomandato (realizzato con una nuova sostanza detta “Festo”, adatta a simulare contrazioni muscolari assolutamente realistiche) gironzola tra gli scaffali. In pratica fa le vasche, letteralmente, in cerca di una preda e anche se l’acqua è sempre più alta, il film è stagnante e, verso il quarantesimo minuto, si arena definitivamente contro una coppia di idioti da protocollo bloccati con cagnetto nel parcheggio dell’edificio multipiano. L’animaletto, nell’unico minuto esilarante, tornerà letteralmente dall’aldilà su un pezzo di legno-zattera. BAIT 3D, in pratica, è tutto qua: concepito addirittura nel 2009, il progetto è definito, disegnato e limitato dai confini produttivi, al punto che ogni livello di realizzazione ha un sottotesto legato al budget e anche alle esigenze distributive. Quando stiamo appollaiati sui trespoli metallici del supermarket sopravvissuto allo tsunami, il meccanismo complessivo (narrazione e recitazione) si ferma: intuiamo, da lontanissimo eppure in maniera assolutamente chiara, l’impaccio degli autori nello sforzo titanico di dover scrivere dialoghi decenti mentre attorno a loro tutti si preoccupavano del 3D, dell’animale gonfiabile, dei problemi con l’acqua, delle lamentele degli attori lasciati a bagno dall’inizio alla fine, etc. Lo squalo, al traino del maremoto e dello tsunami, dovrebbe innescare chissà quali sottotesti sull’avidità umana, che sopravvive a ogni calamità e rivolta come un guanto la qualità etica dei personaggi così come ci vengono presentati all’inizio, ma tutto appare posticcio e mal gestito. Facilmente inseribile all’interno della categoria “catastrofico”, il film è una mezza catastrofe, filmata dalla mano di un ex-chitarrista della band australiana degli Hoodoo Gurus (Kimble Rendall, specializzatissimo, sì, ma solo in direzione di second units). Tornare al rock no, eh ? |
|
di Alex Schmidt
Fuori Concorso |
|
|
|
|
|
23/30 |
|
Tutto sbagliato, in questo
horror tedesco di infimo livello. Ed è così già dall'incipit, nel quale due
ragazzine scendono in una grotta, l'una racconta all'altra della maledizione
per cui da secoli una bambina è rinchiusa lì dentro senza poter uscire,
dopodiché entrambe vengono viste correre in superficie atterrite e sporche
di sangue. Un'ellissi ardita? Nulla in confronto a ciò che immediatamente
segue: le due ragazzine che si incontrano miracolosamente più di vent'anni
dopo, e decidono di tornare nell'isoletta baltica semideserta in cui vissero
da piccole quella strana avventura. Salterà fuori ben presto una terza
ragazzina ancor più misteriosa, nonché il coinvolgimento sanguinolento di un
consistente numero di abitanti del borgo. |
|
the cutoff man
Orizzonti |
|
|
|
|
|
26/30 |
Rivolta nuovamente verso orizzonti
nazionali dimenticati dalla precedente gestione, la Mostra veneziana torna a
occuparsi di quello che, forse venti o trent’anni fa, veniva definito
“cinema del terzo mondo”: terre arse, storie marginali, drammi privati,
povertà di mezzi.
|
|
di Henry-Alex Rubin
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
24/30 |
|
New media connects people all over the world in
new ways we did not foresee. They strangely also have the power to do the
very opposite: to disconnect. To make people feel more lonely and closed off
from (real) communication. The dangers of internet privacy, social
networking and online transactions are laid out in this movie through three
entangled storylines. Two boys pranking a fellow school mate, by making him believe he is chatting to a girl from another school. The situation gets out of hand after they encourage him to take a nude picture of himself. The photo gets spread around the school and the boy tries to commit suicide. The second storyline concerns the news reporter who is making a story about teenagers who are scouted to work for porn chat sites. She connects to an eighteen year old boy who lives at a house with other, even younger, boys and girls who also do cyber prostitution as a job under the care of one man who obviously takes a big share of the profits. She convinces him to make an anonymous statement. The report is a success. But as the FBI wants to arrest the man who is responsible, she needs to give up on her promise to keep his identity a secret, and loses his trust. The third storyline is about a couple who have grown apart since their baby boy died. When he is on a business trip, she pours out her heart in a chat room to a person who claims to be in a similar situation. The couple soon finds out that there they are victims of internet fraud as they find themselves in serious financial problems. They hire a detective who traces the culprit. The detective cannot make an arrest without sufficient evidence so they decide to pay the suspect a visit themselves. All the characters are connected in some way, and for the most part of the movie only the audience knows exactly how. This narrative structure finds its origin in literature, also the construction of the story has this quality. It also could have well been a good TV-series, since there are so many interesting main characters to focus on. The pacing of the movie is excellent, as tension is build up in compact, clearly lined out scenes with to-the-point dialogues. The actors are casted without any prejudice on their famousness, declares Rubin. Still we find some good names on the roll: Alexander Skarsgård, Mikael Nyqvist, Hope Davis, Frank Grillo, Jason Bateman, Max Thieriot… With some room left for a couple of aesthetically pleasing shots, this movie seems to find a perfect balance between suspense, emotional drama and a very contemporary subject. Also the choice of music is great. One could wonder if the movie holds up it’s strength after the basis on which the story evolves, the modern technology and software, expires. Rubin states: I don’t know, I think the emotions of the characters are timeless. |
|
SPRINGBREAKERS
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
30/30 |
|
Welcome to the new Surface Selena Gomez, Vanessa
Hudgens, Ashley Benson e Rachel Simon Korine, scollate temporaneamente
dall’universo-Disney, sono ragazzine appena approdate al college, ma già
desiderose di transitare verso dimensioni più aeree, mutuate dalla
contro-realtà dei videogame, di internet e dell’immarcescibile catodo.
Rapinano tarantinamente un ristorante per pagarsi le vacanze pre-estive,
dove vivranno the time of their lives. |
|
di Paul Thomas Anderson
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
26/30 |
|
Primo equivoco da chiarire:
The Master non è un
film su Scientology, né su alcuna altra setta religiosa. È invece, piuttosto
trasparentemente, un film sulla psicanalisi. Potremmo dire, addirittura, che
sia la controparte (pseudo)freudiana all'intrapresa (pseudo)marxiana che fu
Il petroliere. Dietro la storia di questo reduce di guerra sbandato che si
fa irretire da un omologo di L. Ron Hubbard e dalla sua setta proponentesi
nientemeno che il controllo sulle proprie emozioni, è pressoché tassativo
riconoscere, in ogni dettaglio, un trattamento psicanalitico in piena
regola, alla fine del quale il soggetto conquista la propria indipendenza
rispetto all'analista, e soprattutto impara a maneggiare il terribile dato
di fatto che il proprio desiderio, per quanto abissalmente animalesco possa
essere (si veda la connotazione ipersessuata di cui è oggetto il
protagonista), ha in realtà l'inconsistenza di un'ombra. Nel caso del
protagonista: il desiderio per l'altro sesso, che orienta ogni fibra della
sua vita, è in realtà il desiderio di una donna di sabbia. Il che ci conduce al secondo equivoco da chiarire: P. T. Anderson, fondamentalmente, non è un regista. Non è capace, in altre parole, di entrare nel flusso dell'azione e padroneggiarlo facendosene a propria volta padroneggiare. No: lui crede che a quell'ombra (quel fantoccio, quella figura di sabbia) che è il proprio desiderio si debba dare una rappresentazione davanti a sé, una consistenza monumentale. Ed eccolo, allora, a curare oltre il dovuto le proprie inquadrature, ad escogitare per ognuna di loro una maestosità figurativa che, semplicemente, contraddice l'assunto del racconto, perché è la dimostrazione flagrante che, a differenza del suo protagonista, Anderson non vuole abbandonare l'illusione che il fantasma che si tratta di rappresentare (o rappresentarsi) abbia una sua granitica consistenza. Vuole essere un Master, non riesce ad accettarne la futilità – sopra la quale, anzi, si accontenta di piazzare una pezza tramite la magniloquenza del 70 mm. In termini ulteriormente diversi: Anderson non riesce a trovare la misura per cui il proprio fantasma/desiderio non è né opaco né trasparente, ma ambo le cose insieme (l'esercizio che il santone-alla-Hubbard sottopone al proprio adepto è precisamente quello di oscillare ossessivamente tra una parete opaca e un vetro trasparente). Grandissimo lavoro con gli attori, certo (e Philip Seymour Hoffmann più di Joaquin Phoenix), ma anche qui, non si tratta che del tenero (per non dire patetico) attaccamento all'illusione che un Soggetto Individuale esista – la quale è precisamente l'illusione che la psicanalisi, se vuole davvero andare fino al fondo del proprio percorso, deve abbandonare. Anche perché, alla fine del suo percorso, la psicanalisi è obbligata ad incontrare la religione: cfr. ora e sempre Jacques Lacan e la sua “chose freudienne” così vicina alla The Cause del santone di questo film. E Anderson questo lo indovina, nel momento stesso in cui la religione diventa nel suo film la maschera evidente della psicanalisi. Il problema, al di là della perizia con cui Anderson mette in piedi la sua grandeur di cartapesta e dei sottotesti più o meno acuti con cui infarcisce la sua esile parabola (il ruolo centrale del Femminile in una dinamica a due che parrebbe solo maschile) è che non riesce a credere che il proprio desiderio sia dappertutto anziché di fronte ai suoi come ai nostri occhi, su un piedistallo. |
|
me too
Orizzonti |
|
|
|
16/30 |
|
No, not you (in retromarcia da Sokurov a Balabanov) Beniamino della critica cinematografica russa e padrone di casa a festival quali: “Windows to Europe”; “Molodoist I.F.F.” di Kiev; “Message to Mankind I.F.F.” e “Festival of Festivals” di San Pietroburgo; “Kinotavr F.F.” di Sochi; “Literature and Film F.F.” di Gatchina; “Zarechny F.F.” e “Stalker Human Rights” di Mosca, nonché abbonato a premi FIPRESCI, quando esce dai confini patri, saturi di verboso cecovismo di riporto e surrealtà tutta spiegata in un susseguirsi insopportabile di pacchiano simbolismo e rimandi metaforici, il figlio della perestrojka Aleksej Balabanov fallisce l’obbiettivo con precisione chirurgica. Il problema del regista del notevole “BROTHER” (1997) è che il supposto lirismo dei suoi lavori, intenti a rappresentare una Russia tirata come un elastico tra Storia e Trascendenza, non si stacca di un centimetro dall’osservazione e rappresentazione tautologica di un’umanità apatico-amorale osservata con benevola ma ottusa sym-pathèia mentre è impegnata in una fuga imperterrita dalle Città e protesa verso territori di ruralità ancestrale in cui ottenere risposte ai propri desideri di purificazione. In questo tragitto, però, il supposto lirismo si fa incomprensibile ironia, l’ironia s’inarca tra Tommaso Moro e Campanella, citati senza ritegno nel testo, e il film si sgancia da tutto, ridotto a un cumulo di macerie. Sostanzialmente alla ricerca del giudizio universale che assolva tutti, incluso se stesso, Balabanov si auto-incastra in uno schematismo metaforetico puerile da cui escono personaggi come “il Musicista”, “il Bandito” e “la Ragazza”, impegnati in un road-movie verso il “Campanile della Felicità” posto in territorio contaminato (pure su un’isola e in mezzo a un lago) dal quale verranno sparati solo coloro che non si sono macchiati di assassinii. Sappiamo, quindi, dall’inizio chi otterrà il salvacondotto verso l’eternità e la pellicola si riduce di conseguenza a inutile sequenza di idee filmiche abortite, durante la quale non accade nulla, mentre noi siamo costretti a subire dialoghi imbarazzanti e a registrare maldestre citazioni tarkovskijane (la Zona di STALKER, luogo di realizzazione di tutti i desideri). |
|
di Enzo D'alò Italia 2012, 78'
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
28/30 |
|
PINOCCHIO is the animated
highlight of the 69. Mostra International Film Festival in Venice,
premiering as a special opening of the ‘Giornate degli autori’ section.
Directed by the renown animation director Enzo D’Alo, PINOCCHIO is the long
expected truly Italian interpretation of the famous Collodi’s book. |
|
di Takeshi Kitano
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
29/30 |
|
Più compattamente rispetto al primo Outrage, Kitano continua in questa sua operazione che dietro le apparenze di "resa" al film di yakuza più tradizionale cela un inaudito spessore politico. Otomo, il personaggio di Kitano, tecnicamente era morto alla fine del primo episodio. E invece no – ci si dice: vi siete sbagliati, vi hanno riferito male, a me non mi hanno mai ucciso in carcere. Una volta uscito dal penitenziario, Otomo diventa la pedina-chiave con cui lo scafatissimo commissario di polizia Kataoka cerca di dividere, per imperare, i clan concorrenti dei Sanno e degli Hanabishi. Kataoka, però, non si rende veramente conto di con chi ha a che fare. La lotta tra i clan criminali ha una logica ferrea, e Kitano vi si sottomette impostando il suo film sul tranquillo svolgersi di questa logica. L'impiego della violenza è esso stesso violento – non perché ciò che si vede sullo schermo sia particolarmente efferato, bensì in quanto la sua collocazione rompe violentemente con la strategia per cui il gesto violento dovrebbe essere la periodica valvola di sfogo che renda più digeribile il fittissimo tessuto dei dialoghi. La sua collocazione è invece genialmente, spiazzantemente indifferente – la violenza non è che un automatismo (si veda la crudele esecuzione di uno dei personaggi per mano di una macchina lanciapalle da baseball), e non il contentino umano lasciato allo spettatore in cambio del suo assorbimento dentro i rigori di una logica disumana. Lo svilupparsi impassibile di questa logica, si diceva, è lasciata tranquillamente dipanare proprio in vista di quel punto in cui questa logica è destinata a incepparsi. Questo punto è Otomo/Kitano stesso, personaggio che non si vede quasi mai ed eppure è, cupamente e orgasmicamente, l'unico trionfatore. L'unico che non si abbassa ad imbastire strategie e che vive invece di sottrazione assoluta; un'entità che sarebbe pigro chiamare nichilista e che invece dobbiamo sforzarci di rintracciare dalle parti dell'Odradek kafkiano, un Odradek radicalizzato fino a diventare quel Bloom teorizzato dal collettivo Tiqqun. Otomo/Kitano è una particella priva di volontà propria che si lascia trasportare dalla corrente ma la fa esplodere e disgregare dal di dentro con la sua carica implosa e radicalmente negativa. È questo punto di indifferenza tra la vita e la morte in cui va a finire la personalità al limite estremo della propria affermazione/negazione, quello a cui dobbiamo attaccarci quale ultimo orizzonte possibile di resistenza all'interno della corruzione generalizzata in cui, oggi che si è ormai completamente realizzato l'esaurimento di ogni spinta socialmente propositiva, tutti ci troviamo ad essere. |
|
out of frame
Orizzonti / Cortometraggio |
|
|
|
30/Lode |
|
L’architettura della Grecia classica, fissata
nella struttura del tempio, voleva che al massimo di trasparenza dei
diaframmi (frame) esterni, cioè il perimetro colonnato, corrispondesse il
massimo livello di segretezza dell’immagine, custodita all’interno della
cella, ovvero quella del dio. Questi era rappresentato nella prosciugata
tridimensionalità delle statue, letteralmente out of frame, inattingibile e
fuori campo rispetto alla visione. Il breve film di Yorgos Zois, nella sua
desolata ricchezza priva di eikona (i cartelloni pubblicitari di Atene sono
mostrati nella nuda essenza del mero supporto, senza gigantografie e
pubblicità), è assolutamente indicativo dello stato di precarietà in cui
versano una nazione e la sua comunità artistica. La morte di Anghelopulos
all’inizio del 2012, tra l’altro, ha in un certo senso chiuso il cerchio di
speranza aperto con RICOSTRUZIONE DI UN DELITTO (1970), mettendo una pietra
tombale su quarant’anni di disperata ricerca identitaria di una comunità
stretta tra mega(lo)-Storia e miseria del Contemporaneo).La Grecia è
letteralmente implosa tra l’iperbole olimpica del 2004 e la crisi attuale,
incapace di uscire dalle dinamiche politico-economiche internazionali che ne
avevano già segnato la travagliatissima storia dal 1936 al ’74, e a tale
implosione è seguita analoga scomparsa della rappresentazione, da
Anghelopulos alle arti visive e all’architettura (si vedano anche i
padiglioni ellenici alle Biennali degli ultimi anni). OUT OF FRAME è il
perfetto compendio di BEYOND REFORM, l’opera di Diohandi esposta ai Giardini
nel 2011, dove un laconico e minimalista percorso sull’acqua conduceva sino
al taglio di luce sulla parete, da cui però svoltava immediatamente. La
cruda essenza scorticata dei cartelloni mostrati da Zois, con l’unico
sottofondo dei rumori ambientali metropolitani, vale più di cento
documentari o interviste e sta come epitaffio afono o grido trattenuto di
una cultura rattrappita nel silenzio, impossibilitata a verbalizzare o
formalizzare lo status quo. Spogliati del fardello d’immagini pubblicitarie
colpevoli di troppi incidenti d’auto, i billboard ateniesi –sormontati dalla
dicitura “Remedy”- sono lapidi raggelanti e si susseguono nella sequenza
pensata dal giovane regista (presente al Lido anche nel 2010 con “Casus
Belli”) quasi fossero la teoria cimiteriale destinata ad accogliere i resti
di una nazione. OUT OF FRAME ha vinto il premio “EFA awards” alla 69.ma Mostra del Cinema, garantendosi la partecipazione agli “European Film Awards” nella sua categoria. |
|
di Ibrahim El Batout
Orizzonti |
|
|
|
|
|
24/30 |
|
WINTER
OF DISCONTENT is the fourth feature film by the innovative and
revolutionary filmmaker Ibrahim El Batout. His successful career has strong
roots in the documentary genre, it addresses issues of human suffering,
displacement and social problems. This movie is no exception. Though the
story is fictional, the gravity of the scenes and the suffering portrayed
strike a chord. The shooting of WINTER OF DISCONTENT started just one day before Mubarak stepped down from power. Tahrir Square was the starting point of making the film. We know this setting will present itself in the storyline. The anticipation leading up to the massive protests which brought an end to the Mubarak regime reverberates throughout the film. As the future of Egypt after the revolution is still being written, one can question if this movie comes too soon to make any definitive statements about the events. WINTER OF DISCONTENT finds a solution by just portraying its character’s stories, in contrast to the historic events which are evoked by means of sounds in the distance and the suggestion of chaos erupting in the streets below. Only the revelation of images of Tahrir Square at the ending brings reality to the more theatrical approach of the film. Amr (Amr Waked) lives in a spacious apartment in Cairo. His computer station is prominent in the room, the windows on his screen shows colorful images from nature and the outside world. When he was first arrested two years before the events portrayed in the film, he was tortured by state security officer Adel (Salah Al Hanafy) and his men, then released without an explanation. His tension and fear is portrayed in the way he lives his solitary life, glancing out of his window and small balcony to the street below, which is for us, the viewer, just a brick wall. His mother, who used to live with him, died when he was held prisoner. His girlfriend Farah (Farah Youssef) is a well-known TV news presenter. They’ve grown apart. Everybody watches the foreign channels to hear about what’s happening in the country, while the TV station for which Farah works keeps silent about the protests for the sake of “not causing panic” and “keeping the public calm.” At one moment she decides to quit the lies and deception and records her own confession about what is really happening. She brings it over to Amr and asks him to upload it. He assures her it will take some time for them to find him, but he knows better. Soon they arrest him and raid his apartment for the illegal phone. Some more haunting scenes of torture follow and the story wraps up to its conclusion at Tahrir Square. The actors give a great performance, especially the officer who tortures his prisoners stands out. Also the cinematography is very well done, the sober spaces are filmed beautifully with a palette of wonderful colours. WINTER OF DISCONTENT tries to tell a great story with (presumably) a small budget and finds solutions that don’t compromise the strength of the movie. A well deserved choice for the Venice Film Festival line-up. |
|
BELLA ADDORMENTATA
di Marco Bellocchio
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
25/30 |
|
Quattro storie sul tema dell’eutanasia si
alternano sullo sfondo degli ultimi sei giorni di vita di Eluana Englaro nel
febbraio del 2009. Il filo principale è la vicenda di Uliano, senatore che deve votare la legge che Berlusconi in fretta e furia cercò di far passare proprio per la situazione generata dal caso Englaro. La sua coscienza lotta contro il volere del partito e contro le convinzioni della figlia, attivista del movimento per la vita. In bilico tra la vita e la morte anche le altre tre storie, una grande attrice ha sospeso la propria esistenza insieme a quella della figlia in stato vegetativo, Roberto fa da “guardiano” al fratello con problemi di instabilità mentale ed entrambi lottano per il diritto all’eutanasia, infine un medico assiste una tossicodipendente per evitare che la faccia finita. Il merito del film si trova indubbiamente nella riflessione politica ed in particolare nella ricostruzione dei drammatici giorni in cui l’Italia si trovò spaccata sul tema della morte assistita, un’Italia coraggiosa da un lato, un’Italia terrorizzata dall’altro, di fronte alla dignitosa determinazione di Beppino Englaro di portare a termine la volontà della figlia. Interessante il punto di vista di Marco Bellocchio sulla classe politica italiana, intorpidita nel buio delle sale consiliari e nei fumi della sauna parlamentare, potente scena della rilassatezza del pensiero politico: “Non c’è nel film il pregiudizio, il partito preso, certo non è un film imparziale, in arte credo l’imparzialità non esista, ma è sincero e per nulla ideologico. Ho le mie idee, ma il film non ne è il manifesto. Di questo sono convinto, aperto alla discussione (mi auguro che si discuta) e fiducioso in un pubblico non indifferente”. La conferma della potenza del tema trattato è arrivata con il lungo applauso alla proiezione al Festival di Venezia, più che per il valore artistico del film, proprio per l’importanza e per il coraggio di affrontare tematiche che in Italia sono talmente scomode da risultare censurabili. Il film si regge sulla storia del senatore e della figlia che va in pellegrinaggio davanti all’ospedale dove è ricoverata Eluana e dove in quei giorni si radunarono opposti pensieri. Gli altri personaggi, dal medico all’attrice, risultano invece deboli, la regia spinge su una simbologia pesante di stampo pirandelliano (basti pensare ai nomi di alcuni personaggi, Rossa, Pallido, Beffardi) che non aiuta a dare spessore alle loro vicende. Si esce dalla sala frastornati soprattutto dal rivedere immagini di telegiornali che la nostra coscienza ha velocemente rimosso, parole fuori luogo, parole grevi, svilenti, di politici che affondano il coltello della volgarità in un tema tanto, troppo intimo. |
|
kiss of the damned
Evento Speciale Fuori Concorso |
|
|
|
27/30 |
| KISS OF THE DAMNED si muove con discreta sicurezza tra opposti tematici del canone vampiristico, offrendo una declinazione del genere che incrocia abilmente tradizione e aggiornamento/revisione.Xan Cassavetes, partecipe per lignaggio di èlites culturali, descrive i travagli di un’énclave artistica facilmente riconducibile al cinema indipendente. Lo spunto di partenza, aporia o dilemma, è precisamente quello della doppia opzione contrapposta offerta a chi aspira al successo all’interno del sistema hollywoodiano: Studios, mera adulazione e conseguente deriva comportamentale da una parte o riconoscimento critico, indipendenza e cura della dimensione privata dall’altra. Paulo, sceneggiatore in crisi creativa, sceglie la seconda, che gli si presenta sotto forma di Djuna/Josephine De La Baume, vampira esotica, amorevole e monogama, lasciandosi iniziare durante un accoppiamento che sa già di scelta di vita. Mimi, più giovane sorella di lei, opta invece per la prima, abbracciando le convenzioni poligamiche delle starlette da gossip. Elemento esterno che fa intrusione nel corpo principale del testo (la coppia di vampiri, stretta in un ama et labora potenzialmente infinito ed eterno), Roxane Mesquida/Mimi, non a caso passata dalle parti di “Gossip Girl”, fa sesso con Milo Ventimiglia/Paulo, poi subito ravveduto e pentito, quindi offre una vergine sacrificale alla matura Xenia (Mouglalis, vampira altissima e roca), strappandola a una castità decennale. In precedenza Djuna si era sbarazzata dell’agente succhiasangue, convinto di poter indirizzare Paulo, finalmente ispirato dopo la mutazione, verso un cinema più commerciale. Più avanti toccherà alla domestica il compito di clean up the mess - dove the mess è Mim i- eliminando chi trama contro il simmetrico equilibrio della coppia. Per Cassavetes, insomma, i vampiri definiscono l’élite creativa delle arti e del cinema e, in quanto iniziati a una condizione di superiorità, generatrice del successo che ne consegue, possono decidere se fare di questo un uso corretto, tirandosi fuori dalla stretta mortale dei più abbietti tra gli umani (i produttori, gli adulatori etc) e uscendo letteralmente dal letale fascio di luce della ribalta mediatica, oppure optare per un’esposizione totale, che li brucerà. L’aggiornamento dei codici sta nella nuova declinazione della libertà sessuale tipica del vampiro: non siamo dalle parti del neo-conservatorismo di TWILIGHT, ma il nuovo rigore monogamico sa comunque di ritirata (anche dal genere di riferimento, volendo). La coppia lavora, attraversa spazi lividi, addirittura mangia e conclude la giornata facendo sesso pulito: se di revisione si tratta, questa sa di riflusso, con ironia residuale a pizzicare solo la coda del film. Alcuni passaggi teorizzanti, poi - il convivio durante il quale vengono serviti scuri sorbetti - sembrano la versione innocua di THE ADDICTION senza la potenza espressiva di Ferrara e non si fanno mancare nemmeno riferimenti agli updates del genere (il sangue sintetico di TRUE BLOOD). Il film è bello, sensuale quando la m.d.p. incrocia lo sguardo di Mesquida e si ferma su quel corpo opalescente, dolente o leggero altrove, ma sembra fermarsi e trattenere il respiro proprio quando dovrebbe affondare i colpi, evitando quindi di farsi arma politica rivolta contro le categorie cui sembra rivolgersi. Djuna e Paulo non potranno mai aspirare alla consapevolezza superiore di Lili Taylor in THE ADDICTION, perché questa si dà solo in presenza di contaminazione epidemica e morte, scontro fisico e ideologico, mentre Mimi, la Lindsay Lohan dei reietti incapace di agire seguendo dinamiche di gruppo, non potrebbe mai stare tra i dannati di NEAR DARK (Bigelow, 1987). Cassavetes calibra troppo il tiro, inquadrando i corpi con accuratezza anche laddove i primissimi piani sembrerebbero reclamare un uso più libero della m.d.p. Quando le si para davanti la nuova borghesia vampiresca, poi, che chiama composizioni simmetriche e campi medi, continua a privilegiare i close-up, lasciandoci solo intuire gli ambienti, dai quali Djuna e Paulo sembrano staccarsi, mentre ad essi aderiscono intimamente quasi fossero elementi d’arredo. Attentissima anche nel mostrarci la matrice pittorica dell’immagine - Magritte, più volte- e nel citare con precisione il padre (THE OPENING NIGHT), la figlia di John ci regala sussulti quando passa il testimone a Steve Hufsteter e Demdike Stare, responsabili della banda sonora, che contrappunta ostinatamente e senza pause il flusso narrativo, creando una sorta di doppio del film, impegnato a cucire tra loro innumerevoli rimandi a colonne sonore del passato: veri e propri furti dai Rammstein di LOST HIGHWAYS, dai film scores di Mike Patton, da SUSPIRIA, da altro Lynch e incursioni più trattenute nei territori del belcantismo nazionale. |
|
di Terrence Malich
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
30/Lode |
|
Prevedibilmente, dopo la sintesi cosmica
(Tree of Life) culminante nel
proprio trascendersi e negarsi nell'infinitamente piccolo di qualsiasi
istante epifanico ci sia dato di vivere, la scala doveva, per Malick,
giocoforza ridursi al minimale estremo. Un uomo che, in Francia, conosce una
russa con figlia a carico, se ne innamora, se la porta nel Midwest, la
lascia andare quando le scade il permesso di soggiorno, si mette con
un'altra ma poi sceglie di sposare la prima, fino a che lei lo tradisce e
come conseguenza torna nuovamente e definitivamente in Europa. Nessuna sintesi cosmica, dunque, che sollevi e trascenda la lacerazione che sembra attendere e presiedere a qualunque rapporto umano; c'è un prete tra i protagonisti, sì, ma non è che il sigillo del fatto, qui di evidenza davvero straordinaria, che la Grazia coincide con la Caduta. Che è anche la caduta dalla/della torre di Babele, visto che le solite, onnipresenti voci over parlano quattro lingue diverse lungo il film. La coincidenza fra Grazia e Caduta fa di To the Wonder il film rosselliniano della filmografia malickiana (scioccante vederlo nello stesso festival che ospita il nuovo restauro di Stromboli). La Terra non è più l'abbraccio totalizzante che si onora solo staccandosene attraverso ognuna di quelle fratture la cui successione chiamiamo Tempo, ma è un corpo ormai morto, trapassato, esaurito: abbondano, in To the Wonder, inquadrature dove si fa bella mostra non di qualche bel paesaggio fotogenico, ma delle devastazioni dell'inquinamento. A Malick, insomma, non interessa più (ammesso e non concesso che il punto fosse mai stato quello) esplorare il mondo sensibile quale sede della Rivelazione attraverso la Bellezza: il proposito della sua mobilissima cinepresa e dell'inaudita inventiva del suo montaggio, sinergicamente impegnati a rinnovare continuamente ai nostri occhi l'equivalenza luce = movimento, è quella di trovare continue epifanie sensibili rispetto alle quali che si faccia notare la bellezza oppure il suo contrario è rigorosamente indifferente. Proprio perché la Grazia, è la Caduta. Cadono continuamente, i personaggi, e non cessano di esperire il dato banale ma incontrovertibile che la passione sfuma, e svanisce. Il racconto letteralmente evapora, e la storia latita clamorosamente per larghissime frazioni del film. La separazione è un abisso che si sfiora sempre ma in cui non si cade mai, perché si viene continuamente travolti dall'inesauribile incanto dell'Esteriorità, che è come un soffio che, da sotto, ci impedisce di cadere trascinandoci anzi verso l'alto. Eppure non c'è nessuna trascendenza, nessun cielo da conquistare: il prete, Dio, non lo trova, e quello che sembra all'orizzonte una luce divina è (il protagonista ce lo dice chiaro e tondo) nient'altro che l'ombra della terra che si riflette sull'atmosfera. E se la Caduta è innanzitutto l'inarrestabile emorragia del Tempo, e se tra le prime immagini di To The Wonder ci sono le riprese mozzafiato della marea che piano piano si alza intorno al Mont St. Michel, l'ultima inquadratura ritrae quest'ultimo ormai diventato un'isola vera e propria. Il contravveleno del tempo che tutto travolge e distrugge (l'acqua che si alza) è l'insularità che resiste al Tempo stesso e da esso sboccia come immobile contromovimento. Ognuna delle innumerevoli epifanie sensoriali che scandiscono il film è un'isola che sopravvive al dilagare distruttivo del Tempo, solo sottomettendosi al quale è però possibile imbattersi nel miracolo di queste sopravvivenze che letteralmente fanno il contropelo al Tempo. |
|
Pietà
leone d'oro venezia 69 |
|
|
|
|
|
28/30 |
|
La scena centrale di Pietà è quella che, per l'appunto, lo divide in due parti simmetriche. Un usuraio che vede intromettersi nella sua vita una donna che dice di essere sua madre, la violenta per assicurarsi, costatandone la reazione, che sia davvero lei. È la scena-chiave perché il vecchio refrain antropologico della proibizione dell'incesto e la diabolica e nefasta circolazione del denaro si incontrano nel punto vuoto che entrambi sono: se il denaro è l'epitome di un legame sociale che si disgrega nel momento stesso in cui trova la sua estrinsecazione più tangibile (la circolazione del denaro, appunto), e se la proibizione dell'incesto è notoriamente il fondamento stesso del legame sociale (la circolazione dei membri di una famiglia al di fuori di essa), anche in quest'ultimo caso la disgregazione del legame sociale coincide con l'estrinsecazione della prova tangibile di esso (la prova della maternità della donna coincide con l'epitome assoluta della disgregazione del legame sociale). Attorno a questa geniale intuizione si struttura Pietà, storia di un usuraio che una donna che si spaccia (senza esserlo) per la madre getta per vendetta nello stesso inferno a cui egli sottopone i suoi clienti. "Che cos'è il denaro? L'origine e la fine di tutte le cose": queste parole, riferiteci chiaro e tondo dai personaggi, ci confermano che di origine si tratta innanzitutto nel film. Il solito vecchio topos melodrammatico dell'archetipo materno condannato all'inconsistenza perché schiacciato dalla vuotezza dell'Origine si intreccia con il flusso senza origine né fine del capitale (proprio perché esso è l'origine e la fine di ogni altra cosa, esso non ha né l'una né l'altra). E se non ha né origine né fine, vano è ogni tentativo di regolarne il capriccio: chi se ne illude, cade vittima di esso, e da carnefice diventa vittima, perché di questo flusso si può, in ultima analisi, essere solo vittime. La scena dello pseudo-incesto segna precisamente il punto in cui l'usuraio si ribalta in vittima e il film si riavvolge su se stesso facendo passare a lui quello che lui prima infliggeva agli altri. Più precisamente: ciò che la pseudo-madre gli infligge è una "catarsi per empatia" in cui vede tutto il male che ha fatto, e in cui non c'è nulla di sentimentale, essendo tutto ciò piuttosto il sigillo del nostro essere tutti condannati a seguire, e mai a precedere, il flusso del Nulla, che si chiami "Denaro" o "Vita" o "Desiderio". E le scintille che si liberano in contropelo da questo Nulla, col quale non possiamo mai buddhisticamente coincidere (la grandezza di Kim sta nel riconoscere questo), sono le accensioni visive le cui rime interne forniscono la "resistenza", proprio nel senso fisico/meccanico del termine, di un movimento altrimenti di spietata fluidità. Anche per via di queste increspature, che ci ricordano che non siamo fatti della stessa materia onni-omologante del Denaro, Pietà è una ricognizione sul tema più attuale al mondo oggi (il Debito Universale) di devastante esattezza politica. |
|
la sala
Orizzonti / Cortometraggio |
|
|
|
20/30 |
|
Prodotto dall'“Agenzia per la lotta non repressiva” del
Comune di Bari in collaborazione con l'Apulia Film Commission, il
cortometraggio LA SALA è stato scritto da dodici detenuti della sezione B
della casa Circondariale di Bari coinvolti nel progetto "Voci e suoni
oltre il muro", promosso dalla Biblioteca Nazionale "Sagarriga
Visconti Volpi" di Bari. Il laboratorio di lettura, condotto da Alessio
Giannone, è partito dall'analisi del racconto di Giancarlo Sperti "La
vita sospesa" e si è sviluppato attraverso la domanda “in quale luogo
o circostanza vi sentite bloccati nelle vostre azioni o nell’esprimere le
vostre opinioni?”, cui i detenuti hanno risposto indicando “la sala”,
ovvero il luogo-circostanza della messa in scena collettiva di comportamenti
sociali basati su mere convenzioni. La specifica occasione narrativa scelta
da Giannone e dai suoi sceneggiatori/autori è quella del pranzo di
matrimonio, durante il quale si svelano i sottotesti di un universo borghese
impegnato in un’attenta opera di mistificazione e nascondimento delle
dinamiche private, tra debiti e ricatti, tradimenti e vendette. |
|
di Jazmin Lopez
Orizzonti |
|
|
|
|
|
22/30 |
|
Telling the story of Jazmin Lopez’ film LEONES
is done quite fast: Five young friends wonder through a beautiful and never
ending forrest, searching for a mysterious house. While walking we see them
talking and playing around untill the viewer slowly begins to realize that
what we see, might not be real and that a radical event, confronting the
teenagers with life and death, has already happened. Jazim Lopez tells a story about life and death, like she says: „an essay about death from the point of view of a mortal“ Therby death should be seen „as a beautiful landscape“, in this case the forrest, the flowers and at last the beach and the sea we are following the characters through. Looking at the films’ idea, the actors , the well done sounddesign and the dreamlike setting, Lopez’ film could have become an extraordinary and never seen movie. Especially the camera work of Matis Mesea, who was also responsable for Gus van Sant’s GERRY and ELEPHANT, leads us smoothly and very intimate with the characters through the movie. „ Their purpose is an empty pursuit of arriving nowhere“, Lopez says about the teenagers and this is probaly the biggest problem of the film. Following our characters (mainly the main character Isa), the viewer - really willing to follow Lopez intention of a 8 minutes walking, beach scene without any happening- simply gets bored. As Isa seems to walk an endless way through a flower field and suddenly says „This fucking place“, her comment arouses clapping hands and a lot of laughter, speaking out of the audience hearts. That, in general, movies without much speaking but lot of walking and silent obversation can also create a special atmosphere and never feel boring, Roberto Minervini. has shown with his movie LOW TIDE, also screened at the Venice Film Festival this year. One oft he strongest moments surely is the teenagers playing volleyball in beautiful slow motionn at a lake- just without a ball. With some of these nice scenes, admittedly, LEONES is probably one oft he most unusual films in the Festival and I have to confess that, although, being bored quite often at the screening, the movie is still on mind. |
|
acciaio
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
23/30 |
|
Badlands Prima della necessaria parentesi delle superiori, due amiche adolescenti e il fratello di una di loro, operaio circa ventenne tirato dall’elastico della ex Vittoria Puccini verso un passato prossimo gloriosamente innocente e felice, si trascinano verso futuri di parallele disperazioni. Acciaio e morte, senza prospettive, senza l’affabulazione solidaristica di un Leigh, ma con l’aria malsana e statica di BADLANDS (1973, Malick). Un po’ come in KUF, il moloch metallico della fabbrica o della ferrovia prima o poi ti schiaccia, rendendo preciso e completo il diagramma di sfruttamento dei corpi messo in moto dal vecchio capitale, quello che ancora aveva bisogno della vecchia carne degli operai, che si passavano il posto di lavoro di padre in figlio, per esistere. Piombino era il teatro di questo continuo passaggio del testimone, sino a prima del terzo millennio, epoca di identità svuotate del corpo, ma egualmente alla deriva. Tentare di raccontare la disperazione con la sordina e per interposto romanzo - PROVINCIA MECCANICA, sempre di Mordini, era film più urlato - è un’impresa. Dovresti lavorare di sottrazione (un non-futuro, un non-ancora presente, un non-luogo etc) e finisci per ritrovarti in mano poco o nulla. I dialoghi giustamente latitano, i personaggi sono correttamente solo abbozzati, bloccati come crisalide in un non-stato o mera condizione di transizione, e lo sfondo, costretto a farsi film seppur privo di punti d’appoggio, esce dalla cornice nel tentativo di riempire lo spazio così lasciato libero. PROVINCIA METALLICA, il film di Mordini, ha una sua qualità malata che cresce non tanto in ragione del quasi-romanzo di formazione (sessuale) di cui sono involontarie protagoniste le due adolescenti, ma proprio grazie a certi sguardi trasversali lanciati verso il paesaggio - o da esso verso chi lo guarda - spento tra ocra serale e grigi notturni, mentre i giovani corpi vanno verso il loro silente destino di residualità fin de siècle. Il problema è che il libro di Silvia Avallone (Rizzoli) si costruiva con buona intelligenza proprio sull’uso studiato del lessico post-famigliare di un tessuto sociale fatto a brandelli dai prodromi della crisi. La neolingua avalloniana, recuperata per strada e sciacquata non in Arno, ma nell’acciaio fuso della fabbrica, era l’ubiquo monolito grezzo su cui poggiava costantemente il romanzo. Tolto quello, è plausibile che rimanga poco. |
|
di Manoel de Oliveira
Fuori Concorso |
|
|
|
|
|
30/30 |
|
Questo è forse il punto estremo di quel meta-teatro che costituisce da sempre uno dei più appassionanti filoni della filmografia di Oliveira. Un meta-teatro di chiara ascendenza dreyeriana – e mai come in questo caso, forse, Oliveira è stato vicino al maestro danese (a Gertrud, soprattutto). Il testo di partenza, Il gobbo e la sua ombra di Raul Brandao, racconta di un povero e vecchio contabile che vive con la moglie e la nuora in una misera casupola, aspettando il ritorno del figlio scomparso anni prima per cercare miglior fortuna. Il suo primo pensiero è: nascondere ogni dolore alla moglie che ha già sofferto tanto per il figlio. Arriverà persino ad incolparsi del furto che quest'ultimo ha commesso. De Oliveira non stacca quasi mai la sua macchina da presa dalla cameretta in cui i miserabili personaggi vivono. Le poche volte che lo fa, lo fa con tagli di montaggio lordi di conseguenze come macigni, la cui funzione è esplorare quanto sta "là fuori" (il fuoricampo, in senso lato) in tutta la sua vana inconsistenza. Concentra la sua impassibile cinepresa sui lunghi dialoghi disperati del vecchio contabile e di chi gli sta intorno, ne corteggia l'impietosa immanenza ("7+7=14+7=21" mormora continuamente l'infelice padre) fino a una sottile inquietudine che solo alla fine esatta del film, con l'autocolpevolizzarsi del genitore innocente, riusciamo a qualificare. Essa è, infatti, l'altro lato di quell'immanenza, quella trascendenza intrinseca al qui-e-ora a cui viene data la forma della monumentalità, quel fuoricampo che dobbiamo sentire invischiato a ciò che è in campo, così come la scrupolosa osservazione della legge dobbiamo riconoscerla come qualcosa che è in sé fuorilegge, così come ogni istante del tempo dobbiamo riconoscerlo come la fine. Null'altro che questo è il cinema: torsione, avvitamento estremo e redenzione del legame tra campo e fuoricampo a cui presiede il teatro. Un gioco eminentemente cristiano, nel momento in cui l'avvento del Figlio (il fuoricampo) non è nulla se non è accompagnato dalla dannazione del Padre (ciò che sta in campo). Questo quieto furore anarchico è già tutto nella primissima scena, quella in cui il figlio è intravisto nell'ombra compiere un gesto che c'è troppa poca luce per riconoscere che l'abbia davvero compiuto lui o meno. Un gesto strutturalmente dispossessato, senza soggetto. La disperazione dell'immanenza senza scampo del qui-ed-ora, una speranza ce l'ha: non nell'avvento redentore di un (inconsistente) fuoricampo "divino", ma nella dispossessione di quanto facciamo, agiamo e patiamo quaggiù, dentro il "campo" terreno. |
|
di Jonathan Demme
Fuori Concorso |
|
|
|
|
|
26/30 |
|
The documentary
Enzo Avitabile Music Life is
screened alongside of the official competition of the 69 th Venice Film
Festival. Jonathan Demme, Oscar-winning director (The
Silence of the Lambs, Philadelphia) did a fascinating documentary on
Enzo Avitabile, the famous musician from Naples.
The
multi-instrumentalist composer's love for music is rooted in his fascination
for rhythm. His first great example was James Brown. Now he listens to
Pergolesi's Stabat Mater every day. The documentary shows how the musician
is on a constant creative quest. "There are several musicians in each
musician" Enzo's motto. |
|
di Ulrich Seidl
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
25/30 |
|
Secondo capitolo (dopo
Paradies: Liebe) di una
trilogia, Glaube
convince meno del già traballante primo episodio.
Protagonista è un'infermiera austriaca cattolica praticante – anzi:
discretamente invasata. Riempie la casa di crocifissi e immagini sacre, la
abita attenendosi con scrupolo a numerosi rituali di preghiera più o meno
ortodossi (fustigazione compresa), e ogni tanto parte con la statua della
madonna sottobraccio per andare a convertire qualche immigrato infedele a
caso. Rincasando una sera, però, trova l'ex compagno – musulmano e disabile
– deciso a stabilirsi da lei. La convivenza diventa alquanto problematica. |
|
LUISA NO ESTà EN CASA
Orizzonti / Cortometraggio |
|
|
|
29/30 |
| Delicato tratteggio di un universo privato terminale, LUISA NO ESTà EN CASA descrive la breve parabola esistenziale di un’anziana moglie spagnola tesa tra mesto appiattimento sui residui doveri coniugali e riscatto personale. In una generica città spagnola tenuta fuori campo dalla crisi globale, Luisa rifiuta la miseria emotiva di uno schema a due (devota e sottomessa lei, rabbioso e solitario il marito, casalingo e tv-dipendente) appena le si presenta l’occasione di romperlo e aprirlo a nuove dinamiche. La lavatrice si rompe e l’universo del laundry collettivo, tutto chiacchiera e affabulazione al femminile, ma anche solidarietà trasversale incurante dell’anagrafe, si dispiega davanti alla donna, che rinasce a nuova vita. Arriverà l’elettrodomestico aggiustato, ma Luisa saprà isolarsi creando un muro sonoro contro il marito, vincendo la sua battaglia per la nuova indipendenza. La Clavellino usa bene i pochi mezzi a disposizione e sistema la m.d.p. fissa a inquadrare il bagno, centro narrativo e punto di partenza per lo sviluppo dei micro-eventi. Lo stacco avviene quando, appunto, la medesima inquadratura mostra la parete-tecnica ora vuota e senza lavatrice. Intuiamo che quel vuoto lascerà spazio a un pieno e, con precisione, la regista prosegue il suo racconto staccando sui visi dell’anziana e di una nuova amica impegnate in un dialogo serrato. Assolutamente espressiva la protagonista, tutta rughe e minimalismo gestuale, coniugati alla decisione e sicurezza delle donne aggrappate alla vita con gioia resistenziale. |
|
di Ramin Bahrani
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
24/30 |
|
Ramin Bahrani’s drama AT ANY PRICE is a quite
conventional but well done drama dealing with the problems of fledding,
generation gaps and economical problems in a changing world of old
traditions. Set in the Iowa country, Bahrani tells the story of Henry Whiple (outstanding DENNIS QUAID), a typical represantative of a proud and optimistic familly father, selling modified seeds and trying to keep his clients when new rival Jim (CLANCY BROWN) and his ambitious son (BEN MARTEN) are taking over his long-time clients. Focussing on his work, Henry forgets about his second son Dean (ZAC EFRON) and even his warm-hearted and caring wife, on whom he cheats with the former cheerleader Meredith (HEATHER GRAHAM) who never managed to escape from the solitude. After recognizing that his first son is probably never coming back from travelling around the world, he wants the unwilling and rebellious Dean – who is more into car racing and fooling around with his young girlfriend (upcoming and sweet actress MAIKA MONROE) - to take over the business, as he did from his harsh and demanding father (RED WEST). Things start to get out of control when all of these different people’s expectations differ and the relationships are heading for an unpredicted crash where every character has to decide how far he would go protecting business and family. „People are dancing on graves. And these graves are us“, Bahrani said in an interview. Inspired by the European financial crisis and the fact how agressive people can become trying to defend what their business and families, Bahrani and co-writer Elizabeth Newtons raise questions about morality and unfilled expectations, well shown in the father and son relationships of Henry and Dean, Henry and his father and even of Jim and his son, especially in the showdown in the end. These complex topics need complex characters to fullfill the expectations. Presentating some kind of weird American Dream, Henry turns out to be a very ambigious character, getting sympathie for his effort trying to keep the business and even more dislike for the cheating on his wife , cheating in business and his ignorance to his family. ‘‘I mean, the man is guilty, cheating on his wife, and they’re standing arm-in-arm. „ says Bahrani about Henrys character. This is just awesomly done by DENNIS QUAID, who never struggles presenting a proud and happy family father on the surface and a broken, guilty man inside. Always having the fealing that anything could happen between the characters we follow them through the whole film, which sometimes- this should be said- can be comared to a modern soap opera. But nevertheless, Bahrani leads us adroit through his drama even if the end turn out to be a quite open one. |
|
di Brillante Mendoza
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
27/30 |
|
Brillante Mendoza continua con la sua post-neo-realista presa semidiretta digitale sul reale, con la sua cinepresa attentissima al tessuto sensoriale visivo e sonoro che permea un dato ambiente (qui: la provincia delle Filippine meridionali di Tawi-tawi, di orientamento religioso islamico), e che si dà sostanzialmente come conflitto senza esclusione di colpi (ma fertilissimo) tra la Narrazione e la Descrizione. Sempre più consapevole di quello che fa, Mendoza iscrive allegoricamente le intenzioni estetiche del suo progetto all'interno delle sue coordinate immediate. Alla storia di un'anziana levatrice sterile che cerca la moglie per un marito che non riesce a vedere senza figli, si accompagna infatti il leitmotiv di un tappeto che va tessendosi passo passo, fino all'avvenuto prodotto finale. Il racconto di Thy Womb, infatti, si realizza solo dispossessandosi, così come la protagonista corona il sogno del marito solo rinunciando alla sua esclusiva, e come quel tappeto si arricchisce attraverso l'inclusione nel suo tessersi di un numero spropositato di fili che si intrecciano senza posa al disegno principale. L'andamento episodico, ondivago e casuale della ricerca della moglie non solo rinuncia a qualsiasi malìa melodrammatica che non sia già tutta concentrata e bruciata nel fugace movimento d'occhi della divina Nora Aunor (l'interprete principale, in patria una delle star maggiori di ogni tempo), ma si fa permeare da innumerevoli storie potenziali già tutte contenute e bruciate nella flagranza fisica del loro balenare sensoriale a margine del racconto: indimenticabili, in questo senso, gli squali che volteggiano accanto alla barca dei protagonisti, o il grosso bue che cade in acqua e viene subito ri-raccolto a bordo. Questo costante ispessimento del plot attraverso le suggestioni regalate dall'ambiente può sembrare "turistico" ed esotizzante ma non lo è: le sgargianti danze nuziali offerte due volte ai nostri occhi sono in ambo i casi interrotte da spari di uomini in uniforme, spari di cui nessuna connotazione socio-politica ci è fornita e la cui periodica ricorrenza nel film è la più lampante epitome della figura principe della vita quotidiana di quel contesto: l'Interruzione, anche traumatica. È a furia di interruzioni e digressioni, di veloci cambi di punti di vista centrifughi e centripeti sulla scena che procede il gorgo sensoriale/narrativo della storia, un caos in cui Mendoza e la sua troupe si immergono con più macchine da presa digitali (siamo dunque incontrovertibilmente lontani da qualunque "pedinamento" neorealista) confidando che il tessuto finale affidato al montaggio (che denota peraltro un magistrale senso del ritmo) non potrà non recare tracce, viste le condizioni, della cacofonia rinvenuta sul campo. |
|
Israele/Palestina 2012, 110' sono:
Still Water
The Water Seller
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
28/30 |
|
Water
is a collective omnibus film project realised by three Palestinian
and five Israeli directors. They all share very different and personal
stories, each conceived around the theme of water. The initiator and
artistic director Yael Perlov (from the Tel Aviv University) shares that the
original idea behind the project is to find the juxtaposing of the
metaphorical and the political meaning of water: 'In our region the water
has a strong political meaning, it is controlled in Palestine. I wanted to
explore that conflict trough the means of cinema.' Water has the right reason to be a collective project, because it studies the different view points of two nations, living together in ever lasting conflict. Featuring seven independent episodes: Still Water by Nir Sa'ar & Maya Sarfaty, The Water Seller by Mohammad Fuad, Raz and Radja by Yona Rozenkier, Eye drops by Mohammad Barki, Kareem's pool by Ahmad Bargouthi, Drops by Pini Tavger, Now and Forever by Tal Haring, the film creates a cross dialogue between Israeli and Palestinian stories. Each piece is very personal, most of the time inspired or based on true events or observations of everyday life between Palestinian and Israeli people. The stories are very touching and create an emotional experience for the audience, breaking the prejudice of common notions based on political conflict. 'Water' is a brave and successful collaboration initiative of young directors, which deserves to be seen. |
|
diamond sutra
Orizzonti / Cortometraggio |
|
|
|
30/30 |
|
Il cortometraggio che chiude
la selezione di “Orizzonti” vede Tsai Ming-liang, al momento impegnato nella
fase di post-produzione del lungo PICNIC, esporre quasi a mo’ di
enunciazione filmica, con singole minime accentazioni verbali spostate verso
l’universo delle immagini, la peculiarità di un cinema costruito da sempre
sui tempi lunghi e la lentezza. L’idea è nata da un monologo teatrale messo
in scena dal regista malese per il Teatro Nazionale di Taipei/China. Un
monaco zen disegna la calibrata linea ondulatoria di un brevissimo percorso
davanti a una risiera elettrica che bolle, ma il tragitto viene compiuto in
un segmento temporale eterno, durante il quale lo spettatore volge la sua
attenzione altrove e, letteralmente, pensa ad altro, con attitudine
filosofica. Opposto a OUT OF FRAME, DIAMOND SUTRA stacca dallo schermo
per portarci su un piano di universalità concettuale, abbandonando la
contingenza di ciò che il (meraviglioso) work of video art sembra
rappresentare. L’ombra e l’illusione temporale del
riso che bolle e del passo del monaco letto in ogni suo spostamento
infinitesimale non sono altro che la nostra potenziale infinitezza
sub specie filosofica, con specifica declinazione buddhista. Straordinario oggetto d’arte, ben oltre l’immaterialità bidimensionale di molti lavori di simile concezione, DIAMOND SUTRA è un’affascinante scultura cromatica in movimento che va costituendosi progressivamente, lentissimamente come opera assai innovativa nel suo genere. |
|
BELLA ADDORMENTATA
di Marco Bellocchio
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
30/Lode |
|
Il capolavoro biopolitico che ci si attendeva, è puntualmente arrivato. Marco Bellocchio ha perfettamente compreso che nessun avvenimento può racchiudere l'era-Berlusconi da cui l'Italia è appena uscita (?) meglio del caso di Eluana Englaro: nulla definisce quel tipo di potere politico e i suoi abusi meglio della separazione della Vita con la V maiuscola dall'arena sociale, quella stessa separazione che Giorgio Agamben e l'assai meno convincente vulgata cosiddetta biopolitica che ne è derivata (e che ha reso assai vendibile il pensiero filosofico italiano anche all'estero), si sono per decenni affannati a denunciare. Il caso Englaro costituisce, infatti, il centro assente della bella addormentata: attorno ad esso si muovono diverse vicende (un senatore del PDL indeciso se votare la legge sul fine-vita, la figlia attivista anti-eutanasia, il suo fugace amante su posizioni politiche opposte col fratello fanatico, un'attrice famosissima che si ritira dalle scene per assistere la giovane figlia in coma, una tossica che un medico coscienzioso vuole salvare) tutte strette assieme dalla preziosissima linfa vitale della contraddizione, quella contraddizione la cui incandescenza è la condizione stessa perché un racconto, così come una vita (ma il film, fra l'altro, arriva a convincerci che l'uno e l'altra sono la stessa cosa), possano fregiarsi dell'aggettivo "politico/a". È con superlativa abilità che il racconto muta impercettibilmente il proprio focus dal controllo della vita all'onnipotenza dell'Immagine (evidentemente l'aspetto fondante dell'era berlusconiana). Perché l'una è l'altra faccia dell'altra: la Vita è ritirata dall'arena politica affinché quest'ultima sia esclusivo appannaggio dell'Immagine. E il personaggio della Huppert, come prova "a contrario" di ciò, si ritira dai set cinematografici per mantenere in vita il ritiro dalla vita della figlia in coma, interpretando privatamente e tra le mura domestiche il ruolo principale della sua carriera, quello della Santa (l'Immagine è ritirata dalla sfera politica/pubblica affinché quest'ultima sia esclusivo appannaggio della Vita). Sempre per questa separazione vita/immagine funzionale a un'alienazione fondamentale dalla sfera del Politico, vediamo un gruppo di senatori pidiellini che tentano (come nello stellare Illibatezza di Rossellini) di aderire tanto fisicamente quanto vanamente alle immagini propagandistiche proiettate sul muro innanzi al quale posano per un foto. Ed è per questo, soprattutto, che in una scena sublime vediamo la porta del Senato aprirsi per lasciare intravedere tra gli stipiti non la monumentale aula, ma i pixel della ripresa televisiva di essa. Nell'inestricabilità degli orientamenti del racconto (sanamente contraddittori) e delle sue componenti, così come nell'esibizione spudorata della recitazione sopra le righe quale dimostrazione palpabile del conflitto ineludibile ma anche dell'altrettanto ineludibile impasto tra vita e immagine, brilla la preziosissima carica utopica di una radicale ridiscussione dei rapporti tra pubblico e privato, una ridiscussione che sbaragli la separazione della Vita che ha fatto della politica unicamente una questione di Immagine, e che ci restituisca finalmente la sana conflittualità tra queste due dimensioni, senza la quale, anche dopo Berlusconi, non ci è né sarà possibile riprendere in mano alcunché, né la nostra Vita, né la nostra Immagine. |
|
di Xavier Giannoli
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
26/30 |
|
Superstar, cinquième long métrage de Xavier Giannoli est présenté en
compétition officielle à la Mostra de Venise. "Le cinéma doit avoir un
pouvoir de révélation du monde dans lequel on vit" déclare le réalisateur
qui explore certains mécanismes de la société avec un oeil aiguisé. L'idée du film vient au départ de "L'Idole", roman de Serge Joncour que Xavier Giannoli découvrit il y a quelques années : un homme devient célèbre sans savoir pourquoi. Comme le souligne le réalisateur, c'est ce postulat absurde, kafkaïen, qui constituait une matière intéressante. Le parti pris de ne jamais expliquer les causes de la soudaine célébrité de son personnage, fonctionne. Grâce à une mise en scène rapide, frénétique, le spectateur oublie cette question, tant il est entraîné, sans répit, dans ce tourbillon, cette mise en abyme, ce cauchemar que vit Martin Kazinski . Cet homme qui n'aspire qu'à rester normal, tente par tous les moyens d'échapper à cette spirale. Il court, se cache, essaie de résister aux innombrables assauts de ses fans et son urticaire au bras se manifeste régulièrement à cause de cet étau qui se resserre autour de lui. Le personnage, impuissant, est pris au piège du monde médiatique et devient la proie de cette foule menaçante, intrusive et si versatile. Cette foule qui constitue une machine incontrôlable s'emballe et donne le vertige. On pense à Fury de Fritz Lang ainsi qu'à Un homme dans la foule de Elia Kazan, autre référence du réalisateur. Xavier Giannoli souligne aussi l'interrogation soulevée par la phrase de Victor Hugo "Souvent la foule trahit le peuple". Ce film fait naître un questionnement profond. Cet appétit féroce de notre époque pour la célébrité et le pouvoir incontrôlable des médias sont traités avec beaucoup de finesse. Kad Merad interprète ce personnage perdu, subissant la violence de la société avec beaucoup d'humanité. Son duo avec Cécile de France, jouant Fleur Arnaud, une journaliste confrontée à elle-même qui sortira grandie de cette situation, fonctionne à merveille. |
|
di Ulrich Seidl
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
27/30 |
|
Making the petted audience at the Venice Film
Festival clap their hands during a screening isn’t easy. Ulrich Seidl,
probably one of the most known directors from Austria nowadays did manage
getting this approval with his new movie PARADISE: FAITH, the second part of
his PARADIES-triology. In this silent but engaging movie, Seidl focusses on a middle-aged missionaring woman driven by an obsessing faith in god and her love to Jesus. Working as a medical assistantin in her daily life, adamantined Anna Maria (Maria Hofstätter) spends her holidays trying to convert people to Katholiszm armed with an oversized statue of virgin Maria. Constantly trying to prove her devotion to Jesus she floging herself, sings and plays religious songs on her keyboard and robbs through her house on her knees for hours. When her aegyptian,muslimic and paraplejiced husband Nabil (Nabil Saleh) returns home after years (from somewhere the ausdience does net get to know), a nearly absurd feud of religions starts between Maria, who has abondened from her husband and now holding on to her religion and her love to Jesus, and her husband demanding from Maria the duties of a married woman and her love. Seidl creates very clear, documentary-driven and adamanting pictures, focussing on the characters and their sorrounding. No music and no way for the audience to escape from this absurd world. The actors themselve (especially Maria Hofstätter who has already been starring in Seidls IMPORT/EXPORT and DOG DAYS) mostly improvise, making the scenes intensively real and creating an remorsless black humour and sense of shame for the viewer. Adding a big slice of provocation and double morality, Seidl created a film, you will think about long time after leaving the cinema. |
|
di Marc-Henri Wajnberg
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
28/30 |
|
The very first scene of the movie shows priests
doing acts of exorcism on little children. José, a boy wearing a Winnie the
Pooh T-Shirt, perhaps the ultimate sign of innocence, is also accused of
being a witch. As it is his turn to undergo the ritual he escapes, and so do
we. Abandoned from his home, he tries to find a place in the hectic Kinshasa
streets. Mud roads, occupied by clunky vehicles, trash scattered everywhere,
and nowhere safe to sleep. He finds a group who take him up as a new friend.
The film follows this group and its different members, their everyday
struggle for money, food, and safety. Soon you understand that the dream
they have, to make music, is their only way to escape. A helping hand comes
from a crazy impresario called Bebson, who stimulates them and who makes
them practice. |
|
di Kirill Serebrennikov
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
24/30 |
|
Durante una visita medica, un uomo sposato
riceve dalla dottoressa che lo sta visitando la rivelazione che la moglie lo
tradisce – proprio con il marito di lei. I due, per un po', si macerano
all'ombra della coppia di amanti (visitano i luoghi in cui si recano loro
etc.), dopodiché diventano, prevedibilmente, amanti essi stessi. La prima
coppia fedifraga muore in un goffo incidente; gli altri due (forse
responsabili) vedono il loro rapporto finire e poi ricominciare a distanza
di anni, dopo il secondo matrimonio di entrambi. Da una trama così esile non sembra, ma Serebrennikov gioca grosso. Muove la camera costantemente, con pochissimi stacchi, facendola volteggiare ripetutamente intorno agli attori, incurante del tempo del racconto che è in questo modo libero di gonfiarsi come una bolla d'aria, e raccogliere il Puro Presente nella sua assoluta inconsistenza. Tanto inconsistente che possono pure verificarsi ellissi temporali di più di cinque anni come nulla fosse. Ed è proprio toccando l'inconsistenza di questo vuoto pneumatico di eventi in cui galleggiano i personaggi che si renderebbe avvertibile, secondo Serebrennikov (a giudicare dall'estetica che mette in piedi), il Fantasma, ovvero l'”altra” coppia che in ogni senso possibile è alla base del rapporto tra i due protagonisti e li precede come la loro ombra. Che gran film avrebbe potuto essere, con queste premesse. E invece, nonostante la consistente “puntata” messa sul tavolo da Serebrennikov, quest'ultimo perde clamorosamente. La differenza tra queste intenzioni e gli esiti è quella tra il respirare sottovuoto e l'annaspare. La camera a mano si muove, si muove, si muove, ma del vuoto che pure raccoglie a piene mani non sa assolutamente che farsene. E la diretta e logica conseguenza di questa troppo indiscriminata e indisciplinata apertura, è la necessità di una troppo brutale chiusura: il film si chiude infatti con l'impietoso, improvviso, arbitrario, e anche un po' bacchettone omicidio del protagonista da parte del nuovo marito di lei. Non aiuta, in tutto questo, la seriosità e la solennità dei personaggi e dei loro gesti che vorrebbero presumersi significativi (la dottoressa che prende, va in giardino, raccoglie un pugno di terriccio e se lo mangia): ciò contribuisce, anzi, all'imbarazzo di trovarsi davanti a un film che non si sa se voglia dirci troppo o troppo poco. |
|
di Hiam Abbas
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
26/30 |
| After a very successful career in acting, Hiam Abbas creates her first feature film called Héritage or Inheritance. The film is set at the border of Israel and Libanon where new fighting is taking place. The story starts as it ends, landscapes seen from high above, hills, covered with trees. All looks peaceful if not for the sounds of airplanes and war. Abbas seems to suggest in these images that even when there is no fighting that can be seen from a distance, still conflict takes place. Only when we descend from the sky we see the human scale of things, the houses and the roads where cars drive. Later, you can see the fighter aircrafts fly over. The main character of the film is Hajar (Hafsia Herzi). She is a beautiful and strong female character who stays true to her heart and her dreams. She has fallen in love with an Englishman (Tom Payne). Her brother (Ashraf Barhom) is a conservative man who even threatens to kill her if she stays with him. The father (Makram Khoury) has the same strong traditional opinion. Almost the whole family agrees it would be a scandal to marry a foreigner. And they very much care about the family honour. All of them are nuanced in different gradations, where in most cases the females are the most progressive thinkers. The story follows different members of this Palestinian family on the problems they have. Conflicts are spun out, come to a climax, and are concluded with great precision. These problems are all connected to the same theme: freedom. Old important issues like fertility, marriage, financial success, honour and the position of the woman are handled throughout different family members and relationships. In most scenes the actors give an excellent performance. Since there are so many emotional scenes they must be praised for their accomplishment. There are a few moments in the movie though where some insecurity is shown on scene, and it is a shame that these have been left in the final edit. Some inexperience is also shown in de editing itself, especially the flash-back scene that could have just been left out completely. For a first feature film this is still a wonderful result. The conflicts are depicted in fresh and original ways, the dialogs are great and not much time is wasted to tell the most essential of a meeting, a conversation or an event. The most touching moment is perhaps the bedtime story that a mother tells to her child, about a beautiful bird that is set free from its cage. Exactly what all the characters struggle with; the old traditions, that don’t seem to apply anymore to a new world and a new way of living, preventing them to be free souls. And with the coming war as a dangerous undertone, these sometimes ‘typical’ family problems are set in a much bigger and emotionally gripping perspective. |
|
di Brian de Palma
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
27/30 |
|
Passion
è un film che va visto insieme a
Redacted. È infatti un film in cui l'armamentario post-hitchcockiano
che da sempre sfoggia Brian de Palma (donne bionde/brune, coreografia
registica sopra le righe, manierismo della suspense, fenomenologia
parossistica della Colpa, voyeurismo come goffo e vano tentativo di
nascondersi l'inclusione dello sguardo nel proprio oggetto, e quant'altro)
viene messo molto direttamente al servizio di un intervento politico nei
riguardi di un tema di attualità: all'epoca la guerra in Iraq, oggi il
Diritto d'Autore. È col logo della Apple, infatti, che il film ha inizio. Segue il dipanarsi di una ordinaria dinamica di potere da ufficio (tratta dall'ultima fatica di Alain Corneau), per cui la manager bionda tenta di appropriarsi del lavoro creativo della sua assistente bruna, salvo reazione di questa – la quale ha a propria volta un'assistente rossa diversamente bistrattata. La catena però non viene proseguita con prevedibile assenza di limite: il logo Apple ricompare, ma non alla fine del film in modo da rendere circolare e infinita la dinamica. No: il limite c'è, perché la reversibilità apparentemente infinita tra autore e spettatore che sembra contraddistinguere il mondo mediatico (e quindi il mondo) di oggi è solo la maschera di un ben più radicale spiazzamento che separa il soggetto (autore e spettatore che sia) da se stesso. E lo dice uno che sulla reversibilità tra spettatore e autore, e cioè sul manierismo critico hitchcockiano a propria volta divenuto firma autoriale, ci ha costruito una carriera. Detto altrimenti: il solito depalmiano proliferare dei doppi non è che la maschera di una frattura, quella che separa il soggetto da se stesso. Via via che il dramma da ufficio affonda nelle spire del thriller, il film abbraccia la paranoia, e poi il senso di colpa – altrettante manifestazioni di quella scissione del soggetto la cui manifestazione ultima è la scissione onirica, la quale, non a caso, chiude il film. Man mano che la bruna assistente passa all'azione si scopre sempre più spettatrice di se stessa – e come al solito in De Palma, sguardo in macchina e soggettiva tendono per questo a collassare l'uno sull'altro. E man mano che si scivola nel thriller, i toni emotivi diventano sempre più sovraccarichi, e lo spettatore simmetricamente scopre quanto sia attiva la sua passività spettatoriale nel momento in cui gli viene rovesciata addosso il proprio stesso godimento di spettatore. Il tutto per farci avvertire questo: da qualunque parte la si giri, la falsa questione del diritto d'autore non può ambire a una stabilizzazione. Autore e spettatore si ribaltano con troppa sistematicità l'uno nell'altro. Parlare di "diritti d'autore" senza prendere in causa quelli dello spettatore non ha senso; più in generale: non risolveremo mai il problema dei diritti d'autore se non ci accorgiamo che questo problema, se lo si pone in questi termini, è mal posto, perché non c'è nessuna entità stabile (autore e spettatore non possono che scivolare costantemente l'uno nell'altro) a cui corrispondere questi fantomatici diritti. |
|
di Kiyoshi Kurosawa
Fuori Concorso |
|
|
|
|
|
28/30 |
|
Assente dal grande schermo dal 2008, Kiyoshi
Kurosawa ritorna con una miniserie di quattro ore e mezza che sembra
soprattutto riprendere il filo di
Loft (2005), uno dei suoi film più sottovalutati. Fulcro (langhiano) di questa operazione a tinte fosche e simil-thriller è un infanticidio: nel prologo, una bambina delle elementari viene avvicinata da uno sconosciuto, e uccisa poco dopo; le quattro amiche che erano con lei al momento dell'adescamento vengono poi convocate dalla madre, la quale le informa candidamente che la loro vita verrà per sempre rovinata dal rimorso, e che per questo dovranno trovare, negli anni a seguire, una forma di espiazione che possa soddisfarla. I primi quattro episodi vengono dedicati ognuno a ciò che ne è di una delle ex bambine, quindici anni dopo. Prevedibilmente, le giovani donne risultano tutte variamente disturbate a causa di quel lontano trauma. Particolarmente riuscito il secondo episodio, quello in cui l'ex bambina di turno è diventata una rigidissima, severa maestra elementare, cosa che ingenera l'amore e l'odio (ugualmente violenti) dei genitori degli alunni. È lei quella che aderisce con più zelo all'espiazione comandata dalla madre della bimba morta, colei che percorre fino in fondo, portandola agli estremi, l'assurdità e il paradosso di questa ingiunzione. È il quarto episodio, tuttavia, che comincia a fare intravedere il senso e il valore complessivi del progetto. Imprevedibilmente, i toni si rasserenano, il trauma perde ogni traumaticità e diventa anzi vera e propria merce di scambio, all'interno di dinamiche (tradimenti, equivoci) che sono piuttosto riconoscibilmente quelle della commedia. Una commedia in cui non c'è niente da ridere, certo - ma sbarazzandosi della rarefazione d'atmosfera, degli imperativi dell'inquietudine e della compostezza geometrica che abbondavano nelle prime tre parti, qui Kurosawa lascia intravedere quello che davvero gli interessa: il dipanarsi sempre più asciutto e astratto delle relazioni che avviluppano i personaggi, relazioni che intessono un nodo così stretto tra colpa, innocenza e redenzione da strozzare qualsiasi tentativo di districarli. Lo chiarisce definitivamente il quinto ed ultimo episodio, quello in cui si susseguono colpi di scena sempre più clamorosi e invece sempre più soffocati nell'understatement, praticamente solo sussurrati. La linearità scrupolosa che ha contraddistinto sin lì tutto Shokuzai (in totale controtendenza rispetto alla serialità televisiva “di qualità”, specialmente americana) viene chiarita quale sparizione di qualunque sostanza emotiva dietro al tessersi sempre più asettico ed impersonale della tramatura del racconto. È questa la funzione del nitore delle forme visive adottate da Kurosawa, della precisione con cui soppesa il vuoto, sceglie gli obbiettivi ottici che sospendono glacialmente in esso le figure umane, gioca con le composizioni rigorose ed immobili dell'inquadratura per ritagliare con nitidezza ancora maggiore l'emersione occasionale di sintomi di ciò che, sotto, ribolle (una busta di plastica che si muove, un sinistro cambiamento di luce...): il filo che parte dal trauma, ci ritorna, e devia per tangenti insospettate che invece conducono ancora più al centro di esso, viene seguito con così tanto scrupolo analitico che, letteralmente, “perdiamo il filo”, ci scontriamo con l'impossibilità di sciogliere il nodo che esso impercettibilmente ma inesorabilmente annoda. Ci imbattiamo però anche nel rovesciamento per cui questa stessa insalvabilità finisce per essere una paradossale salvezza. Una colpa troppo grande perché possa essere risolta viene eclissata ed effettivamente redenta dallo spaesamento del reticolo di desideri interpersonali che attorno a questa colpa si aggruma, un reticolo così intricato che non può appartenere a nessun soggetto. La salvezza arriva ad essere perciò l'apparizione di questa insalvabilità. Ciascuno è preso dentro una Situazione impura, in una rete di desideri più grande di lui/lei, in una geometria che tuttavia produce un eco sinistra vibrando in quel vuoto che in ultima analisi è: Kurosawa si prende tutto il tempo necessario (è a questo che gli serve la circostanza televisiva) per ripercorrere con totale linearità il filo di una intricatissima Situazione, giù giù lungo il passato e ancora su nei meandri del presente, affinché da essa risuoni la vibrazione del vuoto in cui è immersa, e che in definitiva è l'insalvabile che ci deresponsabilizza, e che ci salva. |
|
di Sólveig Anspach
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
24/30 |
|
Présenté dans la section Journée des
Auteurs-Venice Days à la Mostra de Venise, le nouveau long métrage
Queen of Montreuil de la
réalisatrice franco-américano-islandaise Sólveig Anspach est une délicieuse
comédie. Agathe (Florence Loiret-Caille) vient de perdre son mari. Elle fait la connaissance de deux Islandais, Anna (Didda Jonsdottir, collaborant pour la troisième fois avec la réalisatrice) et Úlfur (Úlfur Aegisson), bloqués en France. Ne lui laissant guère le choix, la mère et le fils s’installent dans sa maison à Montreuil. De cette cohabitation forcée va naître un échange qui progressivement aidera Agathe à faire son deuil. Des situations burlesques nous emmènent tout au long du film dans un univers surréaliste : son entourage lui prodigue des conseils absurdes pour tenter de surmonter la perte de son époux, elle cherche frénétiquement dans les ordures l’urne trop encombrante contenant les cendres de son mari tandis qu’un phoque se retrouve dans sa salle de bain. Les personnages gravitant autour d’Agathe sont originaux et fantaisistes. Il faut souligner les séquences particulièrement réussies dans une grue de chantier entre Anna et un ouvrier interprété par Samir Guesmi. La réalisatrice nous surprend constamment grâce à ce don pour décaler les situations et les rendre drôles et poétiques. Elle nous offre un film subtil et spirituel dont la structure non conventionnelle parle en profondeur de la relation entre les êtres. La distribution, excellente, est menée par la singulière et toujours remarquable Florence Loiret-Caille. |
|
sono: Poweder Room Zoe Cassavetes
Muta
It's getting late
The Woman Dress
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
20/30 |
|
Each director had the liberty to apply her own
artistic interpretation trough her preferable cinematic choices. The aim of
the film project was to voice feminine point of view and sensitivity,
combined with fashion, as the producer Max Brun describes it: 'Woman's
tales' is an innovative intersection of fashion and film'. The conceptual
idea is great but the fashion orientated limitation for the directors 'to be
inspired by the latest Miu Miu collection' unfortunately labels every film
and turns it into extravagant fashion impression, rather than
cinematographic narration. As the project will continue to develop in the future, I really hope that it can steer to direction of free artistic interpretation on the female relationship with fashion, rather than keeping the focus on a particular fashion collection. This way the resulting independent shorts can contribute indirectly great deal to fashion, bringing it on another level. The four films were screened together as 'Miu Miu Woman's Tales', but will be distributed in art cinemas across Europe independently as well. It's getting late by Massy Tadjedin (8'18") is a portrait of five women preparing themselves for a night out, with impressive international cast including Gemma Arterton, Patricia Clarckson, Rinko Kikuchi and Aubrey Plaza. The audience witness the life of four very different women - middle aged business woman, a mother, young blogger and a film editor, while observing their going out preparation. All of them are engaged in the same actions - slipping silk blouse, stepping into high hills, applying make up, zipping a dress, putting sun glasses on, each in her own situation. At the end they all arrive independently at the singing performance of the fifth woman (Zola Jesus), and placing them together in the last scene creates the impression that they belong to each other and have so much in common - their feminine power and cult for fashion. As the director Massy Tadjedin observes: "Fashion is never just the clothes. It's our mood, our excitement for something, our expectations, our attitudes, our outlooks. Managing those is often what getting ready is all about and that's what my short tries to capture." The Powder room by Zoe Cassavetes is the shortest (2'30") and the most expressionistic piece, set in the lobby of London's Claridges hotel. As the name of the film suggests, the film reveals an intimate portrait of few women performing the ritual of preparing themselves - beautiful camera work, elegant and intimate gestures, close ups and details, and plenty of fashion attributes. As Cassavetes sums it up: "I love the idea of a powder room, the ritual which takes place within them is very important for women." Muta by Lucretia Martel (6'27") is the most conceptual piece. Deriving from the title, meaning both 'mute' and 'transformation', the film take us into film noir suspense, on an anchored ship at dawn. When the darkness sets, the crew of femme fatales mysteriously emerges, with always hidden face and identity. Sounds and movements create intriguing landscape of clicks, vibrations, snaps and insect-like eye lashes flutter. Martel's film can be read as contemporary reflection on the transformative power of femininity. The Woman Dress by Giada Colagrande (6'49") is the only story driven short, staged as theatrical performance rather than a cinematic piece. A woman (played by actress Maya Sansa) sacrifices herself, performing a bath laying, finger prick, blood leak ritual, accompanied by three chanting witches, to transform herself at the end into the dress of her ultimate desire (part of the latest Miu Miu collection). As the director explains: "Cinema is a powerful way to bring fashion in another dimension: you can take a single image, like a dress, and create a whole world around it." Giaga Colagrande is absolutely right, but unfortunately the presented four films of Women's Tales lack the strength and the power of cinema, with the only exception of Lucrecia Martel's Muta. I believe that bringing fashion to another dimension, has to do with abandoning it's direct use in the films. |
|
millennial rapture
di Koji Wakamatsu
Orizzonti |
|
|
|
|
|
30/Lode |
|
Il film probabilmente più portoghese visto
quest'anno a Venezia. Un film ultraletterario in cui l'aderenza alla parola
scritta è aderenza a una distanza al di là della vita e della morte, una
distanza che è tutt'uno con la libertà. Tre giovani virgulti del clan maledetto dei Nakamoto, "nobile ma empio", passati in rassegna nel ricordo da una levatrice morente che parla con la foto del marito, un monaco morto tempo prima. Esattamente l'interregno tra vita e morte è l'interregno del godimento, stella polare che per costoro (un adultero, un ladro, e infine un amante della stessa levatrice) coincide non solo con la trasgressione, ma con la vita stessa. La vita non è, infatti, che irregolarità passeggera di un rapporto altrimenti stabile tra vita e morte. Una dopo l'altra, la vita di questi irregolari ci fa presagire l'ombra dell'incesto, la trasgressione suprema, il secondo Nakamoto più del primo e il terzo (che lo "consuma" infine) più del secondo – ma appunto solo della sua ombra si tratta, perché l'accoppiamento non viene effettuato con la propria madre, ma con questa sorta di matrigna adottiva che è la levatrice. La trasgressione è, strutturalmente, solo l'ombra della trasgressione, perché non ha nessun "fuori" di cui trasgredirebbe i confini, esattamente come la vita stessa non ha un "fuori". È in questo senso che per i Nakamoto, e per l'umanità tutta, vita e trasgressione coincidono. La sublime irregolarità della regia di Wakamatsu, così, se ne frega delle regole del "buon filmare", ma questa sua trasgressione non trasgredisce alcunché, perché è invece aderenza alla parola scritta (del romanzo di Kenji Nakagami), su cui Wakamatsu si adagia con totale indifferenza verso lo scandirsi del tempo (che invece il "buon filmare" vorrebbe regolare), supino al fascino dell'affabulazione di una parola che è distanza, che è gusto della distanza (lo stesso gusto della distanza dei due contemplativi maturi coniugi cui i giovinastri tornano sempre), ovvero l'unico gusto che, oltrepassando la soglia fittizia e illusoria della trasgressione, può esserci nella vita – ovvero nel costante avvicinarsi alla morte. |
|
di Olivier Assayas
Venezia 69 |
|
|
|
|
|
28/30 |
|
1971. Il
1968 è ormai un ricordo che si tenta invano di mantenere vivo e presente, e
in un liceo parigino un gruppo di benintenzionati giovani si spendono in un
attivismo fatto di graffiti, manifestazioni e ciclostili. Ma il decennio
appena inaugurato non si mostrerà clemente con queste illusioni. Il
protagonista, per esempio, abbandonerà le proprie ambizioni di pittore e
diventerà un mestierante in qualche improbabile studio cinematografico.
Altri conserveranno le ambizioni pittoriche, ma a prezzo di qualsiasi
residua velleità rivoluzionaria. Altri andranno in pellegrinaggio in India,
ma solo per ritrovarsi, increduli, in un salotto a mostrare il filmino
turistico agli amici. |
|
WADJDA
Orizzonti |
|
|
|
|
|
30/30 |
|
It’s a surprising fact that
Wadjda wasn’t awarded a single prize at the Venice Film Festival. One does
wonder if the jury maybe missed the screening since anyone who sees this
movie can only conclude it is more than excellent. |
|
di Rusudan Chkonia
Giornate degli Autori |
|
|
|
|
|
26/30 |
|
Le premier long métrage de Rusudan Chkonia, Keep Smiling, présenté dans la section Journée des Auteurs-Venice Days, a recu un accueil très enthousiaste lors de sa projection. Ce film géorgien nous fait partager l’aventure de 10 femmes en lice pour remporter un concours de beauté, réservé aux mères de famille. L'importance du lot, 25 000 $ et un appartement, attise toutes les convoitises des candidates, pour la plupart issues d’un milieu modeste. La réalisatrice donne beaucoup de densité aux parcours de ces personnages confrontés tout au long du film à cet arbitrage entre les exigences de la télévision spectacle et le respect de leur dignité. Rusudan Chkonia parvient avec humour à montrer la fragilité de chacun face à ses propres limites et nous offre des séquences irrésistibles notamment celle où le producteur de l’émission oblige les candidates à se mettre en maillot de bain. La réalisatrice eut l’idée de faire ce film après avoir rencontré une ancienne candidate de ce concours. Elle fut frappée par la richesse de la situation, absurde, tragique et drôle à la fois. Ce long métrage, satire du monde des médias offre une réflexion sur la part de liberté que chacun conserve et la place de la femme dans la société géorgienne. Ce film interprété par de magnifiques comédiennes s'achève avec une image que l'on garde en mémoire, deux anges suspendus au dessus d'une scène de studio d'enregistrement, désertée par des candidates reprenant conscience d'elles-même. |
|
Pietà
leone d'oro venezia 69 |
|
|
|
|
|
30/30 |
|
Pietà is director Kim
Ki-duk's eighteenth movie. When this fact appeared on the screen, a
spontaneous applause erupted. Hugely underappreciated at home, Kim Ki-duk is
well-known beyond the borders of his country South-Korea. He does not
conform to any rules, doesn't avoid sensitive subjects, and shows the
harshness of life without any scruples, political, humanistic and in a very
physical confronting approach. It is true that his films are usually not an
easy watch; they certainly do not conform to idea that film equals
entertainment. The free thinking soul will see that Kim Ki-duk’s movies are
not made to shock the audience just for the sake of it, but to show the
thoughts of a brave artist, who exhibits a rare vulnerability and a
frightening honesty in his approach to his subjects. |
|
69.ma mostra int. del cinema Lido di Venezia 29 agosto / 08 settembre 2012
|