|
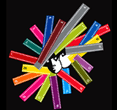
Torino 2002 - Julio Bressane e gli anni delle Belair, ovvero: una
salutare insania cinematografica
L’imponente figura (sotto ogni aspetto) di Julio Bressane ha fatto capolino,
dopo la Mostra del Cinema del 2001, anche a questo Torino Film Festival, che
ha dedicato al grande regista brasiliano una meritatissima e completa
retrospettiva, naturalmente curata da Roberto Turigliatto.
Suppergiù trenta pellicole, che ripercorrono i trent’anni di
un’appassionata, rovente sperimentazione che ha sorvolato i tempi grazie ad
una inaudita libertà espressiva, una libertà che, messa accanto ad odierni
prodotti “sperimentali” (e in parecchi sembravano piccarsi di questo
aggettivo fra le sale del Festival) li fa sembrare dozzinali, prevedibili
cloni di un cinema preconfezionato, tenuto in vita tra additivi e
conservanti. Eppure, in molti il nome di Bressane devono averlo sentito per
la prima volta proprio in questa occasione.
In questo strano panorama festivaliero, dunque, attorniati dalla
globalizzazione più bieca di quel gigantesco fast-food marmoreomuseale che è
il centro commerciale del Lingotto, ovattati ed alienati dal rosso ferrari
moquettoso del multisala Pathé in cui è stato cacciato a forza il festival,
strappandolo al rassicurante centro storico torinese, i film di Bressane
hanno avuto l’effetto eversivo e dirompente di una bomba H capace di
azzerare ogni cosa intorno a sé, violenta rievocatrice di una matrice
primordiale, istintiva del cinema.
Il geniale regista brasiliano rimane d’altra parte un unicum nel panorama
cinematografico mondiale, potendo rivendicare l’invenzione di un modo di
fare cinema che tuttora è nuovo e in continua innovazione, poiché parla i
linguaggio senza tempo dell’invenzione poetica.
Julinho Bressane, classe 1946, è l’anima luciferina del cinema sperimentale
brasiliano (il cosiddetto cinema marginal), regista-artista estraneo ad ogni
inquadramento politico, storico, stilistico, oggi esattamente come negli
anni ’60, quando poteva peraltro costare caro sottrarsi sfacciatamente alla
militanza ideologica e inseguire la propria poetica in un paese stritolato
dalla tirannia e assetato di rivoluzione.
Nel 1966, a vent’anni, Bressane ha già girato un film (Cara a Cara, “Faccia
a faccia”) che fa il giro di tutti i festival europei, inserito com’è nel
fenomeno del Cinema Novo, corrente dalla quale Bressane verrà repentinamente
espulso solo tre anni dopo, nella confusione politica dell’epoca, ripudiato
dal suo stesso alter ego registico e amico Glauber Rocha. Cara a Cara sarà
il primo film di Bressane a passare alla Quinzaine a Cannes, nel 1968,
perloppiù ignorato dal pubblico, salvo “alcune persone buone, sensibili,
strane…”. Fra questi sperduti ammiratori si annoverano Jacques Demy, Miklos
Jancsò, Carmelo Bene, il cui Capricci fu per Bressane “un vero choc…un film
straordinario, che mi stimolò molto…un Ejzenštejn dell’Lsd, un Ejzenštejn
lisergico”.
Quell’anno, a Cannes, il ventiduenne Bressane vive l’esperienza di un
“narco-anarco-festival” (la definizione è sua) in cui, oltre al defoncé
Carmelo Bene, trascorre notti goliardiche con Dennis Hopper (che aveva “un
fumo molto buono”), Jack Nicholson, Nicholas Ray, e avrà occasione di
incontrare più volte un Visconti affascinato da un istrionico Glauber Rocha.
Nel 1970, dopo la rottura con Rocha, Bressane dà vita alla casa di
produzione più indipendente, più prolifica e dalla vita forse più breve
della storia del cinema: in due mesi la Belair (evocazione beffarda di
limousine con autista su Hollywood Boulevard) sforna sette lungometraggi,
fioriti prodigiosamente sullo scompiglio creato nel panorama cinematografico
brasiliano dai due precedenti lavori di Bressane, O Anjio Nasceu (L’angelo è
nato, 1969) e Matou a Famìlia e Foi ao Cinema (Uccise la famiglia e andò al
cinema, 1969), girati complessivamente in tredici giorni.
O Anjio Nasceu rappresenta il punto di distacco dal Cinema Novo, e, insieme
a Matou a Familia, una decisa dichiarazione di libertà creativa, rispetto al
progetto di cinema politico di Rocha e compagni, che Bressane poté
permettersi anche grazie alla possibilità di autoprodurre, almeno in parte,
i propri lavori. Nel film i protagonisti sono due banditi in fuga, uno dei
quali, il nero, mistico e visionario, crede nella venuta imminente di un
angelo purificatore. Il bianco, invece, è ferito ad una gamba, sanguina. I
due si trascinano in una sorta di attesa dell’evento, durante la quale
sperimentano quelli che potrebbero essere definiti gentilmente comportamenti
altamente antisociali con punte di ultraviolenza: dopo svariate efferatezze
on the road, i due irrompono in un’elegante villa borghese (le case dei
ricchi nei film di Bressane sono popolate di design italiano e mobili di
Cassina), violentano e torturano la giovane proprietaria e la domestica e,
attirati da un miraggio finale, le fanno fuori per proseguire il loro
cammino. Alcuni ingredienti-base del cinema di Bressane sono già qui
assemblati a formare un insieme crudo, incoercibile e, nel complesso, pieno
di poesia e di profeticità: la sessualità perversa, sadomasochistica, il
misticismo lucido e invasato, il conflitto violento tra borghesia ed
emarginati.
Ora, se una sinossi può essere estrapolata per evocazione, il tessuto
narrativo e la vera costruzione di O Anjio Nasceu rimangono quanto di più
fluido e scomposto si possa immaginare, cosa che del resto caratterizza ogni
film di Bressane, in gradi differenti. Il mezzo filmico è vissuto come
strumento di happening, un’esperienza artistica vissuta nel girato, nel
montaggio e in mille variabili di produzione e d’altra parte mai veramente
conclusa, dato che lascia allo spettatore un’ampia possibilità di reazione,
esattamente come quando si legge una poesia, o si guarda un quadro, o si
ascolta della musica. L’uso della macchina da presa è sperimentale
nell’accezione più completa, l’espediente tecnico superato da una volontà di
“vedere” ai confini del delirio mistico. E’ un film “incosciente, e con una
forma narrativa che io ancora non conoscevo. Non avevo mai fatto un film con
inquadrature lunghe, con una narrativa che seguiva un crescendo. Una volta
terminato, provai una grande difficoltà ad accettarlo.”
O Anjio Nasceu ha momenti di camera a mano compulsiva, altri di una fissità
ipnotizzata, come l’interminabile inquadratura che conclude il film, una
strada deserta da cui nulla parte e nulla arriva, mentre scorre tutta intera
un’allegra canzone brasiliana, lasciando infine un altrettanto lungo
silenzio. L’attesa continuerà anche dopo la non-fine del film, in uno zoom
sfocato, amaro.
”La maniera in cui lasciai che la mia sensibilità fosse attraversata da
tante forze incoscienti, costituì anche per me un’esperienza devastatrice.
Per me, personalmente. Perché ti confronti con qualcosa di tuo che è
intollerabile, queste potenze che sono dentro di te e con cui ti metti a
contatto restandone estremamente scosso. (…) Credo che Anjo sia ancora una
‘terra incognita’ anche per me.”
Matou a Familia e Foi ao Cinema, girato contestualmente a O Anjio, in una
quindicina di giorni, si compone invece di dieci storie, che prendono il via
da un episodio iniziale, che dà il titolo al film, ispirato ai titoli dei
giornali scandalistici: un ragazzo del ceto medio-basso uccide padre e madre
e va al cinema a vedere “Perdidas de Amor”. Nel film, che finisce per
sovrapporsi alla realtà, due ragazze poco più che adolescenti, vista la
propria relazione saffica minacciata dalla madre di una delle due, la
uccidono a pugnalate. Due sorelle della buona borghesia, una delle due in
piena crisi matrimoniale, si ritrovano nella lussuosa e imbalsamata casa di
quest’ultima e, in un delirio liberatorio a base di samba, dopo aver
infranto in ogni modo l’ordine costituito della dimora, fra balli e risate,
finiscono per spararsi l’un l’altra al culmine di una sorta di rito
sacrificale a metà fra il sabba e l’isteria. Altri frammenti e storie
narrano di altri personaggi senza passato, né futuro, che si agitano nel
presente violando ogni legge etica, senza nulla da perdere, gioiosamente e
disperatamente al tempo stesso.
In Matou a Familia, come in O Anjo, si assiste ad un’autentica implosione
sintattica dei contenuti, dei tempi e dei modi codificati del fare
cinematografico, una decostruzione in piani paralleli e conflittuali degli
elementi del film. I personaggi stessi creano punti di rottura violenti con
l’ambiente che li circonda, facendosi trascinare da una follia eversiva e
provocatoria che li porta all’autodistruzione, una salutare “idiozia” che
trascende i limiti e rompe ogni schema. Ritmi a singhiozzo, scene che si
“incantano”, come la puntina di un giradischi che, nell’ultima scena,
replica all’infinito la mezza strofa di una canzonetta popolare.
Nei film prodotti successivamente con la Belair, Bressane raffina e aggiunge
elementi via via più complessi ai suoi lavori, realizzati sempre in tempi
strettissimi e con un’economia di mezzi e materiali che fa pensare ad una
sorta di action painting cinematografico. In A Familia do Barulho (La
famiglia del chiasso, 1970) si fa il verso alle chanchadas, i popolari film
melodrammatici brasiliani, utilizzando però autentiche star di questo
genere, fra cui Grande Otelo, che era stato attore ed amico di Orson Welles,
l’autore-feticcio di Bressane.
Barão Olavo, O Horrivél (Barone Olavo, l’orribile, 1970) è invece una
commedia dell’assurdo, in cui la follia si autogenera nella cornice di una
misteriosa casa nella foresta, abitata da un gruppo di strani personaggi.
“Alla fine tutti escono dalla casa come se fossero dei topi da laboratorio
che fuggono e vanno a contaminare il mondo” (Bressane). Letteralmente
esilarante la scena finale con sottofondo trascinante di samba, in cui i
protagonisti, in una sorta di candid-camera, si aggirano per le strade
affollate di Rio compiendo ogni genere di stranezze fra gli sguardi
divertiti e un po’ spaventati della gente, “contaminando” il mondo con una
sana follia creativa che precorre di un bel po’ d’anni l’insania
calcolatissima degli Idioti di Lars Von Trier.
In Cuidado Madame (Attenzione Madame, 1970), la camera a mano segue le gesta
di una giovane cameriera che, in combutta con un’amica, compie una piccola
rivoluzione sociale uccidendo la sua elegante padrona a coltellate, tra
sambe e danze sguaiate. La musica ha vita propria e domina letteralmente le
azioni dei personaggi, contrastandole o accompagnandole negli eventi con
un’energia caustica, incurante e irriverente.
Gli anni della Belair si conclusero per assenza di fondi, e non certo di
energia creativa. La ricerca di Julinho continuò e continua tuttora,
infatti, a produrre capolavori estremi come Dias de Nietzsche em Turin o São
Jeronimo.
L’essersi inventato un nuovo modo di fare cinema, l’aver scelto una strada
di ricerca personale, tacciata di eccessivo individualismo, aveva tuttavia
creato un precedente tale da costare l’interdizione a Bressane da tutti i
circuiti di produzione, brasiliani ed europei.. “Ho passato 12 anni senza
poter presentare film ai festival nazionali, e per 20 anni i festival
internazionali rifiutavano o ignoravano sistematicamente i miei film: ero un
‘agente della CIA!’ “.
A vederlo oggi, l’esilio materiale e morale di Bressane, che continuò
dall’estero, per anni, a mandare i suoi segnali cinematografici, può
sembrare assurdo, e lo fu anche per lui stesso. Ma la spinta a girare fu
decisamente più forte, e Bressane, affetto da un autentico nomadismo,
continuerà a spostarsi e a creare, ad inseguire la sua pista.
“Sapete cosa ho capito quando ho iniziato a fare cinema, fin dalla prima
volta che ho messo l’occhio dietro alla macchina da presa, quella che mi
aveva regalato mia madre? Ho provato subito una sensazione di estraneità
rispetto a quello che avevo filmato, qualcosa che avevo fatto io ma che non
mi apparteneva, che era diverso rispetto a me. Questo sentimento mi ha
perseguitato per molto tempo, fino ad oggi.Ho notato che il cinema (…) è una
specie di organismo che attraversa l’intera sensibilità di una persona,
attraverso l’arte, la scienza e la vita stessa. Non è solo uno strumento che
riflette la visione del mondo, ma uno strumento di autotrasformazione
radicale. Oggi un cineasta, oltre a possedere talento, deve contare su
molteplici conoscenze, che è molto difficile avere e per le quali non si ha
il tempo.Ma l’esigenza del cinema esiste ancora ed è un’esigenza
dell’organismo cinema. In questo senso ho sempre inteso il cinema come uno
strumento di autotrasformazione, di rimozione e di acquisizione. Quelle
immagini lì, registrate, trent’anni prima, fissate per sempre, rappresentano
una maniera per poter dimenticare tutto quello. Una maniera per liberarmene
facendo.(…)
Modestia a parte, avrei potuto essere il principe dei cineasti brasiliani e
invece sono stato messo da parte, giustamente.(…) Ho fatto questo cinema
perché non potevo fare altrimenti, non c’era uscita per me, era una
questione di vita, o facevo così o morivo. Ho fatto questi e non i grandi
film, che so: 2001: A space Odyssey. Dovevo fare questo. Ho fatto questi
film e i film hanno fatto me. L’ho capito facendoli, per me la vita non
aveva altra uscita.”
(Julio Bressane, 2002)
Piccarda di Montereale
CONCORSO DOC 2002
Doc 2002 è la sezione
interamente riservata ai documentari italiani (di recente produzione), 15
opere che narrano vicende differenti con differenti modalità, ognuna
testimone della varietà di strumenti espressivi in grado di documentare un
evento, ritrarre una persona, mostrare il trascorrere del tempo. Il Torino
Film Festival è particolarmente orgoglioso di questa sezione perché è
cresciuta negli anni e ha concorso al rilancio del documentario nel panorama
nazionale di produzione cinematografica.
Opere decisamente eterogenee sono quelle che abbiamo visto e ciò ci fa
pensare a un panorama vivo, ad autori che cercano un proprio spazio e a uno
sviluppo di questo genere cinematografico.
ALICE E’ IN PARADISO di Guido Chiesa dall’affermazione scritta a
caratteri cubitali “il ’77: che palle!” ha inizio la storia di Alice, la
radio bolognese chiusa con un’irruzione dei carabinieri nel marzo del ’77
durante gli scontri di piazza avvenuti dopo che un carabiniere aveva
ammazzato uno studente. Il racconto procede lieve con interviste ai
fondatori della radio, immagini dell’epoca, inserti del racconto di Carroll
e scritte che interrompono la narrazione. Il risultato è un documentario
trascinante, ironico, mai retorico, girato in modo da risultare leggero, ma
senza essere mai superficiale o modaiolo (ed era abbastanza vintage per
poterlo essere).
L’ULTIMA CORSA di Enrico Pitzianti narra della
dismissione del servizio passeggeri delle navi traghetto delle ferrovie
dello stato che collegano Civitavecchia alla Sardegna. Tutto girato a
stretto contatto con i dipendenti delle FS, con primissimi piani dei volti,
utilizza ogni strumento per renderci partecipi della disperazione degli
uomini imbarcati per l’ultima corsa del titolo. Anche dal vivo la didascalia
appartiene a Pitzianti, infatti in sala ci ha informati del fatto che in
Sardegna non c’è lavoro e la gente del posto è costretta a emigrare. Devo
dire che la notizia non ci giungeva nuova…
SALA ROSSA di Saverio Costanzo: nella sala rosa del
pronto soccorso entrano i pazienti che stanno tra la vita e la morte; è una
zona off limits e questo corto sfrutta la tendenza voyeuristica dell’essere
umano e la sua curiosità. Condividiamo con due equipe di medici e infermieri
alcuni momenti delle nottate in cui questi sono in servizio e qui la regia è
nulla per ovvi motivi, ma nelle interviste (sempre ai protagonisti)
assistiamo a scelte pericolosamente vicine al patetico con ambientazione
“paradiso” realizzata con un bianco sfolgorante che sfuma i contorni dei
visi e gli stacchi sulle nuvole del cielo.
COME FOSSILI CRISTALLIZZATI NEL TEMPO di Luca Pastore lo si segue
come in trance grazie alla musica che accompagna le bellissime immagini di
fabbriche in disuso. Siamo nei pressi di Biella dove ci sono i più grandi
complessi dell’industria tessile (ovviamente abbandonati) e Pastore ce li
mostra attingendo dall’immaginario dei formalisti russi e facendo una scelta
di stile molto evocativa mantenuta tale poi su piani differenti. Ci sono
figure umane che abitano di nuovo quei luoghi, ma sono figure mute e
immobili mentre gli edifici stessi si animano grazie all’unione della musica
e del montaggio (audace) oppure grazie alla rievocazione della frenetica
attività passata.
PORNODROME UNA STORIA DAL VIVO di Beniamino
Catena è invece uno sconcertante contenitore vuoto e senza che ci sia una
poetica dell’assenza dietro. Un gruppo che suona esclusivamente dal vivo si
prepara per un concerto; e fin qui non ci sarebbe niente di male, niente di
nuovo, ma neppure niente di male, a parte l’elevato tasso di antipatia dei
componenti del gruppo. Parallelamente a questa dura preparazione, però,
Catena ci mostra di aver imbastito una storia imbarazzante che vede
coinvolti tre amici che girano un video con una svedese, la stuprano, la
soffocano e la avvolgono nel cellophane (senza chiedere scusa a Lynch); pare
che lei non muoia, comunque. Almeno avesse avuto l’ironia di commentare che
il suo film era una metafora del fatto che il mito della svedese è duro a
morire, sarebbe stato tollerabile, ma l’autore, che si prende molto sul
serio e forse si rende conto del risultato complessivo, preferisce il
concorso di colpa, infatti dichiara che la sua è un’opera collettiva (con
gli interventi dei musicisti etc.), anomala e con l’obiettivo di raggiungere
una partecipazione condivisa.
Altri film
DARK WATER
di Nakata Hideo
Giappone 2001
L’acqua scrosciante accompagna tutto il film, ossessiva e impietosa segue le due protagoniste (una madre appena separata dal marito con sua figlia) e lo stesso fanno un incubo e una figura di bambina in impermeabile giallo. La paura dell’abbandono si amplifica e si trasmette di madre in figlia, arriva a permeare anche l’ambiente circostante come la macchia di umidità che invade in poco tempo il soffitto della nuova casa delle due donne; il piano razionale, umano, psicologico, confina con quello del paranormale e ciò che all’inizio si pone solo come possibilità remota finisce per diventare l’unica terrificante realtà. Un climax imprevedibile perché il film gioca bene su entrambe le suggestioni, quella terrena di mente suggestionabile e quella ultraterrena, ci porta dentro l’incubo mantenendo una specie di ottundimento dei sensi perenne, lo stesso fanno i salti temporali funzionali alle proiezioni delle esperienze della madre sulla figlia e il ricorrere della situazione che ha causato il trauma iniziale. Tra psicanalisi e horror tout court.
THE PRINCESS BLADE
di Sato Shinsuke
Giappone 2001
Yuki alla vigilia del suo ventesimo compleanno scopre di essere una principessa e di lavorare per l’uomo che ha assassinato sua madre, ragione di vita diventerà la vendetta e in questo suo percorso incontrerà Takashi anch’esso tradito dal proprio capo. Il soggetto è tratto da un manga e racconta la storia d’amore tra i due ragazzi, uniti dal destino proprio mentre intraprendono la loro guerra personale. Molto bello il combattimento tra gruppi dell’incipit, reiterati all’infinito gli scontri tra Yuki e il resto della banda con la reazione proprio in punto di morte che porta alla vittoria. I momenti lirici, contraddistinti sempre dalla presenza di pegni amorosi, si alternano alle scene cruente dando una cadenza molto rigida all’impianto filmico. Vivamente sconsigliata l’identificazione agli adolescenti.
Sara TROILO
TOY LOVE
Di Harry Sinclair
Amori giocosi, frivoli e senza sentimenti, tradimenti leggeri e spudorati,
sesso problematico e relazioni vuote e superficiali: questi gli ingredienti
che condiscono la commedia New Zelandese di Harry Sinclair.
Ben, giovane protagonista del racconto, abituato a tradire senza tanti
scrupoli la fidanzata Emily che lo tradisce a sua volta, viene sconvolto
dall’incontro con Clio, ragazza anticonvenzionale ancora più disillusa e
cinica di lui, che lo porterà a fare pazzie di ogni genere.
Di questi tre personaggi non ci viene detto molto, la loro vita è scandita
solo da ridicole e poco probabili avventure sessuali, poco sentite e
piuttosto squallide.
Un quadro della gioventù disincantata e ormai senza nessun tabù sentimentale
che dovrebbe far sorridere e divertire e che invece rischia inesorabilmente
di annoiare con trovate banali e portate all’eccesso . L’ennesimo tentativo
di stupire con la trasgressione, già visto e rivisto e svuotato di ogni
possibile legame con la realtà, che non aggiunge nulla di nuovo al genere
della commedia sexy.
L’apice della convenzionalità, che voleva essere tanto rifuggita , viene
raggiunto con il tentativo di spiegare la superficialità sentimentale come
risultato di sofferenze e delusioni amorose passate e di affibbiare ai tre
protagonisti sentimenti autentici, di cui erano privi fino alla fine e che
invece appaiono come per magia alla conclusione.
EL LEYTON
(HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE)
di Gonzalo Justiniano
Questo film cileno in concorso, tratto da un racconto piuttosto popolare in
Cile, narra le vicende di una piccola e isolata comunità di pescatori che
viene sconvolta da un delitto d’onore; infatti el Leyton, unico giovane
scapolo del villaggio, bramato da tutte le donne del paese, insidiando la
novella sposa dell’amico Modesto (di nome e di fatto), uomo onesto e dai
sani principi, ma poco virile, provoca lo scoppio della tragedia…
Il regista Justiniano, vincitore di Cinema Giovani nell’ormai lontano 1986,
fa un film in chiave tragicomica e sembra indeciso sul tono da dare al
racconto, non è chiaro infatti se drammatico e moralista o ironico e
indulgente. Si tratta soprattutto di una riflessione sulle ataviche
contraddizioni dei popoli latini, eternamente divisi tra una grande
religiosità e una vivace sessualità e sulla vita comunitaria degli abitanti
di piccoli villaggi, apparentemente solidali tra loro, ma in realtà uniti da
rapporti morbosi, invidiosi ed invadenti, che li portano a rivolgere le loro
frustrazioni su un capro espiatorio: tema che generalmente coinvolge giovani
e attraenti ragazze. In questo caso invece, ad essere implicato è il povero,
ma non troppo innocente, Leyton, il quale, inizialmente costretto ad
abbandonare il villaggio, verrà riaccettato a patto di rinunciare alla sua
libertà di single . Niente di originale quindi, ma il film risulta
scorrevole e divertente soprattutto per il fatto di mettere in risalto
aspetti della vita e della cultura cilena.
La tecnica e le inquadrature decentrate e oblique, che non sempre sembrano
funzionali allo svolgimento del racconto sono tali perché il film è girato
in digitale poi trasferito in pellicola.
Caterina Mazzuccato
HAMMER FILMS
“Un’altra
Europa”, una rassegna nella rassegna posta nell’ambito di “Orizzonte
Europa”, quest’anno ci porta nelle “altre” atmosfere della gloriosa casa di
produzione inglese Hammer. Per chi non lo sapesse la Hammer Films, che ebbe
il suo periodo d’oro tra gli anni cinquanta e sessanta, si specializzò nella
produzione di pellicole e serial televisivi di genere fantastico e
orrorifico. Una vera e propria “macchina spettacolare”, con base negli studi
di Bray, la cui formula vincente era il budget ridotto ed i tempi di
lavorazione tiratissimi (in venticinque anni furono prodotti e distribuiti
centoquaranta film), grazie soprattutto di specialisti dell’horror, dai
registi Terence Fisher, Roy Ward Baker, Freddie Francis e John Gilling; agli
sceneggiatori Jimmy Sangster, «John Elder» e John Sansom; dal direttore
artistico Bernard Robinson; dagli operatori Jack asher e Michael Reed fino
al compositore di colonne sonore James Bernard e al truccatore Roy Ashton. I
segni distintivi delle pellicole Hammer divennero le luci violente
(tutt’altra cosa rispetto a quelle polverose marchio della Universal) e un
nutrito gruppo di attori che divennero delle vere e proprie icone della
fantasia e del terrore come Christopher Lee, Peter Cushing e Barbara
Shelley.
A Torino è stato proposto un piccolo, ma fortemente rappresentativo, gruppo
di film della Hammer; con piacere si è rivisto
L’astronave degli esseri perduti
(Quatermass and the pit,
1967) di Roy Ward Baker ovvero il terzo episodio della saga (ripresa da una
serie televisiva di successo e primo film della casa inglese con
The Quatermass Xperiment del
1956) del Dottor Quatermass e forse il più bello ed interessante.
Decisamente affascinante l’ambientazione realistica, in contrasto con
l’atmosfera sottilmente fantastica, di Londra; dove in uno scavo della
metropolitana viene ritrovata una astronave che forse è all’origine di ogni
male sul pianeta terra. Una pellicola dai mezzi e dagli effetti speciali
poveri, in cui lo straordinario nasce dall’ordinario, e per questo ci
ricorda i sottili terrori dei racconti di Lovecraft.
Di sicuro interesse anche La lunga
notte dell’orrore (The plague
of the zombies, 1966) di John Gilling; a prima vista un classico
horror-movie ma nella sostanza si avverte qualcosa in più. Una lettura quasi
di stampo marxista degli zombie usati da nobili imbelli e corrotti per
realizzare plusvalore per le loro orge e festini di sangue. Dalla morale
comunque semplice e semplicistica, potrebbe tuttavia essere eletto a
capostipite di tutte le pellicole combat zombies nati nel clima della
contestazione giovanile di quegli anni: il trucco minimalista dei morti
viventi non ci ha ricordato forse, quello dei mostri famelici di carne umana
messi in scena l’anno dopo da George Romero?
Quasi completa l’omaggio ai Dottor Frankenstein di Terence Fisher, chissà
perchè è mancato il primo capitolo della serie dedicata all’ambiguo chirurgo
La maschera di Frankenstein (The
curse of Frankenstein, 1957), che ci rivela l’estrema versatilità di
questo regista e il perfetto idillio con l’attore Peter Cushing che ci ha
regalato una serie di interpretazioni si teatrali e sopra le righe, ma mai
disturbante. Con La vendetta di
Frankenstein (The revenge of
Frankestein, 1958) si capisce come questa serie inizi ad entrare
praticamente in competizione con l’altra dedicata a Dracula; un piccolo
gioiello gotico, con il barone scienziato dipinto come un eroe romantico
senza che nessun giudizio morale appesantisca questa piccola grandr
pellicola. La maledizione di
Frankenstein (Frankenstein
created a woman, 1967) da una svolta verso il melodramma alla serie,
in cui il tragico mostro incontra l’altro sesso, ma siamo anni luce dalla
creatura dalle meche elettrificate di Elsa Lanchester ed alcune scelte
stilistiche ci hanno ricordato le strampalate simbologie di un Jesus Franco
o un Jean Rollin. Con Distruggete
Frankenstein! (Frankenstein
must be destroyed, 1969) la regia di Fischer si fa sempre più
classica ed essenziale, così come il volto di Cushing più emaciato e
spettrale. Se il barone apre una clinica per trapianti non è per la ricerca
della felicità e della ricchezza ma per il sacro fuoco della ricerca pura;
chi l’avrà vinta il folle e geniale chirurgo o la mediocrità di coloro che
lo combattono e lo contrastano?
Frankenstein e il mostro dell’inferno (Frankenstein
and the monster from hell, 1974) è la degna conclusione della serie
iniziata più di quindici anni prima, in cui il barone rifugiato in un
manicomio continua a compiere i suoi esperimenti sui pazienti dell’istituto
mentale; un film inedito in Italia, probabilmente non distribuito per un
finale nerissimo, non consolatorio e senza alcuna speranza.
Alberto CASINI