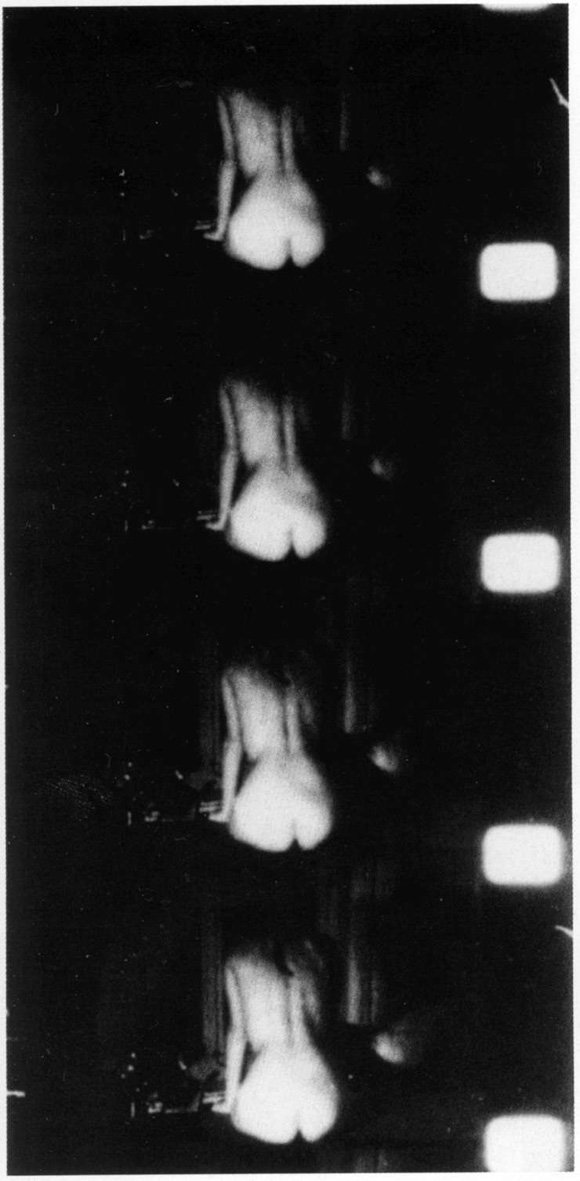|

Report #1
Eccomi sbarcato in grembo alla solita opprimente architettura sabauda,
infine persino piacevole una volta che ti sei abituato alla sensazione di
percorrere una città progettata per persone alte tre metri. Un clima ancora
tiepido, iniezioni d’aria primaverile. Getto un’occhiata alla situazione
logistica del Festival, prima novità: una nuova multisala in funzione, il
Cinema Ambrosio, sporto sull’arteria del Corso Vittorio Emanuele II. Strano
posto quello, in bilico tra un cocktail-bar anni ’80 per dentisti di Miami
Beach e la sala d’attesa di un aeroporto…
Ma comincio a scorrere il programma del festival e già so che il taccuino di
un grafomane qui ha da riempirsi compulsivamente; gli occhi del cinefilo,
pure. L’edizione 2006 si presenta particolarmente ricca, variegata.
Innanzitutto gli appuntamenti “mondani” includono la presentazione della
seconda “stagione” della serie americana horror (già assunta al culto)
“Masters of Horror 2”, con la taumaturgica presenza dal vivo di Dario
Argento e John Landis; la scorsa edizione questa serie ci ha riservato delle
notevoli emozioni, sopratutto grazie alla visione dell’acuto pamphlet
politico di Joe Dante, "Homecoming", dove il mito dello zombie, l’eterno
ritratto scoperto di Dorian Gray o cattiva coscienza collettiva sulla
guerra, veniva piegato all’invettiva contro la presenza militare in Iraq.
Anche questo anno ci aspettiamo delle grandi cose, dai “signori
dell’orrore”…
Nell’ambito dell’importante retrospettiva dedicata a Robert
Aldrich sarà presente la figlia in sala, per parlare dell’iniziativa che
ha visto la famiglia del regista collaborare con l’organizzazione, mettendo
a disposizione un “folto archivio” privato.
Il grande maestro Claude Chabrol, richiamato dalla programmazione
delle seconda parte della lunga retrospettiva a lui dedicata, si sottoporrà
ad un dialogo “socratico” con il logorroico ed arruffatissimo Enrico
Grezzi (speriamo che questi non lo metta (tra parentesi) (come) (suole)
(fare) (nei) (suoi) (scritti). Poi il regista Walter Hill sarà
presente in occasione della sua ultima fatica:
Broken Trail, (id.2006)
ed il leggendario caratterista western Ernest Borgnine, in compagnia
dell’amico Keith Carradine, presenterà un film molto citato ma
pressoché invisibile di Aldrich,
L’imperatore del Nord, 1973.
Le retrospettive collaterali come sempre costituiscono l’occasione per la
sostanziazione del festival stesso. Quest’anno sono da segnalare la
retrospettiva dedicata a Joaquin Jordá, catalano, figura chiave
del cinema europeo contemporaneo e recentemente scomparso, l’omaggio al
cineasta ferocemente sperimentale Piero Bargellini, e l’evento
speciale dedicato ai film restaurati in 8mm della famiglia di celebri
circensi Togni.

Questa mattina ho avuto modo di apprezzare
Monos come becky,
1999, docu-fiction imperniato sulla ricostruzione del profilo del
controverso neurologo Nobel Egas Moniz, ideatore del procedimento
dell’asportazione chirurgica del lobo frontale allo scopo del contenimento
dei malati mentali troppo aggressivi. Il film è interpretato da un attore
che ha subito una lobotomia secondo moderne procedure moderne, e coinvolge i
pazienti di un istituto psichiatrico. Vengono citate le tappe del percorso
del neurologo. Emerge una figura limacciosa, tra smanie di onnipotenza, e
grandeur umanistica. La camera segue i bordi frastagliati di un continuo
sconfinamento della vita degli attori e disegna con intelligenza l’affresco
di una potente indagine sui confini tra malattia e norma, terapia e
autoanalisi…

BROKEN TRAIL
USA 2006, 184'
di Walter Hill
Agli inizi del secolo, ovviamente nell'Ovest degli Stati Uniti cinque
ragazze cinesi vengono vendute come prostitute a un commerciante
statunitense. Il loro percorso si incrocia con quello di Tom e del vecchio
zio Print, che tentano di rifarsi una vita trasportando cavalli per una
grossa somma di denaro.
Non è certo una novità che Hill sia incapace di rassegnarsi alla "morte" del
western. Per fortuna. E per fortuna stavolta la sua testardaggine nel voler
far rivivere un mondo già passato non incappa nelle impasse di, poniamo,
"Ancora vivo".
"Broken Trail" è un film esplicitamente, sfacciatamente, limpidamente
televisivo (d'altronde quella è la destinazione originaria del progetto).
Nella prima parte, in verità, "finge" di voler/poter tornare a una
strutturazione cinematografica tradizionale (non ci azzardiamo a dire
"classica", perché nel caso di Hill la cosa è complicata), e lo fa con una
trovata delle sue, ovvero tirando in ballo il classico "vero", la tragedia
nelle sue forme pure: è pur sempre lui che in "Guerrieri della notte" ha
nascosto dietro a un genere post-classico come quello violento-metropolitano
l'"Anabasi" di Senofonte. Ecco, qui incrementa la portata drammatica
aggiungendo nientemento che il "coro" delle cinque cinesi che saltuariamente
intervengono con i loro interrogativi su ciò che intorno a loro "le agisce"
senza che, per via della lingua, non possano capirci granché.
Poi però con la seconda parte arriva un interprete connazionale e il film
chiarisce meglio le sue carte. Le vedute paesaggistiche, tinte di una
splendida e riappacificata luminosità (anche quando nevica), si fanno sempre
più frequenti, il ritmo si ammorbidisce, l'azione non prova nemmeno ad
essere centrale, l'inseguimento dell'avanzo di galera contro il manipolo di
outsider si palesa un fantoccio narrativo, buono solo a tenere insieme
l'emergere dei caratteri e delle loro storie, nonostante la prima parte
terminasse con un accenno a una possibile deviazione del film verso il
filone "genesi tragica del capitalismo" stile "I cancelli del cielo". Invece
no, tant'è che Tom "diventa grande" quasi per caso e la sua liberazione
dall'inettitudine verso la figura paterna (che Thomas Haden Church esprime
attraverso una geniale reincarnazione di Warren Oates, che era appunto nato
per questo tipo di parti) avviene sparando alle spalle del nemico (e
salvando la vita dello zio) in una scena che quasi non ha preparazione, che
viene sbrogliata in due minuti per passare ad altro: tutto il contrario
dunque della sparatoria finale di "Open range" di Costner, per esempio.
A Hill interessa di più indugiare sullo "spirito dell'epoca", sull'aria
delle praterie e sulla sensazione di 300 cavalli al galoppo - ma tutto
questo non per farne una banale cartolina. Si tratta piuttosto, come Print
ripete tutte le volte che muore qualcuno (che è poi ciò che davvero
scandisce il tempo del film, più che l'azione), del fatto che "viaggiamo
attraversando l'eternità", e nulla come la semplice transitorietà di questi
elementi naturali è in grado di dircelo. Hill, insomma, si arrende ala
televisione e alla "mancanza di tempo lineare" del suo flusso eterno,
statico, e anziché mimare quell'eternità con l'imbalsamazione delle forme
(come in "Ancora vivo") sospende (o quasi) la narrazione e si concentra
sulla tonalità soffusa di tutto ciò che rimane. Solo in questo modo la
malinconia del personaggio di Print, che invade la scena nella seconda parte
diventandone il perno, riesce a non diventare stucchevole né gratuita.
Disillusione senza rassegnazione, né cinismo.
Voto: 26/30

Report #2
Torino, 12:11:2006
Squarci di
Piero Bargellini…
Un cineasta cosiddetto underground, una vita intensa, che inseguiva un’idea
di cinema come visione, come lo sbocciare di una dimensione di alterazione
della pupilla, affiorare di rivelazioni entro la sincope dei salti,
interruzioni, di senso, uno che cercava il cinema con un “misero” 8 mm, 16
mm; ed i corpi di questi suoi film lacerati, feriti ai limiti
dell’intellegibile da decomposizioni chimiche, lacerazioni del corpo
pellicolare, sovraesposizioni, e tutte la altre torture che lo sperimento
inseguito inseguiva, hanno il sapore, oggi, di una presenza attuale, di una
testimonianza affiorata dal sonno, dalla sabbia di un oblio, che tutti
conosciamo.

Dopo aver visto
Dante no es únicamente severo… di Joaquín Jordá, Jacinto Esteva
Grewe.
Un film che è stato collocato all’epicentro di
una nuova generazione di cineasti catalani. Come è stato detto nel corso
della presentazione Jordá è un tassello importante per la conoscenza del
cinema europeo moderno e contemporaneo. E dopo aver visto Dante ne sono
pienamente convinto: film basato sul concetto della divagazione, alla
Godard, di cui recupera, rasentando a volte l’orbita epigonale, tic e
stilemi, ma soprattutto i materiali significanti; attori “giusti”, movimenti
di camera “a pendolo”, disponibilità a rompere la trasparenza narrativa,
etc…
Cosa avviene? Ci sono un uomo ed una donna (tra cui Enrique Irazoqui, che
girerà poi il Vangelo di
Pasolini) che mettono in scena un discorso amoroso che non conduce da
nessuna parte, avvitandosi a spirale. Il vero protagonista è la regia:
assoluta, dittatoriale. Il film termina con un’operazione chirurgica diretta
all’occhio di una bellissima modella (che imbocca retrospettivamente il
senso di diverse violente immissioni dell’immagine di occhio operato).
Metafora fin troppo scoperta.
Ma allora scoperta. Rimbaud, cito a memoria: “ho preso la bellezza
sulle ginocchia, e l’ho ingiuriata”…
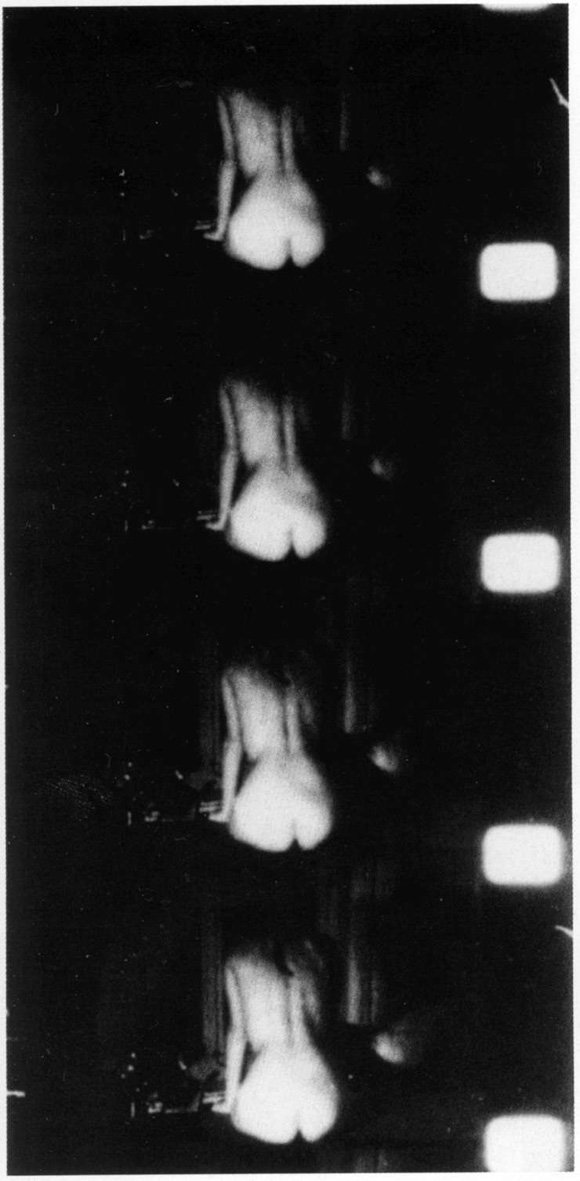

PAVILION SANSHO-UO
Giappone 2006, 98'
di Tominaga Masanori
In Concorso
Kinjiro è una salamandra di più di 150 anni: il suo "debutto in società" lo
fece, giovanissima, in una delle esposizioni universali del secolo XIX. Una
danarosa fondazione è da decenni preposta alla sua salvaguardia. Tobishima è
un giovane radiologo incaricato dalla mafia di scoprire l'autenticità della
salamandra. Ma si innamora della figlia della titolare della fondazione.
Ma c'è qualcosa di più strano di questa trama, ed è l'approccio stilistico
del film. Non certo perché Pavilion
sansho-uo sia una delle mille scatenate bizzarrie camp
giapponesi pieni di trovate stilistiche sopra le righe cui siamo ormai
abituati. No: Pavilion sansho-uo
comincia con toni posatissimi e addirittura seriosi, e tra madri finte e
padri che non ci sono cominciamo a figurarci un affresco iperletterario che
stia per intrecciare un kammerspiel famigliare a metafore anfibie (la
salamandra...) sul cosmo, borioso e pesante.
Poi però le incrinature verso la commedia si moltiplicano, e la regia,
piuttosto funzionale con i suoi lenti movimenti di macchina di calibrata
funzionalità, accoglie mille fessure e altrettante aperture verso l'assurdo.
Il bello però è che il tono mantiene lo stesso la sua solidità impassibile
ed evita sempre accuratamente di sbracare nel grottesco. Anche quando a metà
film senza alcuna ragione il protagonista vende tutto e pur di aiutare la
ragazzina di cui è innamorato si atteggia a reincarnazione di Salvatore
Giuliano, con tanto di picciotti con coppola e lupara, Tominaga "ne prende
atto" e fa continuare il film come quasi niente fosse.
Insomma, Tominaga è bravo (fino al leziosismo) a condurci in una discesa
nell'irreale che non potrebbe essere meno traumatica, anzi pressoché
impercettibile. Abbiamo così una compunta voce over che dopo aver
fatto finta di condurci nelle intricate spire della storia scantona
tranquillamente nel delirio, e in flashback e forward
improvvisi, per poi farsi da parte nell'istante seguente. Come la colonna
sonora, che frequentemente da un secondo all'altro si interrompe bruscamente
e inaspettatamente, il film si fa apprezzare perché è fatto tutto da
scuciture del tessuto che si rimarginano istantaneamente, e riesce così ad
essere stralunato senza averne nemmeno l'aria.
Voto: 26/30

Report #3
Torino, 12:11:2006
Circo Togni Home
Movies
La pelle incespata di uno strano rettile. Delle mani cruente lo
stanno scorticando. Forse. Oppure è avvolto ad una bobina, che lo srotola.
Le squame iridate. O forse è la superficie di un essere marino primordiale,
dal guscio affiltto di mucillagini ed incrostazioni corrosive.
Disorientamento. Poi sovviene la musica, si stacca dal silenzio con un rombo
sordo che si ripercuote e rimbomba entro i gradi più liminari della gamma
auditiva, mimando quella forma informe: la sussume. E’ come un indovinello
senza chiave. Finché dall’impossibile cruciverba d’immagini masticate o
lacerate espode qualcosa: denotazione di fauci ferine. La testa animale
viene riassorbita dalla scia impetuosa di colori cauterizzati. Tutto
finisce, mentre il flusso musicale asseconda e dirige lo sguardo. Compare un
uomo, è prestante, è sorridente, è il forzuto di un circo, perché entra
senza timore in una gabbia, impone senza battere ciglio degli esercizi ad
una tigre, e flette i suoi muscoli. Poi il tendone: un cielo lunare di garza
solcato dai corpi nervosi di acrobati che si esercitano al trapezio. Il
forzuto, un po’ Douglas Fairbanks, un po’ Valentino, gioca con un bambino,
certo suo figlio; nel campo visivo entra una donna, fa l’occhiolino; certo
sua moglie. Lo scenario è ben chiaro ora: il Circo, tradotto da una vulgata
visiva che ne è l’affidabile terreno comune. Ma questo non è un film comune,
è un reperto intimo, contiene vertigini, bestie e sorrisi rivolti ad amici,
amanti, famigliari. La musica scheletrica cresce, instilla pozzanghere di
echi spettrali in cui nuota qualcosa, un tormento ossessivo, che sfocia in
un geyser di white noise; germina inseguendo le immagini. Compare una
scritta: “Circo Togni, Darix”. La vita nei carrozzoni si snoda per percorsi
lontani, compaiono strade e piazze affollate di città straniere. Darix
accoglie una processione di gente all’interno del suo circo. Nel frattempo
un weekend di surreale “normalità”, i pachidermi che fanno il bagno mentre
la mamma si rosola al sole. Vedo la routine, i tirocini degli acrobati, dei
giocolieri, un viaggio in areo, un viaggio in nave, un elefante imbracato
che viene calato dall’alto mentre scalcia. Infine la lunga trasversata delle
montagne, le Alpi?, di un intero caravanserraglio (mi viene spiegato
all’orecchio che si tratta di una strategia pubblitaria, emulare l’impresa
di Annibale ripercorrendone il tragitto). Tornano le luci spazzando via quei
volti di eroi già così dolcemente famigliari. Seconda parte: il“carosello”
ambientato in un circo, dove un ispettore da operetta dà la caccia
all’assassino e smaschera il clown Bongo, che aveva svuotato del mercurio
giroscopico l’asta della trapezista. Infine tenta di venderci della
brillantina. I Togni ne avevano conservata una copia per farci su quattro
risate… Non ne avevano bisogno comunque, facevano già una vita magnifica….
L’associazione "Homemovies" gestisce e cura l’Archivio Nazionale del
Film di Famiglia, avamposto etico dedicato alla salvaguardia e alla
valorizzazione dei filmati famigliari, diari visivi e realizzazioni intime,
come possibile fonte futura di preziose testimonianze storica. Un giorno i
gestori vengono contattati dalla leggendaria famiglia circense dei Togni.
Dentro un carrozzone, esposto ad ogni intemperie, giace scempiato, forse in
maniera irrimediabile, il patrimonio degli 8mm di famiglia. In
collaborazione con il laboratorio di restauro
“La camera ottica”
dell’Università di Udine nasce il progetto di recuperare le pellicole
superstiti, dal contenuto di sicuro interesse. L’impresa riesce e viene
quindi deciso di mostrare un ri-montaggio dei film recuperati nella
Sezione “Latitudini” del Festival di Torino con l’accompagnamento di una
sonorizzazione estemporanea di Stefano Pilia. Il risultato è
un’ibridazione notevole, l’incontro “aurale” sospeso tra immagini che
contengono squarci di rara bellezza e l’esecuzione, irripetibile ed
ispirata, di Pilia.


MANORO
Filippine 2006, 75'
di Brillante Mendoza
In Concorso
Jonalyn è una ragazzina che insegna agli abitanti di sperduti villaggi
filippini a scrivere. Un compito particolarmente importante in vista delle
elezioni presidenziali, in occasione delle quali tenta di raggiungere
(insieme al padre) il nonno, che abita piuttosto lontano, per far sì che
anche lui possa votare. Ma il nonno preferisce andare a caccia di cinghiali.
Manoro è un esempio di
particolare "felicità" d'uso della telecamerina digitale, usata con notevole
versatilità espressiva per rendere il meno "legnosa" possibile la
sovrapposizione di fiction e documentario. Sovrapposizione inevitabile in
casi come questo, in cui gran parte delle intenzioni e della credibilità del
progetto si reggono sull'affidabilità documentaria del resoconto
sull'ambiente in questione. E in questo senso funziona piuttosto bene, il
contesto "rural-forestale" dell'entroterra filippino è dipinto con
un'efficacia e un'immediatezza di tutto rispetto.
L'azione e la descrizione del contesto sono intrecciate strette fino a
frantumarsi a vicenda, e i limiti angusti della "singola scena" o sequenza
debordano verso un accumulo annaspante di dettagli strappati all'una e
all'altra.
Una caoticità ricercata che però non è incoerenza e non sacrifica la
leggibilità che viene ad assumere l'insieme come il singolo dettaglio.
L'articolazione dei dati raccolti dalla telecamera, poi, lascia
sufficientemente aperto il dissidio tra "ruvidità" ingovernabile
dell'oggetto in questione (un intero mondo sociale "sommerso") e
rielaborazione linguistica: basti pensare alla lunga parentesi centrale in
cui Jonalyn e il padre attraversano a piedi (spesso a piedi nudi) la
foresta, una pausa narrativa (non succede nulla, solo una lunga marcia)
integralmente votata alla difficoltà delle condizioni in cui si trovano i
due. Proprio come Jonalyn, Manoro
rincorre un'alfabetizzazione del reale perdente in partenza, ma non inutile.
Lo sguardo esibisce la propria difficoltà a farsi strada in un ambiente
concretissimo, compatto e sovrastante, che ha sempre l'ultima parola. Ma non
per questo si arrende.
Voto: 26/30
Torino, 15:11:2006, in corso.. |