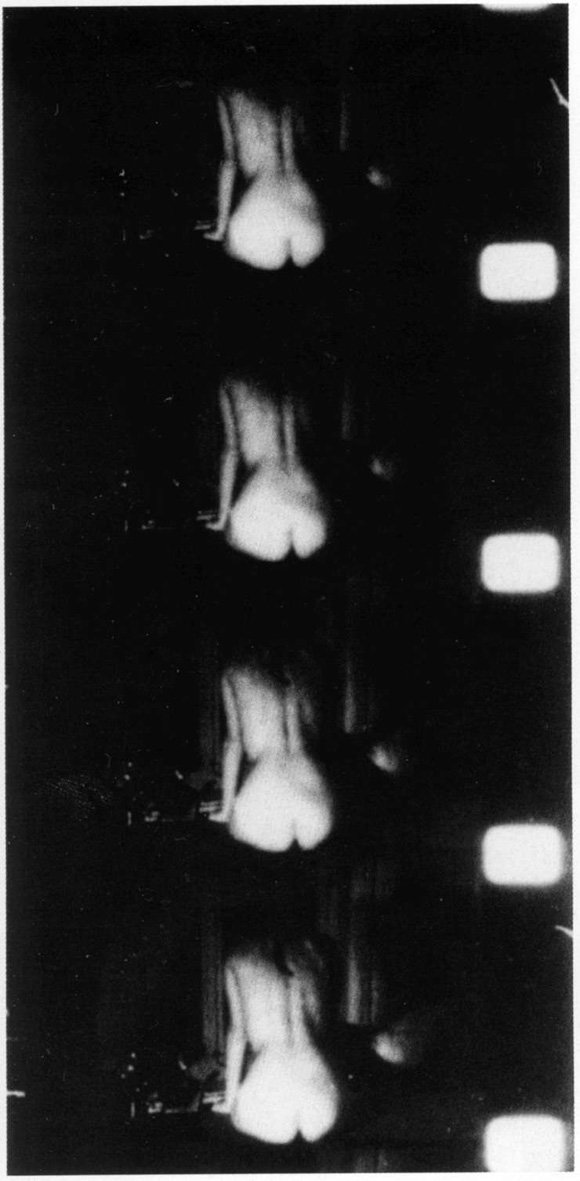|

Report #1
Eccomi sbarcato in grembo alla solita opprimente architettura sabauda,
infine persino piacevole una volta che ti sei abituato alla sensazione di
percorrere una città progettata per persone alte tre metri. Un clima ancora
tiepido, iniezioni d’aria primaverile. Getto un’occhiata alla situazione
logistica del Festival, prima novità: una nuova multisala in funzione, il
Cinema Ambrosio, sporto sull’arteria del Corso Vittorio Emanuele II. Strano
posto quello, in bilico tra un cocktail-bar anni ’80 per dentisti di Miami
Beach e la sala d’attesa di un aeroporto…
Ma comincio a scorrere il programma del festival e già so che il taccuino di
un grafomane qui ha da riempirsi compulsivamente; gli occhi del cinefilo,
pure. L’edizione 2006 si presenta particolarmente ricca, variegata.
Innanzitutto gli appuntamenti “mondani” includono la presentazione della
seconda “stagione” della serie americana horror (già assunta al culto)
“Masters of Horror 2”, con la taumaturgica presenza dal vivo di Dario
Argento e John Landis; la scorsa edizione questa serie ci ha riservato delle
notevoli emozioni, sopratutto grazie alla visione dell’acuto pamphlet
politico di Joe Dante, "Homecoming", dove il mito dello zombie, l’eterno
ritratto scoperto di Dorian Gray o cattiva coscienza collettiva sulla
guerra, veniva piegato all’invettiva contro la presenza militare in Iraq.
Anche questo anno ci aspettiamo delle grandi cose, dai “signori
dell’orrore”…
Nell’ambito dell’importante retrospettiva dedicata a Robert
Aldrich sarà presente la figlia in sala, per parlare dell’iniziativa che
ha visto la famiglia del regista collaborare con l’organizzazione, mettendo
a disposizione un “folto archivio” privato.
Il grande maestro Claude Chabrol, richiamato dalla programmazione
delle seconda parte della lunga retrospettiva a lui dedicata, si sottoporrà
ad un dialogo “socratico” con il logorroico ed arruffatissimo Enrico
Ghezzi (speriamo che questi non lo metta (tra parentesi) (come) (suole)
(fare) (nei) (suoi) (scritti). Poi il regista Walter Hill sarà
presente in occasione della sua ultima fatica:
Broken Trail, (id.2006)
ed il leggendario caratterista western Ernest Borgnine, in compagnia
dell’amico Keith Carradine, presenterà un film molto citato ma
pressoché invisibile di Aldrich,
L’imperatore del Nord, 1973.
Le retrospettive collaterali come sempre costituiscono l’occasione per la
sostanziazione del festival stesso. Quest’anno sono da segnalare la
retrospettiva dedicata a Joaquin Jordá, catalano, figura chiave
del cinema europeo contemporaneo e recentemente scomparso, l’omaggio al
cineasta ferocemente sperimentale Piero Bargellini, e l’evento
speciale dedicato ai film restaurati in 8mm della famiglia di celebri
circensi Togni.

Questa mattina ho avuto modo di apprezzare
Monos come becky,
1999, docu-fiction imperniato sulla ricostruzione del profilo del
controverso neurologo Nobel Egas Moniz, ideatore del procedimento
dell’asportazione chirurgica del lobo frontale allo scopo del contenimento
dei malati mentali troppo aggressivi. Il film è interpretato da un attore
che ha subito una lobotomia secondo moderne procedure moderne, e coinvolge i
pazienti di un istituto psichiatrico. Vengono citate le tappe del percorso
del neurologo. Emerge una figura limacciosa, tra smanie di onnipotenza, e
grandeur umanistica. La camera segue i bordi frastagliati di un continuo
sconfinamento della vita degli attori e disegna con intelligenza l’affresco
di una potente indagine sui confini tra malattia e norma, terapia e
autoanalisi…

BROKEN TRAIL
di Walter Hill
USA 2006, 184'
Agli inizi del secolo, ovviamente nell'Ovest degli Stati Uniti cinque
ragazze cinesi vengono vendute come prostitute a un commerciante
statunitense. Il loro percorso si incrocia con quello di Tom e del vecchio
zio Print, che tentano di rifarsi una vita trasportando cavalli per una
grossa somma di denaro.
Non è certo una novità che Hill sia incapace di rassegnarsi alla "morte" del
western. Per fortuna. E per fortuna stavolta la sua testardaggine nel voler
far rivivere un mondo già passato non incappa nelle impasse di, poniamo,
"Ancora vivo".
"Broken Trail" è un film esplicitamente, sfacciatamente, limpidamente
televisivo (d'altronde quella è la destinazione originaria del progetto).
Nella prima parte, in verità, "finge" di voler/poter tornare a una
strutturazione cinematografica tradizionale (non ci azzardiamo a dire
"classica", perché nel caso di Hill la cosa è complicata), e lo fa con una
trovata delle sue, ovvero tirando in ballo il classico "vero", la tragedia
nelle sue forme pure: è pur sempre lui che in "Guerrieri della notte" ha
nascosto dietro a un genere post-classico come quello violento-metropolitano
l'"Anabasi" di Senofonte. Ecco, qui incrementa la portata drammatica
aggiungendo nientemento che il "coro" delle cinque cinesi che saltuariamente
intervengono con i loro interrogativi su ciò che intorno a loro "le agisce"
senza che, per via della lingua, non possano capirci granché.
Poi però con la seconda parte arriva un interprete connazionale e il film
chiarisce meglio le sue carte. Le vedute paesaggistiche, tinte di una
splendida e riappacificata luminosità (anche quando nevica), si fanno sempre
più frequenti, il ritmo si ammorbidisce, l'azione non prova nemmeno ad
essere centrale, l'inseguimento dell'avanzo di galera contro il manipolo di
outsider si palesa un fantoccio narrativo, buono solo a tenere insieme
l'emergere dei caratteri e delle loro storie, nonostante la prima parte
terminasse con un accenno a una possibile deviazione del film verso il
filone "genesi tragica del capitalismo" stile "I cancelli del cielo". Invece
no, tant'è che Tom "diventa grande" quasi per caso e la sua liberazione
dall'inettitudine verso la figura paterna (che Thomas Haden Church esprime
attraverso una geniale reincarnazione di Warren Oates, che era appunto nato
per questo tipo di parti) avviene sparando alle spalle del nemico (e
salvando la vita dello zio) in una scena che quasi non ha preparazione, che
viene sbrogliata in due minuti per passare ad altro: tutto il contrario
dunque della sparatoria finale di "Open range" di Costner, per esempio.
A Hill interessa di più indugiare sullo "spirito dell'epoca", sull'aria
delle praterie e sulla sensazione di 300 cavalli al galoppo - ma tutto
questo non per farne una banale cartolina. Si tratta piuttosto, come Print
ripete tutte le volte che muore qualcuno (che è poi ciò che davvero
scandisce il tempo del film, più che l'azione), del fatto che "viaggiamo
attraversando l'eternità", e nulla come la semplice transitorietà di questi
elementi naturali è in grado di dircelo. Hill, insomma, si arrende ala
televisione e alla "mancanza di tempo lineare" del suo flusso eterno,
statico, e anziché mimare quell'eternità con l'imbalsamazione delle forme
(come in "Ancora vivo") sospende (o quasi) la narrazione e si concentra
sulla tonalità soffusa di tutto ciò che rimane. Solo in questo modo la
malinconia del personaggio di Print, che invade la scena nella seconda parte
diventandone il perno, riesce a non diventare stucchevole né gratuita.
Disillusione senza rassegnazione, né cinismo.
Voto: 26/30

Report #2
Torino, 12:11:2006
Squarci di
Piero Bargellini…
Un cineasta cosiddetto underground, una vita intensa, inseguendo un’idea di
cinema come visione, come lo sbocciare di una dimensione d’alterazione della
pupilla, affiorare di rivelazioni entro la sincope dei salti, interruzioni
di senso, uno che cercava un cinema nel raggio d’azione del corpo e della
memoria esplorando le combinatorie di possibilità aperte da un “misero” 8
mm, oppure un 16 mm; ed i corpi di questi suoi film lacerati: feriti ai
limiti dell’intellegibile da decomposizioni chimiche, lacerazioni del corpo
pellicolare, sovraesposizioni, e tutte le altre torture che l’esperimento
inseguiva, hanno il sapore, oggi, di una presenza attuale, di una
testimonianza affiorata dal sonno, dalla sabbia di un oblio che tutti ancora
conosciamo. Ricordi dal futuro.

Dopo aver visto
Dante no es únicamente severo… di Joaquín Jordá, Jacinto Esteva
Grewe.
Un film che è stato collocato all’epicentro di
una nuova generazione di cineasti catalani. Come è stato detto nel corso
della presentazione della retrospettiva (c’è tanfo di necrologio a Torino)
Jordá è un tassello importante per la conoscenza del cinema europeo moderno
e contemporaneo. E dopo aver visto Dante ne sono pienamente convinto: film
basato sul concetto della divagazione, alla Godard, di cui recupera,
rasentando a volte l’orbita epigonale, tic e stilemi, ma soprattutto i
materiali significanti; attori “giusti”, movimenti di camera “a pendolo”,
disponibilità a rompere la trasparenza narrativa, attitudine a rompere la
disposizione dell’inquadratura, autocitazione, etc…
Cosa avviene? Ci sono un uomo ed una donna (tra cui Enrique Irazoqui che
girerà poi il Vangelo di Pasolini) che mettono in scena un discorso amoroso
che non conduce da nessuna parte, avvitandosi a spirale. Il vero
protagonista è la regia: assoluta, dittatoriale. Il film termina con
un’operazione chirurgica diretta all’occhio di una bellissima modella (che
imbocca retrospettivamente il senso di diverse violente immissioni
dell’immagine di un occhio operato).
Metafora fin troppo scoperta. Ma allora scoperta. Rimbaud, cito a memoria,
chiedo venia: “ho preso la bellezza sulle ginocchia, e l’ho ingiuriata”…
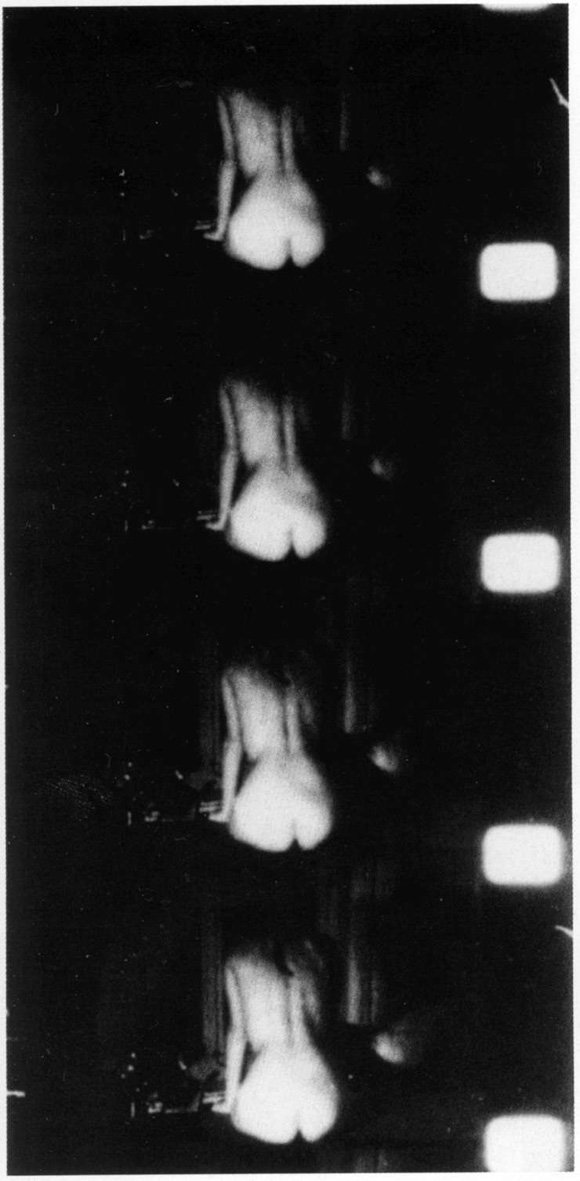

PAVILION SANSHO-UO
di Tominaga Masanori
Giappone 2006, 98'
In Concorso
Kinjiro è una salamandra di più di 150 anni: il suo "debutto in società" lo
fece, giovanissima, in una delle esposizioni universali del secolo XIX. Una
danarosa fondazione è da decenni preposta alla sua salvaguardia. Tobishima è
un giovane radiologo incaricato dalla mafia di scoprire l'autenticità della
salamandra. Ma si innamora della figlia della titolare della fondazione.
Ma c'è qualcosa di più strano di questa trama, ed è l'approccio stilistico
del film. Non certo perché Pavilion
sansho-uo sia una delle mille scatenate bizzarrie camp
giapponesi pieni di trovate stilistiche sopra le righe cui siamo ormai
abituati. No: Pavilion sansho-uo
comincia con toni posatissimi e addirittura seriosi, e tra madri finte e
padri che non ci sono cominciamo a figurarci un affresco iperletterario che
stia per intrecciare un kammerspiel famigliare a metafore anfibie (la
salamandra...) sul cosmo, borioso e pesante.
Poi però le incrinature verso la commedia si moltiplicano, e la regia,
piuttosto funzionale con i suoi lenti movimenti di macchina di calibrata
funzionalità, accoglie mille fessure e altrettante aperture verso l'assurdo.
Il bello però è che il tono mantiene lo stesso la sua solidità impassibile
ed evita sempre accuratamente di sbracare nel grottesco. Anche quando a metà
film senza alcuna ragione il protagonista vende tutto e pur di aiutare la
ragazzina di cui è innamorato si atteggia a reincarnazione di Salvatore
Giuliano, con tanto di picciotti con coppola e lupara, Tominaga "ne prende
atto" e fa continuare il film come quasi niente fosse.
Insomma, Tominaga è bravo (fino al leziosismo) a condurci in una discesa
nell'irreale che non potrebbe essere meno traumatica, anzi pressoché
impercettibile. Abbiamo così una compunta voce over che dopo aver
fatto finta di condurci nelle intricate spire della storia scantona
tranquillamente nel delirio, e in flashback e forward
improvvisi, per poi farsi da parte nell'istante seguente. Come la colonna
sonora, che frequentemente da un secondo all'altro si interrompe bruscamente
e inaspettatamente, il film si fa apprezzare perché è fatto tutto da
scuciture del tessuto che si rimarginano istantaneamente, e riesce così ad
essere stralunato senza averne nemmeno l'aria.
Voto: 26/30

MANORO
di Brillante Mendoza
Filippine 2006, 75'
In Concorso
Jonalyn è una ragazzina che insegna agli abitanti di sperduti villaggi
filippini a scrivere. Un compito particolarmente importante in vista delle
elezioni presidenziali, in occasione delle quali tenta di raggiungere
(insieme al padre) il nonno, che abita piuttosto lontano, per far sì che
anche lui possa votare. Ma il nonno preferisce andare a caccia di cinghiali.
Manoro è un esempio di
particolare "felicità" d'uso della telecamerina digitale, usata con notevole
versatilità espressiva per rendere il meno "legnosa" possibile la
sovrapposizione di fiction e documentario. Sovrapposizione inevitabile in
casi come questo, in cui gran parte delle intenzioni e della credibilità del
progetto si reggono sull'affidabilità documentaria del resoconto
sull'ambiente in questione. E in questo senso funziona piuttosto bene, il
contesto "rural-forestale" dell'entroterra filippino è dipinto con
un'efficacia e un'immediatezza di tutto rispetto.
L'azione e la descrizione del contesto sono intrecciate strette fino a
frantumarsi a vicenda, e i limiti angusti della "singola scena" o sequenza
debordano verso un accumulo annaspante di dettagli strappati all'una e
all'altra.
Una caoticità ricercata che però non è incoerenza e non sacrifica la
leggibilità che viene ad assumere l'insieme come il singolo dettaglio.
L'articolazione dei dati raccolti dalla telecamera, poi, lascia
sufficientemente aperto il dissidio tra "ruvidità" ingovernabile
dell'oggetto in questione (un intero mondo sociale "sommerso") e
rielaborazione linguistica: basti pensare alla lunga parentesi centrale in
cui Jonalyn e il padre attraversano a piedi (spesso a piedi nudi) la
foresta, una pausa narrativa (non succede nulla, solo una lunga marcia)
integralmente votata alla difficoltà delle condizioni in cui si trovano i
due. Proprio come Jonalyn, Manoro
rincorre un'alfabetizzazione del reale perdente in partenza, ma non inutile.
Lo sguardo esibisce la propria difficoltà a farsi strada in un ambiente
concretissimo, compatto e sovrastante, che ha sempre l'ultima parola. Ma non
per questo si arrende.
Voto: 26/30

Report #3
Torino, 12:11:2006
Circo Togni Home
Movies
La pelle incespata di uno strano rettile. Delle mani cruente lo
stanno scorticando. Forse. Oppure è avvolto ad una bobina che lo srotola. Le
squame iridate. Oppure la superficie di un essere marino primordiale, dal
guscio affiltto di mucillagini ed incrostazioni corrosive. Disorientamento.
Poi sovviene la musica, si stacca dal silenzio con un rombo sordo che si
ripercuote e rimbomba entro i gradi più liminari della gamma auditiva,
mimando quella forma informe: la sussume. E’ come un indovinello senza
chiave. Finché dall’impossibile cruciverba d’immagini masticate o lacerate
esplode qualcosa: denotazione di fauci ferine. La testa animale viene
riassorbita dalla scia impetuosa di colori cauterizzati. Tutto finisce,
mentre il flusso musicale asseconda e dirige lo sguardo. Compare un uomo, è
prestante, è sorridente, è il forzuto di un circo, perché entra senza timore
in una gabbia ed impone senza battere ciglio degli esercizi ad una tigre,
flette i suoi muscoli. Poi il tendone: un cielo lunare di garza solcato dai
corpi nervosi di acrobati che si esercitano al trapezio. Il forzuto, un po’
Douglas Fairbanks, un po’ Valentino, gioca con un bambino, certo suo figlio;
nel campo visivo entra una donna, fa l’occhiolino; certo sua moglie. Lo
scenario è ben chiaro ora: il Circo, tradotto da una vulgata visiva che ne è
l’affidabile terreno comune. Ma questo non è un film comune: è un reperto
intimo che pur contiene vertigini, bestie feroci e sorrisi rivolti ad amici,
amanti, famigliari. La musica scheletrica cresce, instillando pozzanghere
d’echi spettrali in cui nuota qualcosa, un tormento ossessivo, che sfocia in
un geyser di white noise, sale, germina inseguendo le immagini. Compare una
scritta: “Circo Togni, Darix”. La vita nei carrozzoni si snoda per percorsi
di orizzonti lontani, compaiono strade e piazze affollate in città
straniere. Darix accoglie una processione di gente all’interno del suo
circo. Nel frattempo un weekend di surreale “normalità” con i pachidermi che
fanno il bagno mentre la mamma si rosola al sole. Vedo la routine, i
tirocini degli acrobati, dei giocolieri, un viaggio in aereo, un viaggio in
nave, un elefante imbracato che viene calato dall’alto mentre scalcia.
Infine la lunga traversata delle montagne (le Alpi?) di un intero
caravanserraglio (mi viene spiegato all’orecchio che si tratta di una
strategia pubblicitaria: emulare l’impresa di Annibale ripercorrendone il
tragitto). Tornano le luci che spazzano via quei volti eroici già così
dolcemente famigliari. Seconda parte della proiezione: un “carosello”
ambientato in un circo dove un ispettore da operetta dà la caccia
all’assassino della trapezista e rapidamente smaschera il clown “Bongo” che
aveva svuotato del mercurio giroscopico l’asta della suddetta trapezista.
Infine l’ispettore tenta istericamente di venderci della brillantina. I
Togni ne conservavano copia per farci su quattro risate. Non ne avevano
bisogno, comunque, di risate; conducevano già una vita più che magnifica….
L’associazione di Bologna "Home Movies" gestisce e cura l’Archivio
Nazionale del Film di Famiglia, avamposto etico dedicato alla salvaguardia e
alla valorizzazione dei filmati famigliari, diari visivi ed altre
realizzazioni intime, come possibile fonte futura di preziose testimonianze
storica. Un giorno i gestori vengono contattati dalla leggendaria famiglia
circense dei Togni. Dentro un carrozzone, esposto ad ogni intemperie, giace
scempiato, forse in maniera irrimediabile, il patrimonio degli 8mm di
famiglia. In collaborazione con il laboratorio di restauro “La
camera ottica” dell’Università di Udine nasce il progetto di
recuperare le pellicole superstiti, dal contenuto di sicuro interesse.
L’impresa riesce e viene quindi deciso di mostrare un ri-montaggio dei film
recuperati nella sezione “Latitudini” del Festival di Torino con
l’accompagnamento di una sonorizzazione estemporanea di Stefano Pilia.
Il risultato è un’ibridazione notevole, incontro “aurale” sospeso tra
immagini che contengono squarci di rara bellezza e l’esecuzione,
irripetibile ed ispirata, di Pilia.


Altre visioni
di Marco GROSOLI
ELEGY OF LIFE
di Aleksander Sokurov
Russia, 2006, 110'
Detours
Ci troviamo davvero davanti a un cosiddetto "documentario"? Ha ancora senso
una classificazione del genere, se mai ne ha avuta una? Questo film potrebbe
chiamarsi non meno appropriatamente "argilla" o "respiro" o "acqua"... viene
in mente anzi che in svedese "film" si dice "Bio", "vita", e pochi film come
questi meriterebbero un nome così sublimemente ambiguo.
Sokurov ci racconta il leggendario musicista Rostropovich e l'altrettanto
leggendaria moglie, Galina Vishnevskaya, cantante lirica. Li intervista, li
filma, commenta come al solito con la sua voce inconfondibile, divaga, si
ritaglia licenze poetiche inaudite.
Non si riesce però a dire che compia un "ritratto" della grande coppia,
perché Elegy of life è un
canto liberissimo e straziante su ciò che eccede la forma, e in quanto tale
"scioglie" la propria stessa forma in un'eterogeneità fluida e avvolgente di
materiali e di ipotesi affabulatorie: se ritratto è, non lo è di un oggetto
ma di quell'invisibile che fluttua intorno all'oggetto, imprendibile.
Quell'invisibile che la Vishnevskaya stessa dice cuore e obiettivo di ogni
efficacia musicale. Disciplina e rigore, rigore e disciplina: questi (come
spesso insiste Sokurov) i pilastri della grandezza dei due musicisti - ma la
cinepresa si focalizza più ancora che sulla eccezionale padronanza tecnica
dei due sull'eccesso espressivo naturale, fisiologico che le loro figure
umane incarnano proprio grazie al dominio sovrano sulla tecnica ("Un russo è
troppo di tutto" dice la Vishnevskaya). Non la forma, di cui Rostropovich e
consorte sono i Re, ma ciò che la eccede: ovvero loro stessi in quanto
uomini di carne e sangue, il loro misterioso abitare il terreno
incollocabile della "vita", irriducibile a ogni forma.
è ciò che una volta si
chiamava "aura" (nel senso di Benjamin), e che ora, persa ogni pretesa di
valore differenziale, consiste in quel misterioso dispendio fisico oltre la
forma, che Sokurov sa catturare nel gigioneggiare scoordinato di
Rostropovich mentre suona un carillon (e va fuori tempo!) o mentre
improvvisa una danza folle in un ricevimento di lusso, quando la moglie
racconta con un misto sconvolgente di partecipazione e glacialità della
morte del figlio, in due occhi amletici che ci guardano da una foto, in
un'improvvisa scena di tenerezza tra i due anziani nella serata in loro
onore in presenza del "bel mondo" di metà del pianeta. Il film, per Sokurov,
non è pellicola, ma una specie di vapore che emana dalle forme catturate
dalla cinepresa. E infatti è innanzitutto
Elegy of life come film a
dissolversi, perché si lascia sbandare tra un vorticoso montaggio alternato
dei due musicisti ognuno intento al proprio strumento, un'incursione
enigmatica nei materiali di repertorio (un film girato dalla Vishnevskaya
decenni fa, che custodirebbe tra le pieghe delle sua recitazione la sostanza
stessa del suo essere), una curiosa ispezione degli oggetti della loro
(incredibile) casa, e mille altre schegge che si richiamano l'un l'altra. E
si richiamano, si badi, non per costruire un ritratto, ma per sciogliersi,
insieme all'oggetto che si "finge" di ritrarre, in quell'unico impalpabile
transito verso l'invisibile che è la vita.
Voto: 30/30
LE TOMBEAU
D'ALEXANDRE
di Chris Marker
Francia, 1993, 120'
Proiezione Speciale

Uno dei più begli omaggi a un cineasta mai
fatti. Marker (insuperabile in questo tipo di operazioni: si ricordi il suo
straziante documentario su Tarkovskij) finge di scrivere una serie di
lettere al cineasta russo Aleksander Medvedkin, morto quattro anni prima
nell'anno chiave 1989, la tomba dell'utopia sovietica. Tutto si regge su un
geniale parallelismo tra la vita del cineasta e la storia russa del '900:
Marker inanella un complesso intreccio di cinema, biografia e storia,
conducendoci per mano in un territorio che non è nessuna di queste
categorie, ma è puro linguaggio, un regno inabitabile dell'astrazione che
attraverso una serie di corrispondenze perverse pare determinare le sorti di
tutto, tirando le redini da chissà quale cielo inattingibile. Tant'è che, in
un presente come quello russo immediatamente successivo alla Perestroijka,
dove la Terra coincide con l'inferno delle code per il pane che non c'è, lo
squarcio di speranza è dato da un atto reale di linguaggio, ovvero da un
film: quel La felicità che è
il capolavoro di Medvedkin e che è una diretta emanazione di quel fervore
rivoluzionario (data pochi anni dopo il "mitico" 1917), sincero e di
schiettissima buona fede, che è sempre stato il segno distintivo del
carattere del cineasta sovietico. L'utopia muore ma il linguaggio resta.
La felicità è dunque il
dispiegarsi esplosivo del momento utopico (la Rivoluzione) in forma di film,
di scintilla miracolosa che fa incontrare il linguaggio e il reale, e a cui
segrete corrispondenze (rintracciare le quali è il grande genio di Marker)
obbligheranno a ritornare ogniqualvolta la pretesa di realismo cozzerà
violentemente con la finzione che è la società (Medvedkin stesso che pochi
anni dopo La felicità va in
giro per la Russia su un treno a documentare il reale e si scontra con il
lato oscuro dell'utopia socialista) o quando il sogno della finzione si
scontra con il grigio pragmatismo dei burocrati (ancora Medvedkin che in
seguito gira commedie geniali bocciate dalla censura). Quel trattore
inceppato e poi miracolosamente aggiustato dall'onnipotenza staliniana,
topos di moltissimi film di propaganda dell'era Stalin, viene ritrovato
"a posteriori" proprio in La
felicità decenni prima con una funzione diametralmente opposta:
l'immensa suggestione di Le tombeau
d'Alexandre sta proprio nel saper tracciare di continuo
corrispondenze come queste, che ci fanno intravedere la consustanzialità
misteriosamente linguistica di storia, cinema e vita. La storia come
sviluppo inevitabilmente imperfetto di un'esplosione utopica che nella sua
raggiante perfezione entusiasta ha già tutto dentro di sé, proprio come
La felicità è condannato come
film a contenere tutta l'ansimante opera successiva del proprio autore.
Epifania improvvisa e conchiusa in sé di ciò che il futuro non può che
condannare a forme dialettiche e conflittuali. Ma è proprio questa epifania
a rimanere testimonianza per i posteri:
La felicità è ancora pronto a dispiegarsi davanti ai nostri occhi
disillusi.
Voto: 30/30 e lode
BLED NUMBER ONE
di Rabah Ameur-Zaimeche
Algeria, 2006, 97'
In Concorso
Kamel è un giovane algerino che dopo un periodo di permanenza in Francia
torna in patria. Non tarderà a scontrarsi con un retroterra fondamentalista
pericoloso, ma anche con chi si oppone apertamente ai fondamentalisti pur
tenendosi ambiguamente legato alla tradizione. E' il caso del suo amico di
infanzia e dirimpettaio che massacra di botte la sorella perché si è fatta
lasciare dal marito.
Ne esce un quadro di sconsolata rassegnazione, un senso di impotenza che
viene fatto scorrere su languide cadenze blues. L'ostentata lentezza e la
rigida lontananza dell'azione fanno da cornice a un cupissimo, irreversibile
scivolare nella marginalità. Una amarissima presa di coscienza che il
territorio (al centro della preoccupazioni formali del regista, attentissimo
alla flagranza del set) è il teatro di un'inafferrabile condanna, anche
quando si crede di sentirsi a casa. La calorosa (per quanto agghiacciante)
ritualità della mattanza, e i simili frequenti momenti forti di appartenenza
collettiva, finiscono per lasciare il posto a un misterioso occidentale che
suona una mestissima chitarra in campo lungo in riva a un lago, al canto
disperato degli ospiti del manicomio in cui viene rinchiusa la ragazza
abbandonata dal marito. Un senso paralizzante di orfananza, resto piuttosto
bene dal dipanarsi delle scene, anodino e incurante della sintesi, e dal
tangibilissimo disagio della cinepresa, che pare "temere" la centralità
fisica dell'azione e sembra costretta a ripiegare sulla discrasia spaziale e
visiva tra l'azione e l'ambiente.
Voto: 27/30
BIG BANG LOVE, JUVENILE A
di Miike Takashi
Giappone, 2006, 85'
Fuori Concorso

L'amore tra i due giovani detenuti Jun e Shiro continua anche quando
quest'ultimo muore, forse ucciso proprio dall'amante. Già, perché in carcere
il tempo non esiste. È un luogo senza futuro popolato da gente il cui
passato è una strada sbarrata che porta al vicolo cieco del presente. La
vita, per loro (solo per loro? Il sinistro e disilluso direttore del carcere
non parrebbe di questo avviso), non è una linea retta da percorrere, ma una
successione inerte di istanti pesanti e sempre uguali, senza scampo.
Miike lo capisce alla perfezione e si inventa un linguaggio visivo
scrupolosamente ad hoc: l'assenza (“carceraria”) del tempo corrisponde
all'assenza dello spazio. Il buio domina completamente lo scena, interrotto
solo da sporadiche chiazze di luce; in questo modo non sembrano esserci
“stanze” a contenere i personaggi, e similmente la macchina da presa anziché
tessere relazioni tra gli elementi compresenti nello spazio affastella
“vedute” (spesso in dettaglio) prese liberamente da punti di vista
radicalmente divergenti tra loro. La claustrofobia del prison-movie
viene stravolta in uno spazio tutto mentale e astratto, bucherellato in
continuazione da inserti onirici, squarci simbolici e parentesi sul “mondo
normale” su cui pare gravare la medesima condanna alla monotonia del
carcere. L'indagine dei due poliziotti sulla morte di Shiro perde la sua
dinamica cadenza lineare (grazie soprattutto alla frequente sostituzione
delle loro domande mediante didascalie in sovrimpressione) in favore di una
lenta e ieratica staticità che informa il'umore generale del film. Non un
giallo, che esige un inizio e una conclusione, ma una litania senza fine né
principio di “diapositive” che cantano il dolore di un mondo per sempre
chiuso nella propria irrealizzabilità.
Non potrebbe essere altrimenti: l'amore folle tra Jun e Shiro si configura
da subito come troppo eterno, troppo assoluto per una consumabilità terrena
(che non ci viene mostrata), troppo al di là della vita e della morte,
troppo fuori dal mondo per essere “veramente” accaduto. Non rimane che
evocarlo sulle corde dell'irreale, con una partitura visiva e scenografica
debitrice di Fassbinder e del Suzuki anni '80 (e non solo), così come a Jun
non rimane, una volta trovato il cadavere dell'amico che si è ammazzato
senza avergli detto nulla, che far finta di strozzarlo.
Voto: 29/30
HONOR DE CAVALLERIA
di Albert Serra
Spagna, 2006, 102'
In
Concorso

Una delle trasposizioni cinematografiche del “Don Chisciotte” più
intelligenti che si ricordino. Il prode cavaliere anacronistico e il suo
scudiero immersi nel paesaggio – anzi, “anneganti” nella natura a dispetto
delle loro manie di grandezza. Il naufragare della trascendenza,
insuperabilmente consegnato ai secoli da Cervantes, è ripreso da Serra con
straordinaria sensibilità di messa in scena: il suo digitale, che non ha
paura delle lungaggini ma non cede ad alcuna autoindulgente facezia
“autoriale”, è tutto rivolto verso il rapporto irrisolto tra i personaggi e
l'ambiente naturale. Il loro vagare imbelle è la resa di fronte a una natura
che si continua a non conoscere, il segno di un'alienazione radicale dentro
il mondo stesso.
La trama, perciò, si disgrega, e lascia spazio a sequenze avulse e sparse
che sono altrettante ipotesi di fraseggio formale sullo sfondo
dell'inazione. L'indugiare ossessivo sui tempi morti, sull'assenza totale di
“cose da fare”, sfuma in accenni di scrittura filmica che la macchina da
presa sembra vergare con l'inchiostro simpatico, consapevole che nel giro di
pochi istanti scompariranno. Inghiottiti da un nulla afasico vicinissimo a
Beckett, ma con i piedi ben piantati (suo malgrado) nel mondo, accostato
senza artifici.
Voto: 29/30
STORIES FROM THE NORTH
di Uruphong Raksasad
Tailandia, 2005, 87'
In
Concorso
Alcune microstorie ambientate in un villaggio rurale tailandese. Due donne
anziane in serena attea della morte, un gruppo di religiosi cicloamatori in
gita, la raccolta delle messi, un bufalo in fuga...
Siamo più dalle parti della poesia che della prosa. D'altra parte il regista
ha collaborato con la stella nascente del cinema d'autore internazionale
Apichatpong Weerasethekul. Ma mentre quest'ultimo gira in “versi liberi”,
inventandosi una metrica tutta sua per le sue incantevoli sospensioni
estatiche, Raksasad gira sì ugualmente in versi ma si adagia su una metrica
più regolare e sincopata, più tradizionalmente musicale. Il discreto lirismo
delle sue inquadrature, dei piccoli abissi tra una giunta di montaggio e
quella seguente, delle architetture silenziose delle immagini, si conquista
un'apprezzabile consistenza grazie anche a un uso assai disciplinato del
digitale, che in genere si lascia imbrigliare con una certa difficoltà.
È vero che l'insieme è discontinuo, che accanto a episodi davvero geniali
(come quello del musicista che di colpo si sdoppia, o quello felicemente
svagato e contemplativo della raccolta delle messi) ce ne sono altri un po'
scontati. Però a Raksasad, con il suo minimalismo ambizioso e sereno, va
riconosciuto un istinto linguistico e di articolazione tutt'altro che
dozzinale.
Voto: 28/30
PLEASURES OF ORDINARY
di Xia Peng
Cina, 2006, 118'
In
Concorso
La regione cinese dello Shanxi e la sua gente, documentata dal giovane (23
anni!) Xia con la sua telecamerina pixellosa. Un montaggio vorticoso frulla
i frammenti più disparati della quotidianità dei suoi abitanti. Molte storie
e persone vi si intrecciano senza soluzione di continuità, dal gestore di
una palestra a un giovane operaio dongiovanni a una madre di famiglia. Tutto
viene colto nella sua fuggevolezza: una volta che il frammento (sia esso
un'inquadratura singola o una situazione strutturata) acquista sufficiente
intellegibilità, si schizza immediatamente via verso qualcos'altro. Le scene
stesse, in molti casi, anche se protratte lungamente vengono comunque
frantumate da una mobilità estrema di punti di vista, sprezzanti della
continuità spaziale come dei raccordi sull'asse. Raramente un'inquadratura
“mette a fuoco” l'inquadratura precedente, per esempio con un dettaglio:
molto più spesso passa a tutt'altro e basta. Xia procede dunque per veloce
coordinazione a scapito della subordinazione.
È ovvio, non si tratta solamente di caoticità scoordinata, di banale
accumulo. Sarebbe troppo facile, e insensato.
Pleasures of ordinary,
invece, dà un senso a questa violenta cacofonia del quotidiano individuando
qua e là le emergenze più evidenti di questo caos, che in questo modo viene
riconosciuto, denominato, circoscritto, vagliato criticamente. Il periodico
ritorno, nel film, alle riprese della preparazione del corteo musicale, con
il relativo trambusto di percussioni e grida, è una chiara metafora in
questo senso. Così come lo è l'indugio sui monologhi deliranti di un barbone
ex ladro di biciclette, la cui vita incredibile catapultata di continuo
dalle stelle alle stalle si cristallizza alla perfezione nella natura
incontrollabilmente ondivaga della sua affabulazione.
Niente naturalismo ingenuamente descrittivo: tutto è perenne contrasto, la
stabilità è un miraggio, la contraddizione pulsa nelle vene di ogni singolo
istante. Questa la sentenza dagli echi metafisici che pare trasparire
dall'intelligente intelaiatura di Xia Peng. Un sospetto che diviene conferma
nella parte finale, tutta costruita su un impietoso montaggio parallelo tra
“le magnifiche sorti e progressive” evocate dalle icone maoiste, e la triste
condizione di un poverissimo anziano reduce dalla guerra di Corea.
Voto: 27/30
DIES D'AGOST
di Marc Recha
Spagna, 2006, 93'
Fuori Concorso

Marc riceve la proposta del fratello David di
partire per un viaggio, per rilassarsi un po' dalle stressanti ricerche
sull'amico morto Ramon che ossessionano Marc da un po' di tempo. Ma a un
certo punto sarà Marc stesso a sparire.
Deludente prova di un cineasta (catalano) di grande talento,
Dies d'agost vorrebbe evocare
la mancanza, la perdita, ma sceglie una strada troppo semplicistica. Tutta
la vicenda è condotta innanzi da un'onnipresente voce over femminile,
che si staglia su inquadrature fisse (scarsi sono i movimenti di macchina)
del paesaggio (oggetto di una attenta ricerca figurativa), spesso vuote. Il
guaio è che questo incessante succedersi di “Polaroid in movimento” è troppo
meccanico e rigido per sortire gli effetti auspicati: il paesaggio, da solo,
non basta. Ed è un peccato, perché l'intreccio, sapientemente costruito su
un complesso gioco di riverberi tra personaggi vicini e lontani, scomparsi e
presenti, meritava ben altra profondità.
L'amaro in bocca cresce, poi, se si ripensa a
Pau i seu germa, film di
Recha del 2001 parte della retrospettiva torinese a Joaquin Jorda. Un film
in cui l'evocazione del vuoto non era affidata a un'eterea voce over,
ma ci gettava insieme ai personaggi in una inquietante sospensione, dove la
macchina da presa mobilissima ma di grande discrezione materializzava il
disagio di una presenza (dei corpi, dei paesaggi, tutti “marcati stretti”
dalla regia) malferma, imprendibile, pronta in ogni momento a slittare verso
l'assenza. Tant'è che il ragazzo morto, intorno a cui si organizzano le
vicende dei parenti attoniti, ogni tanto era libero di materializzarsi in
profondità di campo in fondo all'inquadratura come se niente fosse, con la
naturalezza più totale. Un film di contemplazione non frontale (come in
Dies d'agost) ma liquida, fluttuante, vibrante.
Voto: 25/30
SCREAM OF THE ANTS
di Mohsen Makhmalbaf
India/Francia, 91'
Fuori Concorso
Una coppia iraniana, lui ateo ex comunista e lei vagamente credente (nel
senso più ingenuamente e genericamente new age del termine) vanno in India:
ovviamente è lei che trascina lui, in cerca di un imprecisato santone
chiamato “l'uomo completo”.
Makhmalbaf al suo meglio. La sua ormai inconfondibile vena formalista di
cura dell'inquadratura, dei suoi colori e del suo tratteggio netto e
preciso, si sposa alla perfezione con l'occhio virgineamente documentario.
Trova con questo film la quadratura rosselliniana (non a caso è ambientato
in India...) del cerchio che abbraccia l'osservazione della realtà e la sua
riformulazione estetizzante. Lo sguardo è lo strabismo di due occhi votati
l'uno alla passività documentaria, l'altro al formalismo immediato. È
appunto la lezione di Rossellini, che riecheggia ad esempio nel felice
andirivieni tra i tentativi smaccatamente pittorici di Makhmalbaf e
l'osservazione attonita degli slum metropolitani indiani, come nell'energia
didascalica che si nutre del contatto diretto con il reale (non è un film
verboso, ma apertamente e schiettamente affabulatorio).
La stessa lezione ce la dice a inizio film il grandioso personaggio del
“santone proprio malgrado”. È un vecchio semistorpio che si dice sia capace
di fermare i treni con lo sguardo. Il treno che porta i due protagonisti,
appunto, se lo trova davanti e si ferma. I due scendono e annacquano il
proprio entusiasmo apprendendo dal vecchio che lui tempo fa stava lì per
caso quando un treno lì davanti si è fermato: tutta la gente ha gridato al
miracolo e per lui si è perciò reso impossibile alzarsi da quel punto sui
binari, era insomma diventato un'autorità magico-religiosa solamente a furor
di popolo. Ergo: quel “trascendente” che sarebbe la “finzione” non è che
“realtà” sotto una specie diversa rispetto a quella che accorderemmo al
termine “realtà” (che dunque diventa in un certo senso finzione essa
stessa). La “bella immagine” makhmalbafiana, ugualmente, è talmente scoperta
nella sua ruvida, semplice, artigianale artificiosità da non poter essere
che una specie differente di “documentario”. Per questo la fede e lo
scetticismo sono intimamente legati, e il proliferare spirituale dei mille
dei dell'India è possibile solo sullo sfondo ultramacabro del rogo
incessante dei cadaveri sulle rive del fiume sacro.
Per salvarsi da questo inferno di contraddizioni non rimane, come dice il
messaggio finale dell'Uomo Completo letto dalla protagonista, che l'istante
presente. Un presente che però non è afferrabile in sé (altra ragione, fra
l'altro, per la quale dietro al documentario si nasconde la finzione), come
dimostra la scena iniziale in cui i bambini vanamente cercano di delimitare
con dei sassi l'ombra di un ombrellone inevitabilmente destinata a
spostarsi. E ancora: l'Uomo Completo non può venire inquadrato dalla
macchina da presa, che può solo “documentare” lo sguardo dei due
protagonisti nell'atto di tributare “fittiziamente” un qualche plusvalore
trascendente a chi gli sta davanti, che poi è quello stesso uomo che nella
scena precedente si era messo casualmente a parlare con loro per strada,
regolarmente inquadrato. È lui il santone: l'uomo ordinario – come dice il
fotografo che i due incontrano sul treno, la vita è fatta integralmente di
miracoli, dunque è vano andarli a cercare.
Voto: 30/30
ACCOLTELLATI
di Tonino de Bernardi
Italia, 2006, 85'
Detours

Da anni ormai, il cinema di De Bernardi è un
flusso unico le cui singole tappe si differenziano per piccoli spostamenti,
ma rimane comunque un solo e compatto movimento vitale.
La camera in perenne movimento che gira intorno a corpi, situazioni, luoghi
(spesso familiari) presi nella loro compattezza ma restituiti a una
concretissima mistica dell'esistente, nella loro immediata e opaca
efficacia. Anche qui, il “canovaccio” esilissimo è quello degli
“accoltellamenti” in cui varie persone sono a turno coinvolte: le minime
variazioni di postura e esecuzione sostengono quel soffio vitale in
movimento che le abbraccia tutte, abbraccia persino le concrezioni
metaforiche che ogni tanto fanno capolino, come il racconto dolente dei due
anziani coniugi “accoltellati” da una prassi economica e professionale
infame.
Il cinema di De Bernardi è preso integralmente nel filmare come atto
più che come funzionalità espressiva. Non ha “qualcosa da dire”, ma è un
movimento di avvicinamento infinito e inesauribile verso il mondo che
incontra la ripetizione, si scontra con essa e prova, in un impeto vitale
che non cessa di nutrirsi di se stesso, a scavalcarla, a vincerla. E ci
riesce: anni di film sempre uguali su situazioni ossessivamente ripetute, di
camminate interminabili, di sguardi fissi nel vuoto, di sprazzi di
quotidianità, di musical improvvisati a squarciagola, col tempo (ma
soprattutto con lo spazio generosamente attraversato senza posa) hanno
costruito un corpus unitario capace di farci toccare con mano l'energia
automatica del cinema, la sostanza più inafferrabile e vitale nascosta nel
semplicissimo gesto di filmare, di incontrare il mondo.
Voto: 26/30
OBLIVION
di Stephen Dwoskin
Gran Bretagna, 2005, 78
Detours
Dwoskin è da decenni un'istituzione del cinema indipendente underground. Con
quest'ultimo Oblivion si
confronta con "Le Con d'Irène" di Aragon e con la sua limacciosa storia di
impotenza maschile verso un femminile che non si riesce a dimenticare.
Ovviamente, il piano di convergenza tra i due testi non è quello
narrativo. Dwoskin cerca di tradurre le suggestioni del romanzo in modo
prettamente sensoriale, evocativo. Sonoro asincrono e composto da
imprecisati suoni cavernosi. Immagini ravvicinate di occhi, facce, pelli,
sessi – fino a sfiorarne la cute e a vederne i singoli pori. Stanze, angoli
vuoti, spazi celibi, luminosità lattiginose e invadenti. La distanza, come
principio di individuazione e distinzione tra gli oggetti, crolla – a tutto
vantaggio di una sensorialità distorta e angosciata, descritta
sinesteticamente da Dwoskin con la ricorrente inquadratura di una lampadina
che si accende e la cui luce invade totalmente l'inquadratura, accecandola.
Il ritmo catatonico, i movimenti al rallentatore, fanno dei lembi di carne,
dei rossetti e dei sospiri che si accavallano nel film una “pornografia
degli angeli” (come diceva Borges), una sensorialità che “sfonda” e
oltrepassa il proprio oggetto fino a diventare astratta e incorporea. Come
quando ci si avvicina a un oggetto così tanto da non vederlo più; la materia
“corteggiata” della macchina da presa così tanto da sbriciolarla sotto ai
nostri occhi.
Voto: 26/30
PRO-LIFE
di John Carpenter
USA, 2006, 60'
Americana

Un padre integralista cattolico assedia la clinica in cui la figlia sta
provando ad abortire. Peccato che il pargolo non sia precisamente ciò che ci
si aspettava... bensì, il figlio del Demonio in persona.
Straordinario apologo politico e morale di John
Carpenter, che ritorna su livelli eccezionali. Come nelle sue opere più
celebri (Distretto 13) lavora
su coordinate semplici come dentro-fuori (l'assedio), noi-loro, vita-morte,
solo per poter meglio cancellare il confine con un colpo di spugna (cfr.
La cosa). Chiarissimo il dispiego di linee e vettori: il discrimine
orizzontale tra dentro e fuori la clinica è vanificato dal “di sotto”
verticale da cui spunta il diavolo a ingravidare la fanciulla e riprendersi
il pargolo demoniaco, e la resa spaziale pratica di queste coordinate è
condotta con un senso dell'azione classica impeccabile, con un'alternanza
perfetta tra i segmenti implicati (tra le varie “fazioni” che si
fronteggiano asserragliate nella propria porzione del campo di battaglia).
Come ogni apologo veramente politico, è tutto un arrovellarsi di paradossi:
la cristallina trasparenza della regia serve precisamente a sconfessare la
“naturalità” di ciò che si spaccia per “naturale” (e dunque “baciato dal
cielo”) come la gravidanza – che è invece un atto simbolico, sociale,
mediato. Il sangue stesso, come è evidente dai brutalissimi e iperrealistici
omicidi del piantone al cancello o del padre di famiglia a metà del plot, è
rappresentato con un'estraneità tale da convocare l'effetto speciale.
L'umano si ribalta nel suo contrario (e dunque diventa vano parlare di
“peccato contronatura”), come risulta anche dall'insostenibile montaggio
alternato tra le doglie della ragazza e il dolore del medico cui il padre
pazzo applica i ferri del mestiere di abortista, divaricatori aspiratori
eccetera. Caduto lo specchietto per le allodole della “natura”, del maggiore
o minore “rispetto per la vita” di una posizione o di quella contraria, il
discrimine morale della questione diviene così irrimediabilmente
problematico e allergico alle semplificazioni di comodo: a un moralista
rigoroso come Carpenter non si poteva chiedere di meglio.
Non si poteva chiedere di meglio che sbatterci
in faccia questo interrogativo privo di risposta: “dov'è la vita?”.
Voto: 30/30
DIRECTED BY
di Peter Bogdanovich
USA, 1971-2006, 108'
Americana

Tutte le volte che si dice che John Ford è uno dei maggiori cineasti di ogni
tempo si esita, si dubita: che non sia invece piuttosto IL cineasta se ce
n'è uno, il Maestro Assoluto.
Questo documentario amplia un documentario di più di trent'anni fa dello
stesso Bogdanovich sul Magnifico Irlandese. C'e dentro una leggendaria
intervista al cineasta e una nutrita serie di interviste a collaboratori (John
Wayne, Henry Fonda, James Stewart...) e a “non semplici” estimatori, cioè
per esempio a cineastri della New Hollywood (Eastwood, Walter Hill,
Spielberg, Scorsese, lo stesso Bogdanovich) che hanno fatto tesoro dei
capolavori fordiani.
Non è che queste nuove voci aggiungano granché all'originale, senza contare
che l'inguaribile accademismo di Bogdanovich raramente si discosta da
un'esposizione di stampo diligentemente “manualistica”: per cui Ford rimane
quello dei tramonti e delle scene rituali, del circolo fisso di attori
gestiti con la solita straordinaria disinvoltura plastica di direzione,
eccetera eccetera. Certo, per chi non conosca l'esaltante ed insostituibile
cinema fordiano, “Directed by” può essere uno strumento di avvicinamento più
che degno. Però Bogdanovich con tutta la sua dediziosa “Aufklaerung”
scolastica nulla contro può l'esplosiva potenza di alcuni singoli momenti
aneddotici, che da soli racchiudono TUTTO il mondo del Maestro. Ci
riferiamo, certo, ovviamente all'intervista a Ford stesso, il quale con
meraviglioso candore e immediatezza riustica d'altri tempi era capace di
guardare la camera dritto davanti a sé, con la Monument Valley (teatro di
mille suoi capolavori) alle spalle, e rispondere a un giovane Bogdanovich
che chiedeva “Ma come ha girato il tale film?”: “Con la cinepresa”.
Ma ci riferiamo anche a istanti come l'impagabile aneddoto di cui ci fa
partecipi Steven Spielberg, che quindicenne riesce a conquistare un'udienza
nell'ufficio del Maestro per alcuni consigli su come diventare regista. E
lui si alza, gli fa vedere dei quadri alla parete ritraenti classiche scene
western (del celebre pittore Remington, specializzato in scene del genere) e
gli dice: “Cosa vedi lì dentro?”. “Mah, cavalli, uomini, montagne...” “No,
no, no. Che cos'è QUESTO?” “L'orizzonte” “Bravo. E dove sta?” “In basso”
“Bene. E in questo quadro?” “In alto” “Ottimo. Ricordati: quando ti verrà
naturale mettere l'orizzonte non al centro dell'inquadratura, ma un po'
troppo in alto o un po' troppo in basso, allora sei sulla buona strada per
diventare davvero un regista”. A buon intenditor, poche parole.
Voto: 26/30
FLAGS OF OUR FATHERS
di Clint Eastwood
USA, 132'
Fuori Concorso

Niente battaglia di Iwo Jima, a dispetto del battage mediatico. A parte
alcuni brandelli confusi e una serie di flashback dolorosi in cui i soldati
una volta tornati in patria rivedono i compagni morire sul campo. Il centro
del film è invece la celeberrima fotografia dei soldati che piantano la
bandiera a stella a strisce, simbolo di una guerra, di una civiltà
trionfante, immagine che è risultata cruciale per risollevare gli animi a
pezzi del popolo americano. Un'immagine che ha risollevato un Paese e che ha
dunque cambiato il mondo. Un'immagine che il figlio di uno dei soldati
ritratti, che NON sono quelli che davvero hanno messo la bandiera, è
risoluto ad indagare attraverso le testimonianze dei superstiti e dei loro
correlati.
Quello che preme a Eastwood è indubbiamente girare un suo remake de
L'uomo che uccise Liberty Valance
di John Ford. “Print the legend”, sentenziava quel film altrettanto
incentrato sull'ambiguità storica del Mito, e si chiudeva con una scena che
ripeteva da un altro punto di vista una sparatoria vista all'inizio.
Flags of our fathers non solo
comincia con una leggenda che viene stampata, cioè con la capillare stampa e
diffusione dell'immagine fatidica, non solo verso la fine abbiamo la
riproposta, da un altro punto di vista, della scena mostrata poco prima in
cui uno dei protagonisti incrocia un ex commilitone attraversando in
macchina la prateria, ma, come si sa da mesi, è pronto a sdoppiarsi tra poco
in un film gemello (Letters from Iwo
Jima) che adotta il punto di vista dei Giapponesi.
La sparatoria di Ford è accaduta diversamente da come il Mito l'ha dipinta.
La bandiera di Iwo Jima è stata piantata appena 5 giorni dopo l'inizio della
battaglia che invece ne sarebbe durati altri 20 e passa (niente simbolo di
un trionfo allora), ed è a propria volta la copia di una bandiera issata
poco prima nello stesso luogo. All'inizio del film i tre eroi si arrampicano
su una montagna tra i fuochi spietati nel cielo... ma una volta arrivati in
cima, la macchina da presa svela che non siamo su un campo di battaglia, ma
in uno stadio gremito in cui si festeggia con una finzione rituale e con un
profluvio di fuochi d'artificio un trionfo immaginario.
Il punto insomma è proprio la continuità scandalosa tra la guerra e la sua
immagine, nonostante la loro incompatibilità. Non nel senso mimetico
da “soldato Ryan”, non cioè perché la guerra sia davvero restituibile in
quanto immagine, ma perché le guerre si vincono anche con le immagini, le
battaglie vere si combattono confortati dalla finzione di una bandiera che
sventola, e soprattutto diventare un'immagine significa vivere una scissione
così radicale che è del tutto analoga alla guerra stessa. L'immagine è
strutturalmente una guerra, e la guerra stessa è questione di immagine.
Eastwood filma con suprema abilità il disagio dei tre “finti eroi” in giro
per l'America a celebrare ciò che non hanno vissuto, riproducendo la
paradossalità del loro punto di vista al centro dei riflettori, “spettatori
di se stessi” quanto e più del pubblico pagante che li guarda dagli spalti.
Tesse scene dove l'adesione molto classica al punto di vista del personaggio
non fa filare il racconto ma lo squarcia appunto nella pluralità dei punti
di vista: si veda il doloroso balletto visivo della scena (magistrale e
significativa) in cui i tre incontrano per la prima volta il ministro del
tesoro. L'immagine stessa è una guerra che ci travolge in prima persona
spaccando a metà la nostra coscienza (che non può rassegnarsi ad essere
“solo” immagine). La guerra, per eccellenza il culmine al limite del
“reale”, come caos di punti di ripresa (i primi flashback del film), e come
attonito assistere alla morte altrui (i secondi flashback che compongono il
film,o meglio lo bucherellano enunciando tutta la sanguinante ambiguità del
racconto in quanto tale, del racconto come categoria antropologica), è
dunque agghiacciantemente speculare all'attonito scoprirsi vivi che è
l'immagine, cui vengono dati in pasto i tre soldati nella campagna
trionfalistica.
Per questo il vecchio ex-soldato sul letto di morte si sentirà dire che è
stato un buon padre proprio perché (e non “nonostante”) sia stato
ossessionato dall'incapacità del raccontare la guerra: la guerra nella sua
proverbiale irrappresentabilità ce la racconta eccome un racconto “reduce di
se stesso”, lacunoso e bucherellato. L'impossibilità di raccontare si salda
del tutto naturalmente con l'esperienza dell'impossibilità che è la guerra:
per questo il racconto, anche se “falso”, è salvo (l'allucinazione dell'ex
soldato cui pare di incrociare in macchina il commilitone a piedi è davvero
la realtà, è davvero il commilitone, come dimostra l'accennata scena
ripetuta da due punti di vista diversi), e con esso la funzione paterna. A
noi figli non resta che dare una voce al racconto dei padri che è
inevitabilmente paradossale, inevitabilmente leggenda: non resta che
visualizzare l'”utopico” bagno in mare tra commilitoni vivi e morti che
chiude questo nuovo capolavoro eastwoodiano. Print the legend.
Voto: 30 e lode
Robert Aldrich
L'universo morale di Robert Aldrich è stato
preso in analisi già molte volte e sotto tanti punti di vista. Volendo
tirare in ballo la psicanalisi, la sua cifra fondamentale sarebbe
probabilmente quella dell'isteria. "Isteria, è il nome proprio della
posizione di fascino ambivalente esercitato dall'oggetto che ci affascina e
ci ripugna", dice Slavoj Zizek. La questione è complessa, ma, semplificando,
possiamo rintracciare del tutto agevolmente in Aldrich questa ambivalenza
verso l'Autorità, verso il potere costituito, verso la "figura paterna",
insenso lato.
"I've written a letter to daddy saying I love you", canta la piccola Baby
Jane all'inizio di "Che fine ha
fatto Baby Jane": appunto, un attaccamento verso il padre, e quindi
verso l'autorità, verso il potere, espresso in modo essenzialmente "mediato"
(la lettera), dunque in partenza ambiguo e passibile dei più improvvisi
capovolgimenti. Pressoché tutti i film di Aldrich sono costruiti proprio
sulla figura del capovolgimento improvviso dei valori: su tutti
Grissom Gang, dove (come
culmine di tutta una serie di voltafaccia inaspettati) verso la fine la
ricca e viziata ragazza rapita dall'imberbe ragazzotto povero di provincia
insanamente attaccato alla madre passa improvvisamente dalla parte del
rapitore, "ripudiando" idealmente il padre.
Non è a un caso allora che Aldrich raccolga ambiguamente il testimone della
Hollywood morente: crollato il suo sistema di valori, Aldrich si rapporta a
questa autorità con una esplicita ambivalenza di amore e condanna,
continuità e trasgressione. Le regole non sono più il pilastro di un sistema
organico, ma quelle di un gioco: in tutti i suoi film, anche quelli non
centralmente sportivi come invece sono
California dolls o
Quella sporca ultima metà c'è
il riferimento forte allo sport. E come tali, queste regole sono
costituzionalmente fragili e passibili in ogni momento di essere messe in
discussione fin dalle proprie fondamenta. Il mondo di Aldrich è fortemente
morale proprio perché "istericamente" mette in costante discussione e dubbio
la maschera stessa che la moralità viene di volta in volta a incarnare. La
morale, in Aldrich, è un fondamento tutto da scoprire in progress e
mai dato in partenza.
Si capisce allora l'anima della sua energia registica, quella strana
radicalità nell'intessere inquadratura dopo inquadratura, taglio di
montaggio dopo taglio di montaggio, relazioni di potere tra personaggi e
situazioni visualizzate con un piglio "illuminista" direttamente debitore
della Hollywood classica, ma che a differenza di questa ribollono, cambiano
pelle ogni secondo, si sostituiscono reciprocamente senza posa, sfuggono a
qualunque univocità semplificativa come alla sintetizzabilità nei confini
ristretti della scena. L'aldrichiano tessere relazioni di potere tra
personaggi è una catena infinita (e non, dunque, finalizzata ai limiti della
singola scena come parte di un continuum come nella vecchia Hollywood) in
cui c'è sempre un nuovo anello di cui tener conto, sempre pronto a
riscrivere l'assiologia morale in corso. Una tessitura alle prese con un
eccesso che non si lascia addomesticare nonostante costantemente ci si provi
(un'altra perfetta definizione di isteria, peraltro), come è evidente nel
sapiente controllatissimo squilibrio tra acting out di recitazione attoriale
e spigolosità spietata di regia in
L'assassinio di sister George, o in
Grissom Gang la sublime
sospensione che piano piano divora gli sguardi, che non si lasciano più
strutturare in un gioco di relazioni ma, ribaltone dopo ribaltone, si
perdono nel vuoto.
Cade Hollywood e cade l'autorità. Al singolo, che non è più il perno
organico dell'universo, non rimane che un conflitto infinito con le altre
singolarità (Quella sporca dozzina),
semmai ricomponibile sotto la specie di un'autorità come un onore di stampo
sostanzialmente militare (Quella
sporca dozzina, L'imperatore
del nord, Non è più tempo di eroi) che è però talmente astratta da
non poter essere definita a priori ma sempre secondo le circostanze, insomma
istericamente indefinibile e in fin dei conti inerme di fronte all'onipotenza
del pragmatismo crudele della Realpolitik:
Ultimi bagliori di un crepuscolo,
che materializza questo pragmatismo crudele proprio nella pluralità
mediatica dei punti di vista (split screen e schermi televisivi a circuito
chiuso a profusione) come nemico mortale dell'azione responsabile del
singolo.
Un film, quello, in cui all'esercito si rimproverava di non essere
abbastanza in linea con l'etica militare, ma di lasciarsi corrompere dalla
politica. Ancora un'ambivalenza strutturale verso il potere, che Aldrich
rinnova con grandissima acutezza morale in tutte le pieghe della sua
filmografia, come anche nel fatto che ha caparbiamente sempre coltivato la
sua indipendenza solo per poter costruire film in un certo senso
"post-Hollywoodiani", dove le ceneri formali di Hollywood vengono
simultaneamente criticate e riabilitate. Vedere
Il grande coltello,
melodrammone hollywoodiano anti-Hollywood, che peraltro si presta a
esemplificare lo strano rapporto con il teatro di alcuni film aldrichiani
tratti da qualche pièce teatrale: l'impianto scenico è formalmente
rispettato assai diligentemente, ma contrastato e dialettizzato dall'interno
da un intenso gioco di montaggio. Un teatro "istericizzato", insomma. Una
vera e propria scienza dello smozzicare progressivamente la compattezza
scenica.
Altro esempio fulminante di questa ambivalenza è il rapporto con la
televisione, violentemente attaccata a più riprese e in più di un film,
primo fra tutti il capolavoro assoluto che è
Quando muore una stella (che
meriterebbe fiumi di inchiostro a parte: diciamo che è un remake de
Il grande coltello alla luce
de La donna che visse due volte
e all'alba dell'onnipotenza TV), ma inaspettatamente riavvicinata con
Un gioco estremamente pericoloso,
film in cui la solita problematicità morale rientra in un impianto
strutturale sfacciatamente televisivo.
Lo scottante valore del cinema aldrichiano risiede proprio nell'"isterica"
apertura di questi interrogativi.
Torino, 19:11:2006 |