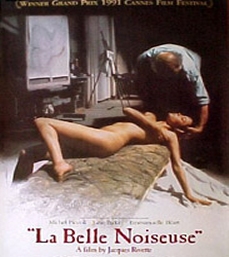|

In genere quando si parla di Rivette si tirano fuori riferimenti
cinematografici sempre molto superficiali. Renoir, Rossellini, ben che
vada Preminger... Eppure, dapprima come critico, e poi nelle interviste
una volta passato dietro la macchina da presa, l'interessato ha
costantemente annoverato Mizoguchi Kenji tra i suoi numi tutelari.
La bella scontrosa, in particolare, è un film che presuppone molto
chiaramente I racconti della
luna pallida d'agosto. Ma mentre il
Maestro giapponese costruisce una commossa elegia della creazione
innanzitutto umana (arte come artigianato e viceversa), capace dello
slancio universale che assume e sublima i propri stessi limiti
(l'assenza, la morte, l'inconoscibile, l'irreale), il francese misura la
dolorosa distanza che lo separa da una visione così classica, così
totalizzante da potersi definire cosmica.
La bella scontrosa è la
funerea genesi della Modernità: la fine dell'unione piena tra l'artista
e l'opera, tra l'opera e ciò che rappresenta, tra soggetto e oggetto,
tra uomo e donna. Prima del mestissimo party conclusivo che "festeggia"
la nascita del quadro, ce lo dice la moglie di Frenhofer: "questo non è
un inizio, è una fine", ce lo dice la tipicamente rivettiana (si pensi
al recente Histoire de Marie et Julien) costruzione che moltiplica le
impossibilità (sia quelle dei personaggi che quelle relative al visibile
che la macchina da presa non può non cercare) e le incrocia a scatole
cinesi: un quadro che NON mostra una donna (non ne vediamo il viso) e
che sostituisce un altro quadro (che invece lo mostra) murato
nell'atelier e che gli spettatori stessi non possono vedere - il tutto
dipinto da un pittore che sa di poter amare una donna solo perché non
riesce a dipingerla, e viceversa dipinge solo ciò che gli appare a una
distanza di sicurezza. Alla superficie del visibile, insomma, non
possono accedere che rimasugli insignificanti dell'invisibile.
Fin qui, nulla di nuovo. Il discorso però acquista una profondità
decisiva grazie all'elemento, anch'esso squisitamente mizoguchiano, del
Femminile. Come per il Maestro (famoso appunto per i suoi ritratti
femminili), la donna è il limite irrappresentabile che l'occhio
(maschile) che produce il visibile deve per forza fronteggiare: l'illocalizzabile,
imprendibile duello tra la modella e il pittore. Ma il "duello" non è la
figura giusta: l'atelier è piuttosto il teatro di una continua erosione
dell'occhio "reificante" che chiude il visibile in uno sguardo, in una
figurazione precisa. L'usuale grandezza etica di Rivette sta nella sua
consapevolezza di non poter staccarsi da quel tipo di sguardo, e dunque
invece di rincorrere vanamente la rappresentazione dell'irrappresentabile
costruisce una serie di forme visive vettoriali, chiuse, che lascia però
scuotere da vibrazioni indefinite. Questo è lo spazio in Rivette: il
sospetto di un'estensione al di là delle relazioni tra gli oggetti
immediatamente catturabili dall'occhio. Questo il senso, ad esempio,
delle improvvise zoommate verso Marianne dopo svariati minuti di una
mano che dipinge, o di inquadrature composte (pittoricamente) dal
pittore che dipinge in profondità e dalla modella che voltandogli le
spalle ci guarda in primo piano "sfondando" la quarta parete, o di un
controcampo di Marianne ("chiuso" nella normale relazione
guardante-guardato) che si allarga fino a mostrare i sussulti
inconsapevoli del suo corpo nudo. Nell'atelier la relazione tra soggetto
e oggetto viene sbalestrata (al punto che Marianne più il quadro procede
più è trascurata dalla macchina da presa), grazie al tempo: al suo
irrompere traumatico (il passato del quadro incompiuto con Liz) e al suo
protendersi (delle molte ore del film, delle sue scene incuranti della
sintesi fattuale dell'azione). E lo spazio in Rivette è questo: ciò che
resta dell'incontro "impossibile" tra lo spazio stesso e ciò che lo
percepisce, che lo chiude in una forma visibile; ciò che resta dopo
l'irruzione del femminile che demolisce le coordinate ordinarie:
Marianne che "invade" l'atelier, sposta gli oggetti, dice di rivendicare
un suo tempo e un suo spazio, diventa un puro, vuoto propulsore negativo
("No", la sua battuta che chiude il film), esplosivo, fino alla
demolizione suprema, quella della staticità del punto di vista quando
Frenhofer la accusa di essersi mossa e lei ribatte "guarda che ti sei
mosso tu".
Questo terremoto avrà ovviamente come conseguenza il fatto che tutto
rimanga tale e quale a prima: Liz con Frenhofer, Marianne con Nicolas,
il produttore coi soldi. E Frenhofer ha soprattutto paura di perdere il
controllo, almeno quanto finge di volerlo perdere. Ma il moderno è
questo, e la nouvelle vague lo ripete da decenni: la continuità con il
classico con altri mezzi, non più l'unità ma la rottura. E il terremoto
filmico bisogna costruirlo davvero, non vuol dire agitare la macchina a
caso come in Blair Witch Project.
In La bella scontrosa è terremotata
sia la struttura generale (e pochi si sono occupati di deragliamento
della struttura quanto Stravinskij, citato in colonna sonora), con una
voce over assolutamente indipendente dalla narrazione (salta fuori nei
primi 5 minuti e negli ultimi 5) che scaraventa all'improvviso il cuore
del film al di là del visibile (dice "Io sono Marianne e non quella che
vedete" - ma dove e cosa sarebbe questo "io" che non si vede?), che la
grammatica molecolare delle inquadrature: mai, nell'atelier, vengono
collegate a semplice catena il pittore, la sua opera, e la modella, ma
sempre vengono create relazioni parziali e a cui il tempo attribuisce
sostanza per allargare allo spettatore lo spaesamento visivo al centro
del film (e dei continui deliri verbosi di Frenhofer), tanto più grande
quanto la regia appare comunque quadrata, attenta, portatrice di un
punto di vista stabilmente appoggiato sulla porzione di mondo che
inquadra. Perché il costruire (dipingendo) lo spazio, è esso stesso
questione di spazio: lo spazio che si srotola al di là delle relazioni
immediatamente percepite/costruite dall'occhio (e infatti il rapporto
pittore-modella si gemma ed espande nelle relazioni interpersonali fuori
dall'atelier), srotolandosi da solo nelle mani del pittore, negli occhi
stessi di chi guarda. Rivette riesce a costeggiare la visione stessa,
intesse una fitta trama di relazioni e movimenti e se ne autoesclude, si
muove ai margini dello spazio perché il guardare stesso è un atto
spaziale, e dunque contemporaneamente dentro e fuori lo spazio. Lo
spazio come autoesclusione di sé stesso.
|