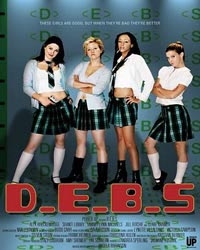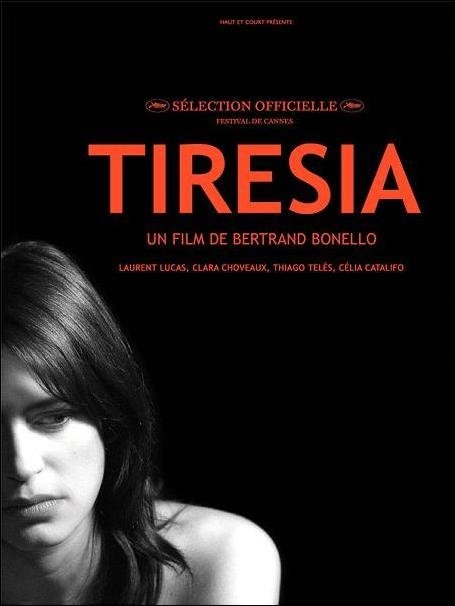|

Viviamo un tempo che sfugge a tentativi di etichettatura e definizione, un
tempo la cui unica cifra interpretativa pare essere la complessità, il
paradosso, il mutamento, il continuo slittamento di sensi e prospettive. Non
fosse altro che appunto lo viviamo, questo tempo, nell’assenza di una
necessaria distanza che ne permetta una messa a fuoco. E l’individuazione
del sé, la rappresentazione della propria individualità di genere, maschile
o femminile cerca anch’essa nuove possibilità rappresentative, desiderosa di
svincolarsi dal soffocante abbraccio di una identità sessuale i cui confini
sono continuamente spostati. In questa ricerca di una singolarità
identitaria che sfugga agli stereotipi del maschile e del femminile si pone
Gender Bender, festival giunto alla sua seconda edizione, un mix
sapiente ed irriverente di musica, installazioni, teatro, mostre
fotografiche e cinema realizzato grazie alla collaborazione sinergica del “Cassero-
gay & lesbian center” di Bologna e le istituzioni culturali della città,
dalla Galleria d’Arte Moderna alla Cineteca dove dal 29
ottobre al 2 novembre è stata offerta al pubblico un’esaustiva panoramica di
quanto in tempi più o meno recenti il cinema ha offerto al dibattito sulla
definizione dell’identità corporea e sessuale. Ripartire dall’immagine per
tentare il recupero di una corporalità che paradossalmente proprio
l’immagine ha esaurito, nella sua incessante offerta di corpi scrutati con
occhio morboso e voyeuristico, nella sua costante vocazione “orgasmica”,
dalla pubblicità ai videoclip. Il paradosso è che quella stessa cultura che
ci propugna metodicamente nudità e sesso ha finito per rappresentare se
stessa come grottesca caricatura della disinibizione finendo poi col
gettarci nella prigione di un progressivo rifiuto della corporeità nel
momento in cui disattende i canoni imposti di bellezza, giovinezza, assenza
di odori e tracce di umano. Non è un caso che il contatto si dia sempre più
nell’assenza di contatto, nella necessità di nascondersi, magari dietro ai
tasti di un computer, al nickname di una chat, nella perdita e assenza anche
della voce che è pur sempre un segno corporale e perciò fastidioso, da
cancellare. Pur senza voler scendere nell’insidiosa diatriba se possa
esistere un cinema gay (rifacendo il verso all’eterna querelle letteraria
dell’esistenza di una scrittura al maschile o al femminile tanto cara ai
movimenti femministi) possiamo riconoscere alle pellicole viste nella
rassegna il merito di un tentativo di recupero della corporeità, in toni a
tratti leggeri a tratti provocatoriamente crudi, come segno necessario e
imprescindibile della rappresentazione di sé nel mondo. E ancora il
tentativo di scardinare punti di vista e ruoli sessuali e sociali,di
ritrovare oltre alla sessualità di natura anche una sessualità di cultura,
di liberarsi da stereotipi e schematismi, da una “normalità” vissuta come
inadeguata e avvilente rispetto all’espressione della propria soggettività.
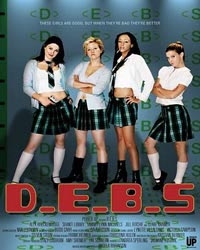
D.E.B.S
(Usa 2003 ) di Angela Robinson, 90'
Il film che apre la rassegna è una piacevole e scanzonata rilettura degli
action movies degli anni ’70, una sorta di
Charlie’s Angels in chiave
lesbo. Le D.e.b.s. del titolo
sono un gruppo insospettabile di studentesse, ninfette sexy in gloss e
trucco pastello, micro kilt e calzettoni bianchi. C’è l’afro americana, la
bianca molto “wasp”, la francesina ninfomane dai tratti orientali e la
ragazzona ipervitaminica dai capelli biondo angelo. Tutte bellissime,
insospettabili agenti segreti al servizio del governo Usa, selezionate in
base ai segretissimi criteri di valutazione di un misterioso test. La loro
nemica numero uno è la pericolosissima Lucy Diamond, spietata criminale alla
cui vista mai nessuno è sopravvissuto. Ma dietro alla spietatezza di Lucy
c’è una grande solitudine e l’incapacità di amare ed essere amata dopo tante
relazioni sbagliate. Lo stesso senso di inadeguatezza e mancanza che prova
Amy Bradshaw, la Deb dal volto d’angelo, la migliore delle agenti, la “best
scored” nel test d’ingresso, la più corteggiata dai ragazzi della scuola e
anche la più triste. Quando le due ragazze dopo un inseguimento si trovano
faccia a faccia è il colpo di fulmine, anche se le resistenze di Amy sono
difficili da abbattere, dato che in un colpo si trova a dover rimettere in
discussione non solo la propria eterosessualità ma anche il proprio ruolo
sociale di difensore della giustizia contro al male rappresentato da Lucy.
In un inseguirsi di episodi rocamboleschi Lucy inscena un finto rapimento di
Amy per poter passare un po’ di tempo con lei. Le compagne organizzano una
missione per liberarla ma quando la ritrovano assieme a Lucy capiscono in
maniera inequivocabile che non c’è carceriere e carcerato. Si tratta di
salvare le apparenze dato che Amy ha disatteso la regola numero uno delle
Debs, quella di non avere a che fare col nemico, e per di più in maniera
così plateale. Ma la Deb decide che non può più mentire a se stessa e al
mondo e il finale è inevitabilmente rosa, con le due ragazze che in un
romantico tramonto si allontanano su una decappottabile in barba a ogni
falso senso del dovere e del decoro.
Voto: 24/30
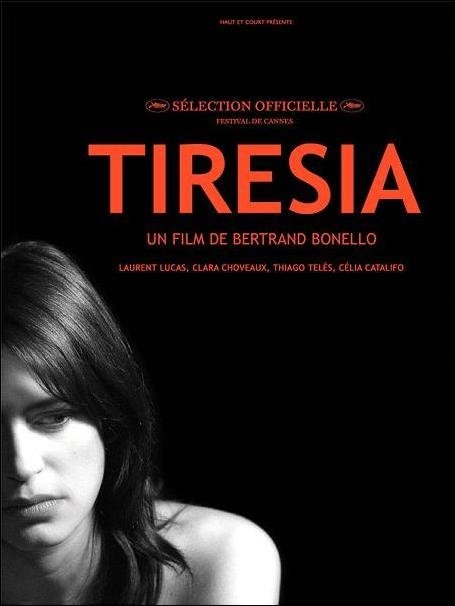
Tiresia
(Francia/Canada 2003) di Bertrand Bonello, 110’
Il mito ci narra del vate tebano Tiresia, che fu uomo, donna e ancora uomo,
colui che rivelò a Era e Zeus che tra i piaceri sessuali infinitamente più
grande è quello della donna. Colui che fu reso cieco da Era indispettita
dalla rivelazione di cui il tebano poteva essere certo, avendo sperimentato
entrambi i piaceri, e che Zeus ricompensò, impietosito, dalla perdita della
vista facendogli dono della veggenza. Tiresia vive ai giorni nostri in un
volto inquietantemente bello, il volto di un transessuale, su cui la
macchina da presa si ferma intenta a scrutare un segreto che non sa dire,
mentre si alternano al primo piano immagini potenti di lava ribollente.
Sulle strade della periferia di una Parigi desolata e autunnale i passi di
un uomo, la voce dei suoi pensieri fuori campo, giardini squallidi,
l’interno di un museo in cui dorme sdraiata un’enigmatica statua di
ermafrodito. E’ il mistero che l’uomo va cercando, che trova ai bordi di una
strada, di notte, ascoltando la voce di Tiresia che modula piano una
malinconica canzone portoghese. L’uomo la porta con sé, e giunto nel suo
appartamento la imprigiona. Ma la bellezza della donna è frutto della
chimica (e ci tornano a mente le parole della voce fuori campo “il falso è
meglio del vero... l’originale è un maldestro tentativo, è la copia che
conta, il falso è meglio del vero..” come in maniera tragicamente comica ci
diceva la Agrado almodovariana di
Tutto su mia madre), delle dosi massicce di ormoni che ogni giorno
deve assumere “per essere bellissima” e cancellare la peluria del viso e
ogni traccia di mascolinità (che resta nel pene che ci viene mostrato
assieme al seno acerbo, da fanciulla, in un nudo privo di ogni morbosità).
Quando la bellezza di Tiresia sfiorisce e la barba inevitabilmente ne sporca
il viso l’uomo decide di sbarazzarsi di lei, e lo fa cavandole gli occhi con
un paio di forbici e abbandonandola priva di sensi lungo la strada. Qui è
ritrovata da Anna, giovane e silenziosa ragazza che si prende cura di
lui/lei. Ed è durante la convalescenza che Tiresia si rende conto di aver
acquisito la capacità di vedere il futuro, non avendo più occhi per guardare
e per guardarsi. La fama del veggente si diffonde in fretta tra la gente del
villaggio che come su un altare porta a Tiresia doni di frutta cibo e vini
in cambio di un responso dell’oracolo. E ne viene a conoscenza anche il
giovane parroco, che altri non è che il rapitore e torturatore di Tiresia.
Il finale tragico si chiude con la profezia di una nascita, del parto di
Anna e la morte di Tiresia per mano del suo antico carnefice. Un film che ha
diviso pubblico e critica a Cannes, a nostro parere bellissimo: Tiresia è la
personificazione dell’assurdo e del dolore che impasta l’esistenza. Il suo
corpo di ermafrodito è monstrum, mostruosità e prodigio, segno
tangibile di un’impossibilità di essere nel mondo, di darsi come identità
certa. E i due attori chiamati a impersonificare Tiresia sono la forma
stessa di questa impossibilità di istituire confini, al corpo e
all’individualità: corpi troppo alti, troppo magri, mano troppo lunghe, due
corpi macerati e quasi impalpabili ma al tempo stesso incredibilmente
carnali, sensuali, impossibili da etichettare e da toccare, in
un’oscillazione tra timore reverenziale riservato alla divinità e repulsione
di ciò che è altro e sfugge.
Voto: 28/30

MOTUS -SPLENDID’S
(Italia 2004) di Daniela Nicolò e Enrico Casagrande (i Motus) dall’omonimo
testo di Jean Genet, 55’
Una danza di corpi morti, corpi che si muovono come marionette, i fili
maneggiati dalle dita del gran prestigiatore Genet: questo è
Splendid’s, il testo teatrale
pubblicato postumo da cui la compagnia teatrale Motus trae questo video,
interamente girato nella hall di un albergo, portando a compimento il
progetto a lungo accarezzato di trarre una trasposizione filmica di un testo
“dalla forte impronta cinematografica”. L’azione è ambientata interamente
nella hall di un grande albergo, lo Splendid appunto (il “set” utilizzato è
stato nel caso del film il Grand Hotel di Riccione messo interamente a
disposizione della troupe): un gruppo di banditi spacconi, che ostentano
movenze e dialoghi da gangster cinematografici si sono asserragliati
all’interno dell’hotel. Hanno in ostaggio una ricca ereditiera americana,
che senza motivo finiscono per ammazzare, ed un poliziotto che si è presto
trasformato in complice attratto dall’irresistibile fascinazione del male e
della trasgressione al proprio ruolo di tutore della legge. Non ci sono vie
di fuga, soprattutto nel momento in cui all’esterno si verrà a sapere
dell’uccisione della ragazza. La radio interrompe di tanto in tanto la
programmazione musicale per dare notizia di ciò che accade all’interno
dell’albergo. Ed è la radio stessa, l’informazione ufficiale, a costruire in
qualche modo l’identità sanguinaria e feroce dei banditi che finiscono per
accettare di recitare, fino in fondo, il ruolo. Poco più che burattini,
dunque, si muovono a passo di danza lungo l’immenso corridoio della lussuosa
hall, alternano scene di corteggiamento a minacce, i mitra sempre puntati
l’uno addosso all’altro, ostentano una libertà di movenze e un senso
beffardo di sfida alla morte e di rivendicazione di una libertà venduta come
assoluta quando è in realtà gabbia, per di più senza via di scampo dato che
le munizioni stanno per finire e la polizia ha completamente circondato lo
stabile. Nella trappola mortale in cui sono tentano con sotterfugi di
rimandare il momento dell’esecuzione, mentre chi è più consapevole non sa
fare altro che sprecare una cartuccia utile contro la polizia per spararsi
un colpo in testa. Cade ogni regola, ogni gerarchia. L’assurdo e il
nonsense, il travestimento in abiti femminili, i balli, le scene di
seduzione tra i membri della gang si danno in una dimensione che è solo di
apparente libertà, di illusorio abbandono delle convenzioni sociali: oltre a
ciò la via è la morte o la fine della commedia, l’infrangersi dello schermo
tra recitazione e realtà: ad accogliere i banditi che a mani alzate escono
dallo Splendid nessuna pistola puntata, solo la macchina da presa maneggiata
da un cameraman.
Voto: 25/30

PETRA
(Germania, 2002) del collettivo Hangover Ltd, 72’
Il richiamo, ovvio, alle Lacrime
amare di Petra von Kant è esplicitato dal titolo. Ma in realtà si
tratta di un richiamo piuttosto labile. L’allucinata sequenza di immagini di
questo film difficilmente classificabile in quanto genere (il collettivo
parla di Science&Fiction, traducibile come “scienza della finzione) è il
risultato di un montaggio ed una scrematura da un materiale iniziale di 32
ore di riprese. Girato in assenza di una qualsiasi sceneggiatura ha per
protagoniste Petra, un’artista-regista che cura installazioni lavorando
“solo con donne nude” (come osserva con tono deplorevole la madre che piomba
nell’appartamento quanto mai inappropriatamente) e le tre attrici con cui
sta lavorando al suo progetto. Questa la labile trama su cui si innestano le
performances che sotto la nevrotica guida di Petra le attrici
inscenano, raramente ribellandosi, rimettendosi completamente alle sue
decisioni. Così fra travestimenti da fatina o da rockstar, da animali con
enormi teste di peluche o da cameriere sexy le donne mettono in scena un
vortice di ossessioni, di desideri sessuali, pulsioni erotiche, in una
rappresentazione straniante e a volte urtante del corpo femminile. Corpo da
mangiare, da toccare e far toccare, in un costante rifiuto della femminilità
stereotipa di madre- contenitore-femmina predata. Le tre donne urlano,
appendono bambole - neonati con chiodi alla parete inscenando riti vodoo
dopo esserseli appesi al seno inscenando un allattamento, si cospargono di
finto sangue lasciando galleggiare il proprio corpo nudo nella vasca da
bagno - la rappresentazione del corpo morto ritorna, un corpo che “non deve
essere niente” che non deve essere recitato in alcun modo, in alcun modo
investito di significati che vadano oltre i confini della carne, morta,
corpo che ”è” nel momento stesso in cui non è più. Il tutto nel segno della
più ampia libertà di movenze, grazie all’assenza di una progettualità
iniziale e pure di un obiettivo. Tatiana Turanskyi, una delle registe
intervenute nel breve incontro al termine della proiezione esprime in
maniera chiara il metodo di lavoro utilizzato: “Crediamo nel potenziale
creativo della sperimentazione e dell’improvvisazione. Per girare
Petra abbiamo affittato un
appartamento per sei settimane, ci siamo chiuse dentro e abbiamo cominciato
a girare”.
Voto: 26/30
Bologna, 08:11:2004
SITO UFFICIALE |