RECENSIONE DVD ED EXTRA
LENINGRAD
COWBOYS GO AMERICA
di
Aki Kaurismaki
Finlandia 1989
Con Richard Boes e Duke Robillard
Quanto è cambiato Aki Kaurismaki. Fa un effetto strano rivedere oggi
Leningrad cowboys go America:
ci riporta al tempo in cui il regista finlandese in un qualche modo si
appagava del suo minimalismo, senza che, come avverrà nella sua fase
“matura”, questo minimalismo si lasciasse trasportare con naturalezza verso
cose immensamente più grandi di lui (la Provvidenza in
Nuvole in viagGIO, il cinema
in Juha, la memoria/oblio
come fondamento dell'essere in
L'uomo senza passato, gli intrecci tragici tra Potere e Desiderio
nell'ultimo Luci nel crepuscolo).
Leningrad cowboys go America
fa dunque parte di questa fase forse acerba ma godibilissima in cui il
linguaggio visivo striminzito fino all'osso di Kaurismaki serve pressoché
esclusivamente ad inanellare una serie di gag (e la gag è una delle
“frontiere” più tipiche a cui si rivolge il linguaggio una volta stirato
verso il proprio limite). La trama è un pretesto (un ingessato gruppo delle
steppe sovietiche va in America per fare fortuna, e finisce a suonare ai
matrimoni in Messico), quello che conta è lo svagato, spensierato
susseguirsi di gag, numeri musicali e (notevoli) parentesi contemplative
sull zone più “off” del paesaggio americano. Insomma, un occhio fotografico
non da poco si accompagna alla capacità di sapersi accontentare (con
superiore padronanza, peraltro)dell'ABC del cinema senza tanti fronzoli –
anche se poi fa capolino qualcosa di più: il personaggio dell'avido (anche
se in fondo bonaccione) manager dei Leningrad Cowboys lascia trapelare le
dinamiche dello sfruttamento economico, la cui visualizzazione nel cinema di
Kaurismaki è sempre lo scheletro da cui deve prendere le mosse tutto ciò che
valga la pena da essere filmato; una sorta di dato materiale di base la cui
evidenza lo rende obbligatoriamente il punto di partenza fondamentale del
filmabile.
Come il suo gruppo rifà il rock & roll con tutto lo straniamento apportato
dai loro bizzarri costumi (scarpe a punta e ciuffo chilometrico) e dalla
“nordicità” del loro pallore e della loro rigidità, Kaurismaki “rifà” Jim
Jarmusch (che compare in un cameo) confezionando (sul suo stesso terreno) un
calco del suo minimalismo discostandosene per maggior freddezza. Un road
movie atipico, scandito da continue didascalie, che pascola tranquillo
nell'orizzontalità e si infischia delle verticalità narrative, e che mette
tranquillamente sullo stesso piano metropoli come New Orleans e il più
sperduto paesino del Sud: d'altra parte, il cuore del meccanismo messo in
atto è proprio far scontrare l'essenzialità (del linguaggio) con la
stralunata estemporaneità degli alleggerimenti umoristici.
www.emik.it
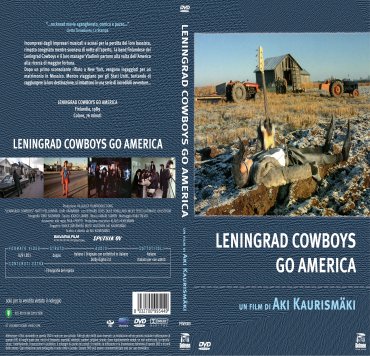
![]()